Tagli alla cooperazione
Takunda, il primo bimbo nato sano da madre con Hiv. Una storia che rischiamo di non vedere più
In Zimbabwe Takunda è stato il primo bambino nato sano da madre sieropositiva e trattato con un farmaco antiretrovirale grazie a un progetto sviluppato da Fondazione Cesvi. «Sono grato che mia madre abbia potuto prendere parte a quella iniziativa». Ma ora con i tagli alla cooperazione allo sviluppo molti programmi di cura e prevenzione sono già stati chiusi: «Questo preoccupa la popolazione»
di Anna Spena

Takunda il 9 maggio compirà 24 anni. Studia scienze sociali ad Harare, la capitale dello Zimbabwe. «Voglio diventare un assistente sociale», racconta. Della sua famiglia dice che è «molto piccola. Siamo solo io, mia madre e mia sorella, che frequenta la prima media». Nella lingua Shona, la più parlata nel Paese, il suo nome “Takunda” significa “Abbiamo vinto”. E sua madre Safine quel nome l’ha scelto per una ragione precisa. Takunda è il primo bambino nel Paese nato sano da madre sieropositiva.
La sperimentazione
All’inizio degli anni 2000 l’Aids a livello globale uccideva 4.300 persone ogni giorno. A Centenary, distretto nel nord dello Zimbabwe, dove si trovava l’Ospedale Saint Albert, una donna su tre era sieropositiva. È in quell’ospedale che Fondazione Cesvi inaugura una sperimentazione farmacologica per bloccare la trasmissione del virus da mamma a figlio durante il parto. È in quell’ospedale che nasce Takunda. «All’inizio degli anni Duemila nel Paese lo scenario era apocalittico», ha raccontato in questa intervista “Io, cooperante cuore e testa” Maurizio Carrara, presidente onorario di Cesvi. «Attraverso la pediatra Claudia Gandolfi veniamo a conoscenza di un protocollo per evitare che una donna in gravidanza passasse il virus al suo bambino: bastava che la madre assumesse un farmaco prima del parto e che quel farmaco fosse assunto anche dal neonato entro le prime 72 ore di vita. Ma a produrre questa pillola, la Nevirapina, era solo una casa farmaceutica. Individuammo un piccolo ospedale a 300 chilometri da Harare, il Saint Albert, gestito dalla suora laica Elisabeth Tarira. Dovevamo convincere le donne incinte e sieropositive a venire in ospedale e sottoporsi alla profilassi. E non era una cosa semplice, c’era uno stigma culturale pesantissimo». Com’è raccontato nel libro “40 – i nostri anni di solidarietà” , al Saint Albert si presentò Safina. Una giovane donna di 23 anni. Il suo primo figlio era morto di Aids e lei, consapevole della sua sieropositività, era arrivata incinta, abbandonata dal marito, con la speranza di salvare il suo secondo figlio. «Sono molto grato a mia madre per quella scelta», racconta Takunda. «Sono contento che abbia avuto il coraggio di partecipare a quel progetto». Oggi con i tagli alla cooperazione c’è «una preoccupazione che si diffonde nella popolazione africana. Però dobbiamo anche dire che le comunità sono state istruite e sensibilizzate. La cooperazione ha fatto un grande lavoro in questa direzione. Oggi le persone sanno cosa può causare l’Aids e come prevenirlo».
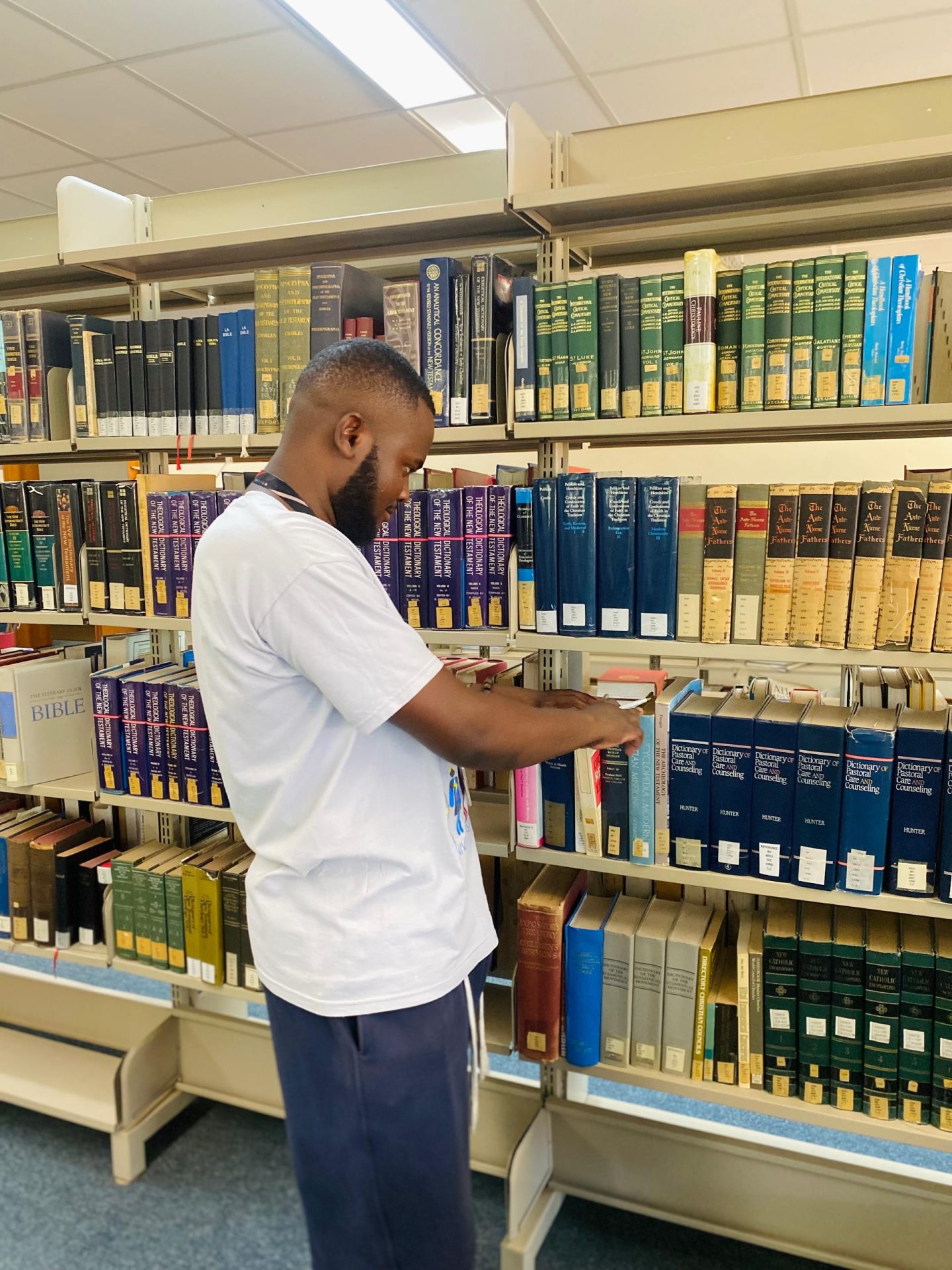
Il punto di svolta
Takunda ha già «svolto un tirocinio presso la Casa del Sorriso di Harare e in quella di Chiredzi, supportate da fondazione Cesvi». E quando oggi pensa al futuro «proprio come il mio nome», dice, «desidero davvero continuare a migliorare e a studiare». La nascita di Takunda è stata un punto di svolta. Dopo di lui, molti altri bambini nacquero sani all’ospedale Saint Albert, grazie alla profilassi anti-Hiv. E tutta la sua vita, tutta la sua storia, sono la prova tangibile che la cooperazione internazionale è un bene preziosissimo da tutelare, non da distruggere. E invece dallo scorso febbraio il settore vive con il fiato sospeso e un’ombra sul futuro. La decisione del presidente americano Donald Trump, prima di congelare per 90 giorni i fondi per i progetti già contrattualizzati dall’Agenzia degli Stati Uniti per lo sviluppo internazionale (Usaid), per poi procedere con lo smantellamento della stessa, è un attentato alla vita di milioni di persone. L’ente — fino ad oggi — ha finanziato il 40% della cooperazione internazionale mondiale, nel 2025 i fondi previsti ammontavano a 40 miliardi di dollari. Nessuna realtà ne uscirà illesa e le conseguenze drammatiche di queste scelte sono già diventate concrete.
In Zimbabwe, per esempio, sono già stati tagliati progetti dal valore di 522 milioni di dollari, tra questi molti di carattere sanitario. Questa cifra riguarda solo i progetti finanziati direttamente da Usaid. Ma l’Agenzia ha anche supportato il Global Fund, che – fino ad oggi – ha fornito la maggior parte degli aiuti per gli interventi in Zimbabwe contro l’Hiv, la tubercolosi e la malaria. Nel 2022, in Zimbabwe, 1,3 milioni di persone convivevano con l’Hiv. Di queste, il 95% conosceva il proprio stato sierologico e riceveva una terapia antiretrovirale. Terapia che ha portato alla soppressione della carica virale nel 95% dei casi trattati. Inoltre, si è registrata una significativa diminuzione (78%) delle nuove infezioni da Hiv tra il 2010 e il 2022. Cosa succederà ora che i progetti sono stati tagliati? Oggi perdiamo tutti.
Effetto boomerang
In Zimbabwe Cesvi non ha più progetti sanitari: «Siamo intervenuti nei primissimi anni Duemila nel pieno dell’epidemia di Hiv quando il grosso problema era quello di far nascere bambini sani da madri sieropositive», racconta Roberto Vignola, vicedirettore generale di Cesvi. «Allora i dati erano allarmanti perché almeno il 50% dei bambini nati da madre sieropositiva risultavano positivi al virus. L’introduzione di questo protocollo da parte dell’organizzazione è stato una vera attività di capacitazione, di trasferimento di conoscenze ad un Paese che non aveva esperienza in merito. Il protocollo è stato perfezionato negli anni al punto da portare l’infettività della trasmissione del virus da mamma a bambino, allo 0,1%». Se non ci fossero state organizzazioni, finanziate sia da fondi pubblici che privati, che hanno lavorato per costruire competenze locali, formare e trasferire conoscenze, probabilmente il virus non sarebbe stato fermato. «È importante sottolineare», continua Vignola, «che grazie a questi sforzi, nel 2015, il governo del Paese era pronto a gestire il progetto in modo indipendente. Negli stessi anni in cui è nato Takunda, sempre in Zimbabwe, abbiamo aperto una Casa del Sorriso per accogliere gli orfani di vittime dell’Aids. Tutte persone che non avevano accesso ai farmaci antiretrovirali. Poi le nostre Case Sorriso sono rimaste nel Paese, ma per rispondere ai bisogni di altri bambini. Quella fase emergenziale legata all’Aids era finita. Ma oggi il taglio dei fondi alla cooperazione può far crollare il livello di accesso minimo al sistema sanitario. Ciò che rischiamo è un effetto boomerang che potrebbe vanificare anni di lotte in molti settori della sanità, in particolare quello dell’Hiv. Questo potrebbe portare ad un aumento della circolazione del virus non solo in Zimbabwe, o in Africa, ma a livello globale».
17 centesimi al giorno sono troppi?
Poco più di un euro a settimana, un caffè al bar o forse meno. 60 euro l’anno per tutti i contenuti di VITA, gli articoli online senza pubblicità, i magazine, le newsletter, i podcast, le infografiche e i libri digitali. Ma soprattutto per aiutarci a raccontare il sociale con sempre maggiore forza e incisività.
