La neuroscienziata, che è partita per Boston oltre vent’anni fa, durante il dottorato, con una borsa di studio di due anni, non ha più lasciato gli Stati Uniti se non per alcuni anni, in cui ha lavorato presso la sede dell’IIT di Rovereto e dove collabora tuttora. Alle ragazze dice: «La ricerca è il lavoro più bello che esista e vi insegna a ragionare sulle cose del mondo» ma aggiunge: «Pianificate un periodo all’estero, potrebbe cambiarvi la vita».
Lei studia la percezione, in particolare visiva, ricorrendo alle più moderne tecniche di neurostimolazione. Sono lavori dalle importanti ricadute cliniche. Di cosa si tratta?
Studio il funzionamento di certi meccanismi cerebrali, per capire che cosa succede quando sono interrotti e danneggiati a causa di una lesione corticale che può essere causata da un ictus o da un’emorragia cerebrale. Che ne è dell’informazione visiva da quando raggiunge la retina, quali sono gli stadi della sua elaborazione e come viene interpretata dal cervello? E, ancora, come si diventa consapevoli di quanto si osserva e cosa succede quando una lesione impedisce tutto ciò? Attraverso le metodiche di stimolazione cerebrale noninvasiva, che interferiscono con l’attività elettrica del cervello, possiamo inibire certe aree, il cui silenziamento simula delle lesioni temporanee, e possiamo quindi studiare le dinamiche neurali, individuando le regioni necessarie alla funzione visiva e stabilendo relazioni causali e non semplici associazioni.
Spesso si lamenta la scarsa comprensione dei meccanismi che sono alla base dell’efficacia delle metodiche di modulazione dell’attività elettrica del cervello. Proprio per studiare i processi biologici sottostanti lei ha ricevuto un importante grant. A che punto siamo?
Siamo agli inizi. La comprensione anche a livello molecolare ci aiuta a intervenire in modo personalizzato. Nel nostro studio, lavoriamo con pazienti affetti da cecità corticale parziale, caratterizzata dalla presenza di aree cieche nel campo visivo, causate da lesione alle aree corticali visive. Utilizziamo una tecnica di stimolazione corticale non invasiva che ci permette di modulare e aumentare l’eccitabilità corticale, meccanismo necessario per promuovere il recupero della funzionalità corticale delle aree cerebrali lesionate dall’ictus e, di conseguenza, favorire il recupero della visione nelle aree cieche. Arruoliamo pazienti volontari in un trial clinico che dura quattro settimane e poi li richiamiamo dopo tre mesi per studiare la possibile persistenza del miglioramento. Ma andiamo oltre, e infatti una parte di questa ricerca è svolta in collaborazione con una collega neuroscienziata, Chinfei Chen del Children’s Hospital di Boston, che sta studiando a livello molecolare negli animali gli stessi meccanismi biologici di recupero della visione dopo lesione.
Qui, riabilitazione e prevenzione si intrecciano. Lei studia queste tecniche di neurostimolazione anche nei sani, quindi non solo in un’ottica di recupero delle funzioni. Sollecitando le funzioni cognitive, è possibile rallentarne il fisiologico decadimento dovuto all’età e preservare così capacità cruciali all’autonomia e all’indipendenza?
Capire in che misura queste metodiche supportino il mantenimento della cosiddetta riserva cognitiva, che inizia a ridursi piuttosto presto e ha un ruolo protettivo verso le malattie neurodegenerative, è importante nelle nostre società che invecchiano. È una delle frontiere della ricerca neuroscientifica, ma abbiamo già i primi risultati dai nostri studi dove reclutiamo soggetti sani per capire quali siano i protocolli migliori per potenziare l’attenzione nell’adulto e nell’anziano. Ad esempio, abbiamo dimostrato che con la stimolazione corticale a correnti dirette, totalmente sicura e indolore, è possibile estendere il funzionamento ottimale dell’attenzione sostenuta, facendola passare da 45 a 90 minuti. Questo protocollo di stimolazione sperimentale non è l’unico e l’idea è proprio quella di poter disegnare dei protocolli applicabili anche ai soggetti sani per aiutare a mantenere un funzionamento cognitivo ottimale anche in età adulta e negli anziani.
Dalla riabilitazione, al mantenimento finanche al potenziamento. Lei crede che ci sia un dibattito pubblico sufficiente da dissipare ingiustificate paure e fornire a tutti gli strumenti per farsi un’idea?
Sicuramente, negli ultimi anni c’è stato un aumentato impegno nella comunicazione scientifica, in parte anche in Italia, ma sicuramente negli Stati Uniti. Qui, a Boston, la scienza è veramente attivissima, è considerata centrale e vengono organizzati numerosi eventi per coinvolgere il pubblico nella ricerca e favorire l’apprezzamento per i suoi traguardi. Proprio ieri il New York Times (e ripresa anche da testate italiane) ha raccontato la storia di un ragazzino sordo dalla nascita per un disturbo genetico dell’udito e tornato a sentire grazie all’editing genetico, un risultato delle neuroscienze e biologia molecolare con ricadute straordinarie. Sono molte le entusiasmanti e stupefacenti scoperte che possono migliorare la qualità della vita e altre sono in arrivo, anche nel complesso ambito delle malattie neurodegenerative.
Qui la scienza è considerata centrale, ci sono numerosi eventi per coinvolgere il pubblico nella ricerca e favorire l’apprezzamento per i suoi traguardi
Come si è avvicinata alla psicologia sperimentale?
La mia passione per la ricerca ovviamente è nata molto tempo fa, all’Università di Padova, quando ho cominciato a studiare neuropsicologia. Ricordo ancora le lezioni di Carlo Semenza e gli studi di Clara Casco, per me un modello importante di donna scienziata, con la quale mi sono avvicinata alla visione. Mi incuriosiva il concetto di causalità e gli effetti delle lesioni su cognizione e comportamento, anche per capire in che modo intervenire per favorire il recupero dei pazienti con deficit. Dopo la laurea, ho vinto una borsa di studio dell’Università di Padova per trascorrere un periodo di studio all’Università di Birmingham dal professor Glyn Humphreys, uno dei maggiori studiosi di pazienti con lesioni cerebrali. Successivamente ho iniziato a collaborare con Vincent Walsh della University College of London, tra i primi a esplorare l’uso della stimolazione corticale non invasiva.
I molti bias che pesano sulle donne «rappresentano un grave ostacolo al raggiungimento dell’uguaglianza di genere e all’emancipazione di tutte le donne e ragazze» afferma l’Onu, i cui dati indicano che i pregiudizi sono diffusissimi e riguardano nove individui su dieci, di entrambi i sessi. Come le neuroscienze e le scienze cognitive hanno contribuito alla diffusione stereotipi sulle donne e le loro capacità cognitive, giustificando lo status quo?
Le differenze volumetriche emerse dagli studi non sostengono l’esistenza di differenze nelle prestazioni cognitive. Ci sono variabilità individuali, esattamente come accade con la corporatura. Credo che i bias verso le donne siano da attribuire in massima parte ai fattori sociali e culturali, per menzionare l’annosa questione nature vs nurture, natura vs cultura. Le donne non hanno potuto partecipare all’impresa scientifica per via di secoli di esclusione e sottomissione, una discriminazione che ha perpetuato questa immagine della donna debole, meno portata e con meno capacità. Negli anni Sessanta, ad Harvard il 95% dei docenti erano uomini e le poche donne avevano un salario nettamente inferiore. Bisogna essere consapevoli di quanto è stato, conoscere la storia per fare qualcosa e cercare di proporre una soluzione. Per questo, suggerisco di leggere “The exceptions”, della giornalista del New York Times Kate Zernike. Oggi, qui ad Harvard, la situazione è cambiata. Proprio in questi giorni sono in corso i colloqui di ammissione ai dottorati e incontro moltissime ragazze. Solo per fare un esempio, alle selezioni per il dottorato in neurobiologia, mio marito [lo scienziato statunitense John Assad] ha fatto i colloqui con otto donne e un uomo. Ricordo che i candidati al dottorato sono persone già selezionatissime, quindi le ragazze sono pronte a mettersi in gioco e vengono selezionate.
Le donne non hanno potuto partecipare all’impresa scientifica per via di secoli di esclusione e sottomissione che hanno perpetuato false idee sulle loro capacità cognitive (bias)
Lei crede che le misure adottate finora per garantire l’equità di genere siano efficaci?
Rimane il grosso problema, che riguarda tutto il mondo del lavoro e non solo della ricerca, delle misure scarse o inesistenti per sostenere la lavoratrice. In accademia, le donne sono numerose all’inizio e le perdiamo per strada a partire dal momento in cui vogliono farsi una famiglia: è frustrante vedere delle eccellenti scienziate lasciare la ricerca. Bisognerebbe sempre considerare, nella valutazione del lavoro scientifico che viene fatto ai fini della progressione di carriera, l’interruzione o il rallentamento dovuti alla maternità. Il termine è stop the tenure clock, sospendere il conteggio e dare loro più tempo. Attualmente lavorano con me sei ricercatrici e un dottorando, ma nel passato mediamente ho avuto lo stesso numero di collaboratori e collaboratrici. Sento forte la responsabilità di supportare le mie ricercatrici e i giovani ricercatori in generale. Molto conta, infatti, l’ambiente che si crea all’interno del laboratorio e Harvard ad esempio organizza corsi di mentorship, una realtà non unica nel panorama di ricerca internazionale.
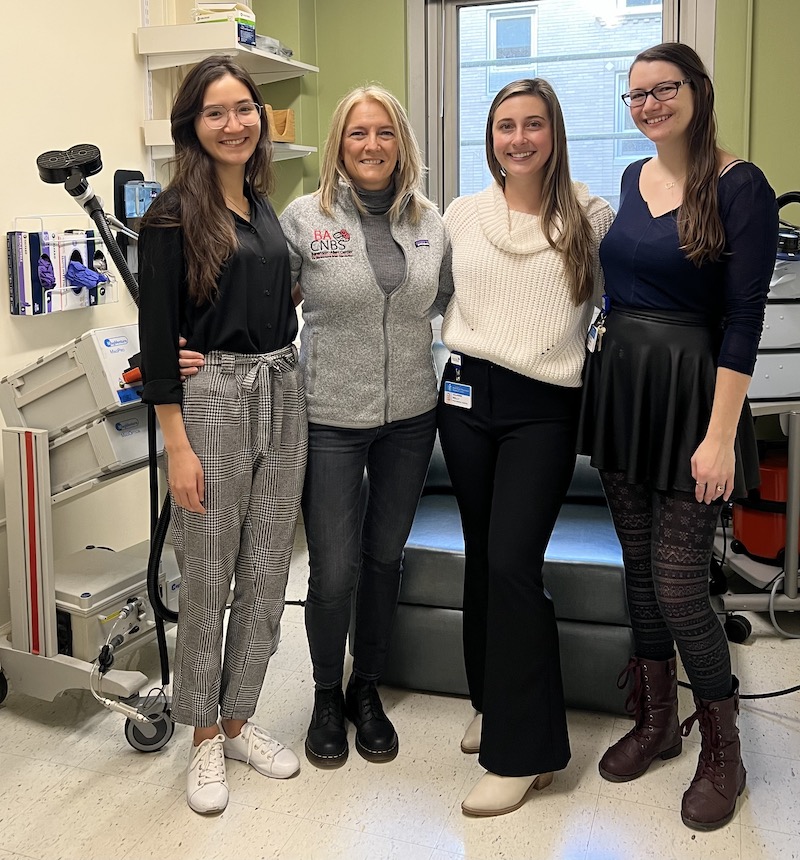
Anche in Italia si stanno diffondendo, insieme alle policy per la Diversity&Inclusion.
Sono sicuramente importanti per varie ragioni. Da un lato, ampliano lo sguardo dalla discriminazione verso il genere femminile a quella verso le minoranze e le diversità. Dall’altro, affrontano un tema rilevante per la ricerca, perché anche in una città multiculturale come Boston fatichiamo a reclutare persone di etnie diverse, nonostante la richiesta formale dell’NIH alla rappresentanza dei soggetti nei trial clinici.
Cosa direbbe alle ragazze interessate agli affascinanti temi di cui lei si occupa?
Quello che ho sempre cercato di far capire a mia figlia Elena, 23 anni, una laurea in biologia alla UCSD e in questo momento in volo verso Seattle per una selezione di dottorato alla University of Washington: è importante che siate soddisfatte di quello che fate e che studiate quello che vi appassiona. Infine, un messaggio di gratitudine agli insegnanti perché, è vero, io e John in casa abbiamo inevitabilmente parlato sempre di scienza, ma Elena si è innamorata della biologia grazie a una bravissima docente delle superiori. Lo stesso messaggio abbiamo trasmesso ai gemelli, Giovanni e Tommaso, che infatti studiano computer science e architettura.
Conosco le vostre difficoltà, conosco le statistiche e le diverse possibilità che avete. Ma studiate quello che vi appassiona. Vi meritate un futuro nella ricerca
E se dovesse rivolgersi alle ragazze italiane?
Conosco le loro difficoltà. Conosco le statistiche, che parlano chiaro, ma conosco anche i tentativi di carriera di molte giovani ricercatrici. So che spesso in Italia non conta solo il merito e che le ragazze non hanno sempre le stesse possibilità dei ragazzi. Per questo, ho un consiglio per loro: pianificate un periodo di ricerca all’estero per fare nuove esperienze, vivere in ambienti diversi e respirare un’aria nuova potrebbe cambiarvi la vita. Vedo chi arriva qui dall’Italia: sono molto preparate, fanno molto bene e sono sempre contente della loro scelta. È vero, potrebbero esserci delle difficoltà a reinserirsi nel caso si volesse tornare dopo qualche anno e una carriera avviata, ma non è impossibile, esistono dei meccanismi di fondi di ricerca per favorire il rientro. Non devono scoraggiarsi e non devono mai perdere la fiducia perché si meritano un futuro nella ricerca, che è il lavoro più bello del mondo e va al di là della passione che ciascuno di noi nutre per la sua disciplina. Al di là dell’enorme e indicibile soddisfazione che si prova quando un esperimento gira e restituisce le risposte cercate, c’è di più. La ricerca insegna a ragionare e a esercitare la consapevolezza, aiuta a comprendere molte cose del pensiero, del mondo interiore e della realtà che ci circonda.
Di seguito, le altre interviste:
Ragazze, inseguite i vostri sogni e avrete forza e leggerezza d’animo (Silvia Priori)
Ragazze, il futuro dipende da voi. Siate intraprendenti e autonome (Manuela Raimondi)
Basta con gli stereotipi. Ragazze, non rinunciate alla bellezza della matematica (Gligliola Staffilani)
Si può usare la Carta docente per abbonarsi a VITA?
Certo che sì! Basta emettere un buono sulla piattaforma del ministero del valore dell’abbonamento che si intende acquistare (1 anno carta + digital a 80€ o 1 anno digital a 60€) e inviarci il codice del buono a abbonamenti@vita.it

