Si fa presto a dire disabilità. Anzi no. Ci si inciampa, mossi spesso da buone intenzioni, per costruirci intorno una definizione che metta a posto la coscienza di chi disabile non è. Lo si fa per pudore, per incapacità, nella migliore delle ipotesi, per empatia. Ma alla base c’è sempre un disagio. Perché il disabile rimarca una differenza tra ciò che è apparentemente normale e ciò che non lo è. Hai voglia a dire che nessuno è normale, perché tutti siamo diversi e unici. Ci si sente, nella migliore delle ipotesi, umilmente empatici e spesso, così facendo si rischia di diventare patetici e finti. Sono riflessioni di chi con la disabilità ha avuto a che fare da quando era adolescente, per scelta, per i casi della vita. Chi è toccato dalla disabilità ha un percorso maledettamente più tortuoso, ma se, senza pietismi e scontate arrendevolezze, lo attraversa, riesce a darti una visione che sfronda molti livelli superficiali di lettura della realtà in cui viviamo. È il caso di Autilia Avagliano e della sua storia di madre di un figlio con un cromosoma in più, raccontata in un libro schietto, sincero, senza sconti, "Din Don Down" (Marlin editore).
Autilia, cominciamo subito con la domanda d’obbligo. Quando le è stato detto che il suo secondo figlio aveva la sindrome di Down qual è stata la sua prima reazione?
Come scrivo nel libro “Tirai un sospiro di sollievo: lo schizzo di vita era venuto al mondo e non se n'era andato sul nascere. E questo mi sembrò un dono enorme, una fortuna immensa. Portarmelo a casa…ci sarebbe stata una base sulla quale lavorare…avremmo vinto noi, non mi sarei arresa, il bimbo c'era e già questo era un miracolo. Ricambiai la stretta di mano, mi girai verso il dottore e chiesi garbatamente di portarmi in camera. Ed ebbe inizio, per noi, la notte più lunga del mondo”.

Ad un certo punto scrive una frase che ci ha colpito: “Sì, forse ho esagerato con la disabilità”. Cosa voleva dire?
Premesso che non si può generalizzare ed ogni disabilità ha il suo percorso, quando la disabilità ti sceglie rischia di assorbire quasi tutte le energie di cui disponi. All’inizio, quando è nato Alberto, le esigenze erano tantissime, prime sul piano della sua salute, poi sul piano assistenziale e burocratico, poi sul piano relazionale, sociale, scolastico. Devi diventare anche un “genitore competente” per rispondere al meglio delle tue possibilità ai tanti problemi ed esigenze che affiorano. Queste necessità mi hanno condotta ad avvicinarmi sempre più al mondo associativo, l’unico, soprattutto all’inizio, che mi sembrava adeguato a darci delle risposte soddisfacenti, anche per esperienze di tanti genitori che ci avevano preceduto. Piano piano, la competenza in materia si è fortificata e, quindi, anch’io ho sentito l’esigenza di restituire alla mia comunità di genitori un piccolo patrimonio di conoscenze utile per crescere meglio un bambino con disabilità.
Un passaggio dal piano personale a quello collettivo. Una condivisione a tutto campo, dal piano emozionale privato a quello sociale e di comunità?
È un passaggio che diventa abbastanza naturale e succede quindi di pensare continuamente in termini di diritti da tutelare e difendere, in termini di bisogni da appagare, di miglioramento della qualità di vita di persone fragili che non è detto che riguardino strettamente tuo figlio ma, pro tempore, devi ugualmente affrontarli perché utili alla comunità ed al bene di tutti. Tutto questo va fatto, ma anche in questo è necessario una misura, perché l’argomento è talmente pervasivo e coinvolgente che rischia di travolgerti e annientarti e questo, ho constatato, non giova a nessuno, neanche a tuo figlio.

Cito un altro passo del libro “Con il tempo la disabilità di Alberto è uscita fuori dalle anguste mura domestiche e, per me, è diventata una diversità universale, da esportare ovunque e far diventare patrimonio mondiale dell’umanità”. Ci spiega questo processo?
Faccio un esempio: quando diventi mamma, in fondo, diventi mamma anche degli altri figli che incontri sulla tua strada e cogli le analogie: uno sguardo, un pianto, un capriccio, ci sarà sempre qualcosa che ti rimanda al tuo bambino, per cui, in un attimo, cogli l'universalità della tua missione ed un'ingiustizia subìta da quel bambino la senti vibrare dentro di te, come se l'avessero inferta a tuo figlio. La disabilità di Alberto con il tempo è diventata un fatto meno privato e sempre più pubblico, per cui qualunque discriminazione subìta da un estraneo non è più altro da me e, lì davanti a me, sarebbe potuto esserci Alberto senza armi per difendersi e non importa che essa riguardi la disabilità o l'essere bianco o nero o gay o anziano, è il pregiudizio che va combattuto, ovunque si annidi, ovunque metta un essere vivente al di sopra o al di sotto di un altro essere vivente. Non puoi pretendere che gli altri accettino ed accolgano la tua diversità se tendi a mettere distanza e non capire una diversità distante dai tuoi parametri mentali e, quindi, finisci per condannare ciò che presumi di capire ma che in realtà non hai compreso.
“Incespichiamo ancora…soprattutto quando incontriamo la diversità non nei nostri occhi, ma in quelli di chi ci guarda”. Quanto sono cambiati gli sguardi degli altri in questi anni? E soprattutto il suo sguardo?
Se questa domanda fosse arrivata qualche anno fa, non avrei avuto dubbi: senza esitazioni avrei risposto che tanta strada è stata fatta, anche se ancora tanta se ne deve fare, ma che, tutto sommato, rispetto al passato sono stati fatti passi da giganti e la gente ha uno sguardo verso la disabilità più benevolo e solidale ed è più propensa ad accettare ed accogliere la diversità. Invece, purtroppo, il mio sguardo attuale è abbastanza disincantato perché a discapito di tante belle parole, di tanti convegni e studi, la discriminazione alberga in molte menti, è diventata più furba, meno esplicita, più ingannevole, che accontenta le apparenze ma dimentica la sostanza, molto social ma scarsamente sociale. Senza andare troppo lontano basta riflettere sull’operato di Trump, o osservare talune manovre politiche o osservare quanta poca cura e poco rispetto ci sia nell’uso e abuso di un linguaggio della disabilità improprio, inopportuno, spesso profondamente offensivo anche nel linguaggio di tutti i giorni, per strada, a scuola, sul lavoro, in TV: inaspettatamente veicolato e avallato dagli stessi media che, alle volte, “sportivamente” fanno finta di non sentire, sdoganando “il mongoloide di turno” in prima serata, senza scrupoli, con arroganza, ignorando totalmente espliciti inviti degli interessati ad un utilizzo corretto ed educato del linguaggio della disabilità.
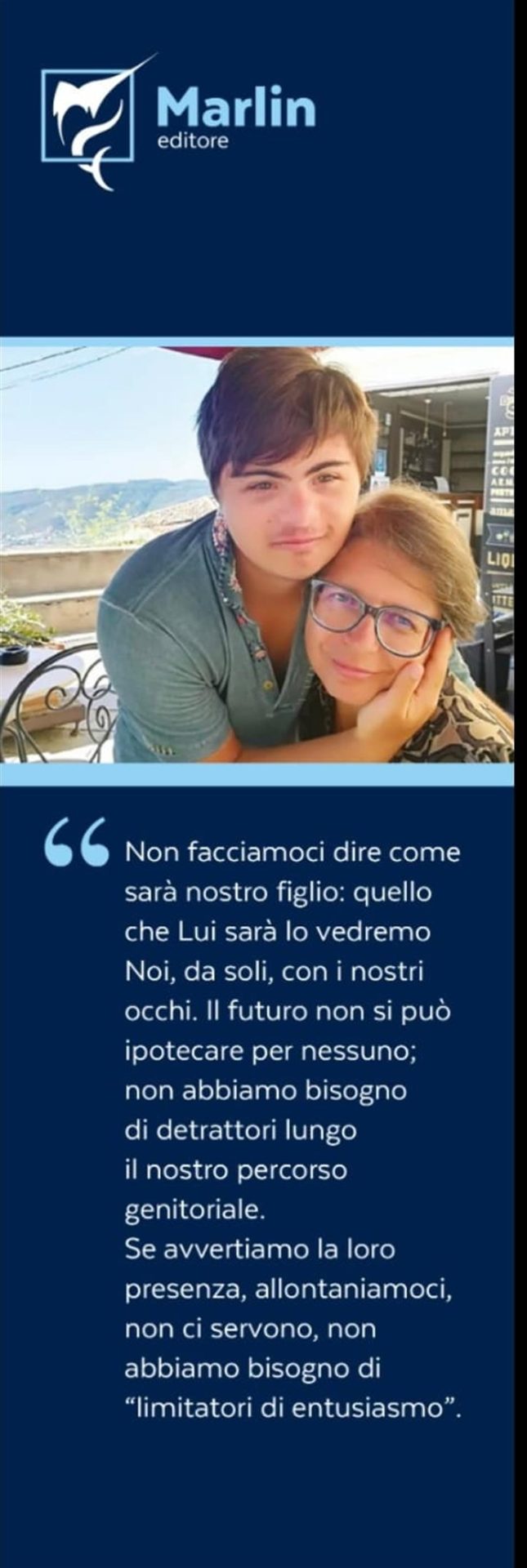
L’impegno civile è nelle sue corde. Assessore alle politiche sociali prima, attualmente presidente di APDD, Associazione Persone con sindrome di Down e Disabilità intellettiva di cui fa parte anche suo marito, che però, leggiamo nel libro, era critico. Perché?
C’è un passo del libro in cui lo spiego bene: “Per Paolo le Associazioni sono ghettizzanti, sono, più o meno, il luogo dove ci si autocelebra, dove l’unisono degli intenti annebbia l’obiettività delle situazioni reali, il luogo dove si finisce per dire le stesse cose e autoconvincersi di stare nel giusto. Il luogo dove la concentrazione di disabilità, così palese, rafforza e alimenta il concetto stesso di disabilità, a discapito di una distribuzione della stessa in mezzo alla gente, in tutti i contesti, come un fatto naturale, senza darle troppa importanza. Quando parliamo di queste cose, mi rendo conto che lui è “oltre” e lo invidio un po', perché riesce ad incarnare il visionario che è in me che però io non so scorgere nel nostro quotidiano”. Il pensiero di mio marito inconfessato è: fino a quando sarà necessario fare associazionismo per difendere diritti che non dovrebbero essere violati e messi in discussione, saremo ancora lontani da una vera inclusione delle persone con disabilità nella società di tutti. Tutto questo sul piano teorico ma, praticamente, lui con me e tanti altri genitori di Cava de’ Tirreni, in provincia di Salerno, abbiamo poi fondato l’associazione. Perché nei fatti, al di là delle parole e di quello che ci piacerebbe capitasse nella realtà – ossia un mondo dove non vengono violati i diritti dei più fragili – l’associazionismo serve e serve tantissimo per fare cultura della diversità, contro l’ovvio abilismo dilagante, per tutelare diritti, per difendere quanto di buono già realizzato, per creare opportunità concrete di inclusione sociale, scolastica e lavorativa, per accelerare i tempi del durante e dopo di noi, perché quando sei genitore di un figlio con disabilità hai una percezione del tempo diversa e sei consapevole, forse più degli altri, che non hai tanto tempo a disposizione per proteggere il tuo “tallone di Achille”, soprattutto quando non ci sarai più.
Due mondi si incontrano: la normalità e la disabilità. Lei, molto acutamente, parla del pregiudizio che, ovviamente, colpisce entrambi i mondi. Un pregiudizio che lascia ognuno nel proprio castello di preconcetti. Come ha lavorato per superarlo?
Faccio una premessa: penso profondamento che dal di dentro nessuno è normale. Ma cosa intendiamo per "normale"? Normale è chi si alza la mattina, va a lavorare, poi torna, cena e va a dormire? Allora un artista che si esibisce di sera e va a letto all'alba non è normale? La normalità è relativa e soggettiva anzi a dirla tutta, è la diversità che è normale, dal momento che è risaputo e scientificamente provato che non esistono al mondo due esseri perfettamente uguali e se pure esistessero dovremmo studiare la loro reazione di fronte ad un medesimo accadimento. Detto ciò il primo lavoro è su se stessi: non posso pretendere l'abbattimento di barriere mentali negli altri se non applico la stessa ruspa a miei muri mentali. Peraltro, non si è mai liberi dal pregiudizio, perché la stima naturale che abbiamo per noi stessi ci porta a considerare al centro la nostra verità. Fatto e tenuto in allenamento questo esercizio mentale, questo sgrossare continuamente il proprio sguardo, il tentativo è lavorare sul piano culturale, come stiamo facendo ora, stare in prima linea per la difesa dei diritti, rendersi accessibili, spiegare, confrontarsi, non cedere il passo all'inerzia o alla rassegnazione o pensare che le cose non cambiano né cambieranno.
Altro punto nevralgico che spiega bene nel libro: l’argomento disabilità, ho imparato, è uno di quei temi che incarna meglio il “guardare ma non vedere”. La disabilità commuove, rende solidali, fa smuovere improvvise montagne, fa scendere i sovrani dal trono per abbassarsi e vedere quanto sia vera e commovente. Insomma, parla dei “solidali per eccellenza”. Come se ne esce?
Quando ero più giovane avevo la pretesa o la presunzione di pensare che combattendo potevo cambiare le cose. Oggi ho un atteggiamento meno sfidante ma forse più proficuo. Chi per vent'anni consecutivi ha comprato l'azalea e pensa di aver assolto il suo debito di riconoscenza verso la vita, è un po’ difficile che si convinca che quella sia una solidarietà un po' miope…La mia è solo una presa di coscienza: il problema principale è di chi lo vive sulla sua pelle, ogni giorno, senza tregua. Però, con molta umiltà, non avendo la pretesa di cambiare il mondo, è necessario accettare ed essere grati a tutti perché anche l’acquisto di una pianta può dare la misura di un gesto autentico e proporzionato alle forze e alle motivazioni di chi lo compie.
Le parole sono importanti. Forte della sua esperienza quali sono le parole giuste, equilibrate, da usare?
Guardi, non è difficile, se si riferisce al linguaggio della disabilità, non è necessario andare troppo lontano, basta sfogliare la “Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità” per accorgersi che è meglio dire “persona con sindrome di Down” piuttosto che persona Down, è una sottigliezza semantica ma non è difficile da percepire: io sono Maria, Anna, Claudio o Francesca ma non sono Down, ho la sindrome di Down che mi caratterizza ma non mi identifica, perché resto Maria, Anna etc, etc. È così difficile? Ad esempio si sente ancora “affetto da sindrome di Down” come se fosse una malattia e non una condizione genetica. Per non parlare del tono impietoso ed offensivo che ogni tanto catturi: “ma che sei Down?” o “non fare il Down…!”, sottolineando un malcelato abilismo che puntualmente spunta dal cilindro. Ma, come ho già detto, c’è anche il “delizioso” “mongoloide” che sistematicamente rimbalza agli onori delle cronache in qualche programma televisivo o anche semplicemente a scuola, in autobus, al supermercato…e mai una condanna sociale definitiva e totale che metta al bando queste espressioni!!! Diamine, anche Giobbe si sarebbe scocciato!
Chiaro di Luna, siparietto dell'attore d'Arte Tempra", realizzato dal Laboratorio Teatrale Arte Tempra durante il periodo del lockdown. Si ringraziano Clara Santacroce e Renata Fusco per la gentile concessione alla riproduzione
Una parola anche per il suo primo figlio, Mario. Ci sono pagine molto belle del rapporto che ha con suo fratello Alberto. Quanto sono di stimolo l’uno per l’altro?
Da piccolini, quando Albero faceva ore di terapia riabilitativa e logopedica, scherzando con mio marito, usavamo dire che il vero fisioterapista e logopedista di Alberto era suo fratello maggiore. Mario è stato il benchmarking per tutta l’infanzia del fratello e non escludo che lo sia ancora, il fratello da imitare, da raggiungere e superare, la calamita umana da emulare e superare, se possibile. E questo innegabilmente è stato uno sprone costante per le sue abilità. Al contrario, per Mario penso e spero che il fratello gli dia la dimensione reale e umana della vita, sempre, ovunque egli sia. Adesso però è troppo presto e forse entrambi sono troppo giovani per riconoscersi e riconoscere il senso profondo di certi valori.
C’è una frase che arriva dritta al cuore “E io lì, che mi ripeto la stessa domanda e che, prima o poi, girerò a lui: Come mai avrei potuto decidere, di non averti?”. Cosa si risponde?
Non mi so immaginare un altro Alberto, un altro Mario. Più passa il tempo e più si staccano da noi e loro somigliano sempre di più a loro stessi ed il loro posto nel mondo mi sembra sempre più definito: “fiume in piena, Vita in piena, alla quale noi diamo solo il “La” per cominciare…la possibilità dell’essere e del fare per un altro da te, come sempre dovrebbe essere!”
Chiude il suo libro raccontando una storia che risale a tanti anni fa. Può dirci, senza svelare troppo cosa le ha lasciato in eredità?
Tutto! La partenza è lì, posta alla fine del libro, il libro potrebbe essere anche letto al contrario, partendo da quella storia nella storia, l’avvio umano, almeno per me, è lì, poi… poi al lettore l’ardua sentenza.
Nessuno ti regala niente, noi sì
Hai letto questo articolo liberamente, senza essere bloccato dopo le prime righe. Ti è piaciuto? L’hai trovato interessante e utile? Gli articoli online di VITA sono in larga parte accessibili gratuitamente. Ci teniamo sia così per sempre, perché l’informazione è un diritto di tutti. E possiamo farlo grazie al supporto di chi si abbona.

