
Melinda ha un ristorante e i suoi clienti lasciano pita e tzatziki pagati per i migranti. Samira vive nel prefabbricato numero 28, dentro al campo di Kara Tepe, ha un tumore e non può allattare la sua bambina di nove mesi. Isabel è messicana, sa arrampicare sulla roccia e pulisce gli scogli dai giubbotti salvagente e dalle carcasse dei gommoni. Claudia è una ventenne tedesca che manda email ai suoi genitori spiegando che si fermerà per altre settimane. Non riceve risposta: forse sono arrabbiati – ci spiega sorridendo.

Isabel
Sono quattro delle decine di donne che s'incontrano sull'isola greca di Lesbo, nel Mar Egeo e a due tiri di schioppo dalla costa turca di Ayvalik e Dikili. Da due anni, questa porzione di terra di 1.600 chilometri quadrati è diventato l'epicentro della crisi di migranti e rifugiati alle porte dell'Europa. Siriani, afghani, pakistani, iracheni, libanesi in fuga da guerre e persecuzioni che bussano in continuazione. Nel solo 2015 sono approdate a Lesbo mezzo milione di persone, circa sei volte tanto la popolazione locale.
L'isola è diventata anche una palestra per ong, preti, giornalisti, medici e semplici volontari. Fra questi la presenza femminile è corposa e basta fermarsi ad ascoltare qualche minuto che ci si imbatte in una una sorta di “Antologia di Spoon River” in rosa.
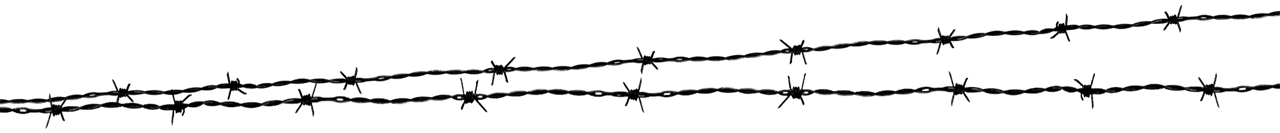

Come Melinda McRostie, australiana di nascita, greca d'adozione, portata sull'isola dalla madre all'età di tre anni. Un donnone tutto di un pezzo con la passione per la cucina, tanto da creare il Captain's Table Restaurant – la Tavola del Capitano – sin dal nome il più classico fra i ristoranti da porto, situato sul lungomare di Mólivos – cittadina a nord dell'isola, famosa perché nelle vicinanze si trova la “Montagna di Efthalou”: un'enorme discarica di giubbotti salvagente, abbandonati sulle coste dai migranti in fuga e accumulati in unico punto dalle ruspe, tanto da creare una piccola collina di gomma e plastica.
E al Captain's Table puoi pagare due volte: non perché il menù sia esoso o i camerieri distratti ma perché si può decidere di offrire un pasto a uno dei naufraghi di Lesbo. «Come si fa con il caffè a Napoli» ci scherza Melinda.
Oltre al Captain's Table, l'australiana ha fondato anche la Starfish Foundation, che si occupa di distribuire vestiti asciutti, cibo, cure mediche e semplici parole di conforto alle “carovane” di migranti che arrivano a Lesbo. A partire da quella prima sera nel novembre 2014. Cosa offrì quella notte ai naufraghi? «Tè. Tè freddo o almeno tiepido, perché non si possono dare bevande bollenti a chi arriva con i piedi e i polmoni congelati dal vento e dell'acqua. Si rischia di provocare altri danni». E le tazze di tè sono diventate centinaia fra l'estate e l'autunno del 2015, quando sulle spiagge arrivavano fino a 60 barconi al giorno in cui venivano stipate anche 70 persone a fronte di una capienza per 12.
Per quale ragione Melinda ha chiamato la ong “Starfish”? «C'è una storia che racconta di una ragazza – ci spiega – lei passava il suo tempo a gettare in mare tutte le stelle marine arenate sulla spiaggia per salvarle. Si avvicinò un uomo e le disse: «Tu hai una buona anima ragazza, ma non potrai mai salvarle tutte. Datti a qualche impiego più fruttuoso». La ragazza si alzò in piedi con una stella marina nel palmo della mano, guardò l'uomo e gli rispose: «Posso salvare questa. E la gettò in mare».
Ecco perché “Starfish”. È una leggenda? «No», si indispettisce, «è una storia», raccolta nel libro “The Star Thrower” dell'antropologo e filosofo americano Loren Eiseley, nel 1969.
Anche Samira è arrivata dal mare: cristiana-maronita in fuga da Tarabulus – la seconda città del Libano che si traduce con il nome di Tripoli, come la capitale libica – è approdata a Lesbo con le sue bambine e incinta di cinque mesi. Che sia cristiana lo si intuisce dai nomi che ha scelto per le figlie: una è Mariam, 4 anni, e l'altra è Marian, nove mesi. Samira ha un tumore alla laringe e ha fatto la chemioterapia in Libano. Ci mostra il foglio con l'intestazione di Save the Children dove si certifica che non può allattare. Nonostante ciò fuma tutto il giorno e prepara caffè solubile sul fornello a gas.
Ci fa accomodare nello “shelter” numero 28 dentro al campo di Kara Tepe, a poche centinaia di metri dal capoluogo Mytilene. Qui a Lesbo questo è considerato il campo profughi “accogliente” e “ospitale” contrapposto alla “prigione” di Moria: al centro di accoglienza di Kara Tepe accedono solo le famiglie, e i bambini hanno il campetto e le altalene per giocare.

Ogni giorno accorrono decine di volontari per intrattenerli: dai clown agli artisti pittorici. Come Andria, cipriota, e Daria, artista in erba italiana – entrambe studentesse all'Accademia di Belle Arti di Firenze. Andria prepara una tesi sui rifugiati; Daria è alla sua prima esperienza nel volontariato, lavora in un agriturismo nelle campagne di Lucca, adora Jackson Pollock e insegna ai ragazzini di Kara Tepe la pittura astratta su strada. «Prima di essere un campo di accoglienza era una pista per insegnare scuola-guida ai minorenni», quindi di strade da “imbrattare” con mani e colori ce ne sono parecchie, racconta Maria che lavora per la municipalità di Mytilene, dove abbiamo chiesto l'autorizzazione ad entrare. «Oggi qui vivono circa 900 persone».


Fra queste Amina e Taqwa, siriane di Aleppo. Sono arrivate in Grecia passando da Istanbul e Smirne il 18 marzo – due giorni prima della firma dell'accordo fra Unione Europea e Ankara – dopo i bombardamenti russi della scorsa estate che hanno liberato la città dallo Stato Islamico e, allo steso tempo, raso al suolo i palazzi. Amina ha perso il marito e lo racconta piangendo, scusandosi per le lacrime. Vorrebbe andare in Germania, «ma qualunque Paese in Europa va bene». Taqwa è una ragazza giovane con la sorella in Belgio. Ha studiato letteratura araba e inglese. Vuoi diventare un'insegnante? «Lo volevo prima di essere attorniata da bambini tutto il giorno in questo campo. Mi hanno fatto cambiare idea», scherza.


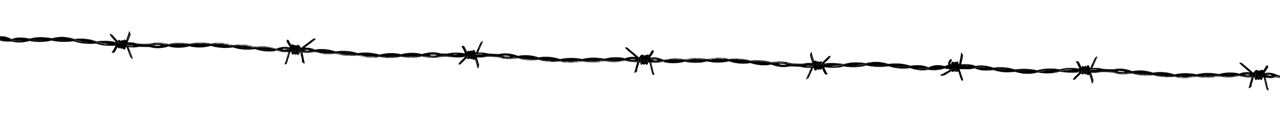
Ci sono anche mamme occidentali a Kara Tepe: come Saida, 28 anni, origine marocchina ma nazionalità olandese. È una madre single che è corsa a Lesbo, per qualche settimana, con l'organizzazione “Because We Carry” e ogni giorno alle 9 del mattino entra nel campo per la colazione. Assieme a lei le sue colleghe Chequita, Johanna – la leader del team no profit con tanto di furgone e targa olandese al seguito – e Ly, di origine vietnamita: 27 anni fa anche sua madre e suo fratello erano dei rifugiati. Sono soprannominate “The Banana Ladies” proprio perché distribuiscono frutta ai ragazzini. Ne hanno viziati alcuni che, infatti, corrono incontro ad ogni macchina che apre il portellone urlando “Banane!”. Se le banane non ci sono cominciano un'intensa trattativa per ottenre le patatine fritte vendute al chiosco del campo – detestano quelle in sacchetto, pretendono le “chips” fresche di friggitrice. La loro negoziazione si conclude quasi sempre con successo.
Isabel invece non cucina come Melinda, non compra patatine fritte e non prepara nemmeno il caffè come Samira – ma ha altre abilità. Prima di venire a Lesbo insegnava arrampicata sulla roccia e kayak ai bambini con disabilità motorie e autismo, a Londra. Lei è messicana, se ne è dovuta andare dal centro America dopo una laurea in scienze politiche e qualche attrito di troppo con i clan di narcotrafficanti. Lavorava per il governo. Ora sfrutta le sue abilità nel camminare sulla roccia per ripulire gli scogli dai salvagenti e dai gommoni abbandonati.

Lo fa assieme allo staff della LightHouse Relief, una ong svedese che si è creata un campo base e un ufficio sul lungomare di Skala Sykaminias, località nel nord dell'isola. La LightHouse svolge numerose attività di soccorso – incluso il ruolo di “guardiani del faro”, da cui deriva il nome e il simbolo della Ong – e azioni di stampo ecologico. Fra cui proprio la catena umana di persone che, lungo le spiagge, fanno passare di mano in mano ciò che resta di imbarcazioni e giubbotti per accumularli in un solo punto – dove alla fine interverrà una barca a ripulire il tutto. Isabel ha 38 anni e un fisico scolpito dalle attività sportive e dalla vita che pratica. Quando le chiediamo di posare per il ritratto fotografico protesta, si nasconde la faccia e prende in giro le modelle da copertina. Dopo un quarto d'ora di imbarazzi da parte sua finalmente si lascia fotografare. Ne viene fuori uno degli scatti più belli. Prima di salutarla le facciamo la domanda di rito: «Quando te ne torni a Londra?». «Quando le spiagge saranno pulite».










Se Isabel è il braccio della LightHouse, Claudia ne è la mente. Tedesca sin dal colore dei capelli, appena ventenne e studentessa ad Hannover in “Landscape, Ecology and Nature Protection”. Portata a Lesbo grazie a un annuncio sul gruppo facebook della ong svedese. È la donna più giovane della LightHouse ma è anche la coordinatrice del team, in barba a qualunque principio di anzianità. Lei è felice di trovarsi sull'isola, con pragmatismo protestante la definisce «una chance lavorativa» oltre che un'occasione per essere solidali. Un po' meno felici i suoi genitori che non hanno preso troppo bene la pausa di diverse settimane “congelando” l'università. Si fa più timida: «Ho mandato una mail giorni fa dicendo che mi sarei fermata fino a giugno ma non ricevo risposta. Temo che siano arrabbiati».
Ci sono anche donne misteriose e non tutte hanno un volto e un nome. Come le “Dirty Girls”. È questa la scritta che svetta su decine di cassonetti disseminati sull'isola per la raccolta di indumenti. Fondate da Alison Terry-Evans, una australiana ex organizzatrice di eventi a San Francisco, trasferitasi poi a Londra come street photographer. Negli ultimi nove mesi le “Dirty Girls” hanno lavato 140 tonnellate di vestiti, coperte e sacchi a pelo, coinvolgendo oltre 1000 volontari di 20 nazionalità diverse e procurando un vero e proprio mestiere a 12 fra gli abitanti di Lesbo. Vanno molto fiere di aver fatto risparmiare un milione di euro all'Unhcr con la loro attività. Annunciano l'apertura di due nuove lavanderie: una già attiva ad Atene e l'altra in fase di avvio a Salonicco, nell'entroterra greco e un'ora e mezza da quella Idomeni sgomberata a metà maggio. Sono misteriose perché di loro rimane soltanto una “caccia all'uomo” sull'isola, una conversazione telefonica e uno scambio di mail.



Ci sono altre donne che non hanno tutto il tempo per parlare. Solo un'istantanea rubata: Natasha, nella base centrale di Medici Senza Frontiere, a Mytilene; Sacha che gestisce i rapporti con i media per Save The Children da Atene; le ragazze della No Borders Kitchen, anarchiche, che girano per l'Europa con un van a cucinare nei punti nevralgici della crisi migratoria. Poche settimane fa hanno sgomberato il campo dove lavoravano. Giorgia, combattiva italiana con un master a Ginevra che è stata cinque mesi sull'isola per conto di Sea-Watch – l'Ong tedesca che si occupa di soccorso in mare. Il nostro primo contatto a Lesbo ma ripartita due giorni prima che arrivassimo. Anche perché dal 20 marzo di gommoni sulle coste non ne sono praticamente più approdati. Ora c'è bisogno di Sea-Watch nel Mediterraneo centrale e Giorgia, dopo una breve pausa fra la Sicilia e Roma, si è imbarcata a largo delle coste libiche.
E poi ci sono le ultime donne, quelle che tempo e voglia di parlare ne hanno da vendere, ma che non sanno farlo, almeno in inglese. Sono quasi-donne, bambine per la verità: Bayda, Tohama, Hala, Shaema, Malak – in cinque tutte imparentate fra loro, sorelle o cugine o cos'altro non si capisce. Ci scrivono i loro nomi in arabo su un foglio di carta. Gridano, fanno casino, si arrampicano su alberi o persone – poco importa – intrecciano braccialetti col del filo rosa e fucsia per regalarli a passanti e volontari. Quando alla sera lasciamo il campo di Kara Tepe, dicendo che ci saremmo rivisti il giorno dopo, loro severe ci apostrofano: «Tomorrow we Athena». Il giorno dopo torniamo e di navi per “Athena” non c'è traccia. Ma loro insistono: «Tomorrow we Athena».

Noi ragazze di Lesbo
Testi a cura di Francesco Floris
Immagini a cura di Francesco Brembati


Vuoi accedere all'archivio di VITA?
Con un abbonamento annuale potrai sfogliare più di 50 numeri del nostro magazine, da gennaio 2020 ad oggi: ogni numero una storia sempre attuale. Oltre a tutti i contenuti extra come le newsletter tematiche, i podcast, le infografiche e gli approfondimenti.



