Esperienza è una parola comune nella nostra comunicazione sociale. Ma è una parola a cui chiediamo troppo, o troppo poco. In un mondo che ha fatto dell’immediatezza, della rapidità irriflessa e dell’eccitazione infinita le sue parole chiave, sembra non manchino le occasioni per fare esperienza. Chiediamoci: è proprio così? Gli esseri umani, spiega Andrea Tagliapietra, filosofo e storico delle idee, autore del recente Esperienza. Filosofia e storia di un’idea (Raffaello Cortina editore,pagine 286, euro 16), «ma in generale tutti gli animali superiori non possono vivere senza fare esperienza. Anzi, direi che l’esperienza fa già parte – parte intrinseca, costitutiva – del rapporto delle singolarità con il mondo». Un dato elementare, ma non autoevidente. L’esperienza, osserva Tagliapietra, è un «capitarci che non ci aspettiamo». «Una forma che l’esserci singolare assume quando l’automatismo del nesso fra stimolo e risposta, che rapporta l’animale con l’ambiente, si sospende ed è possibile l’esitazione, il tempo e l’evento».
Il narcisismo dei consumi, la resistenza della singolarità
Nel suo lavoro lei parla di singolarità, non di individui o di soggetti. Che cosa intende con singolarità?
Le singolarità vanno distinte dagli individui e dai soggetti. Ognuno di noi è un individuo in quanto ha e vive una biografia e soggetto in quanto si identifica con le forme della figura teorica con cui la filosofia moderna ha pensato il conoscere e la sua articolazione con l’esistenza e, di qui, con il diritto, la politica, la morale, ecc.. Ma le configurazioni, i ruoli, anche eccezionali, che le individualità possono assumere in una biografia dipendono in larga misura dai valori e dalle strutture simboliche e istituzionali di una società e di una cultura. Gli individui, anche quelli che credono di essere più originali, sono riconducibili ad una combinazione di stereotipi. Nella società narcisistica dei consumi questo fenomeno appare piuttosto evidente, là dove ciascuno, per così dire, acquista e consuma la propria individualità come merce. Parimenti il soggetto non è differenziato, ma è una funzione formale, una figura filosofica che connette l’attività intellettuale e cognitiva con il suo fondamento empirico. Foucault, guardando all’operazione kantiana, aveva coniato il termine di allotropo empirico-trascendentale. Invece, le singolarità sono ciò che non possiamo non essere, perché siamo viventi e siamo situati in un corpo che sente piacere e dolore, in un ciascuno che è diverso per ognuno. È “il ciò a cui accade di”, il dativo e locativo singolare e plurale che si perde nelle generalità e nell’universalità del nominativo e dell’accusativo del soggetto e dell’oggetto. Partendo da questo, possiamo capire come il senso più proprio dell’esperienza sia la connessione tra eventi che possono accadere solo in rapporto a delle singolarità.
Tutta la grande tradizione intellettualistica occidentale – a partire dall’impresa della filosofia, per continuare con quella della scienza – per quanto la evochi, sembra agire in modo da allontanare, fino a rimuovere questa singolarità.
L’esperienza, anche quando viene evocata, alle soglie della modernità, contro il sapere autoritativo degli antichi, come fondamento della scienza moderna – si pensi al grande Galilei -, va comunque posta sotto la tutela dell’intelletto, ordinata “more geometrico” per cancellarne proprio l’imprevedibilità. È la scopa slegata dell’esperienza comune, che Bacone contrappone alla scopa utile ed efficiente dell’esperienza scientifica. Utile ed efficiente è l’esperienza quando è ripetibile, quindi quando viene neutralizzato il suo carattere di evento. Così il sapere scientifico dimentica il negativo che caratterizza l’esperienza – nessuna banca degli errori, nessuna rivista pubblica gli esperimenti falliti – e aspira, come metteva in guardia l’ultimo Feyerabend, all’ideale intellettualistico di una scienza senza esperienza. Di pari passo, l’ntellettualizzazione e l’anestesia dell’esperienza nella vita quotidiana, di cui già parlavano Simmel e Benjamin nella prima metà del Novecento, ha raggiunto quella compiutezza di cui parlava, quasi quarant’anni fa, Giorgio Agamben, in Infanzia e storia, che si apre con una lucida e perentoria affermazione: fa tante cose l’uomo contemporaneo, ma di una cosa può essere assolutamente certo, ossia che nessuna di queste si trasformerà in un’esperienza. L’esperienza diventa, allora, una cosa che non si può fare.
D’altronde, i neurologi stanno osservando che la nostra soglia di attenzione – condizione preliminare perché si abbia esperienza – si sta abbassando in maniera drastica. Ma davvero l’esperienza è finita? Davvero non possiamo più avere esperienza?
Io credo che dal punto di vista culturale, il dispositivo di pensiero costruito attorno alle tecnoscienze, anche in conseguenza della rivoluzione informatica e al loro capillare impiego nella vita quotidiana vada effettivamente in questa direzione: la progressiva distruzione dell’esperienza. Ma questo non significa che noi non facciamo esperienza. Significa semplicemente che la cultura in cui siamo immersi non la vede, non la valorizza e la esclude. Ma qui tornano in gioco le singolarità. Le singolarità sono quei punti di resistenza involontari, non mobilitabili, che consentono – e questo non succede agli individui che sono sempre il punto di partenza della mobilitazione – di resistere alla pressione degli apparati culturali e delle strutture sociali. Sono punti “naturculturali”, perché sono basati su noi stessi, sul nostro corpo e sulla nostra biologia, sulle differenze e sugli inevitabili deficit che essi comportano.
Il chè non è assolutamente qualcosa di negativo, di cui parlare sempre in maniera nostalgica, tradizionalistica e reazionaria…
Come parlarne, allora?
Direi che la biologia è, semplicemente, ciò che ci fa essere ciò che siamo, con tutti i nostri difetti e tutte le nostre défaillances: è una valorizzazione della nostra situazionalità, non – come nel caso dell’individuo e del soggetto – una statistica o una trascendentalità che portano a rimuovere culturalmente, nell’idealizzazione eroico-politica dell’individuo o nell’astrattezza formalistica della soggetto, le singolarità. Una rivalorizzazione dell’esperienza va in parallelo con la scoperta, la riscoperta o, comunque, con l’ammissione della singolarità.
Non si rischia di farla coincidere con la corporeità?
Singolarità non è corporeità soltanto, ma è l’intersezione fra la nostra corporeità e tutti i percorsi culturali, biografici, affettivi, logici che la accompagnano. Questo fa sì che è vero che ci sono strutture intellettuali e sociali che possono rendere stereotipati e, quindi, eterodiretti (pensiamo alla figura del “grande consumatore”) parte di quei percorsi, ma la singolarità è un punto di resistenza, perché è diversa, perché differisce, perché è segreta anche a se stessa. A differenza dell’io che cerca di comprendersi e a differenza dell’individuo che crede di fare ciò che fa perché lo vuole, ma poi si scopre eterodiretto, la singolarità costitutivamente non si può conoscere, ma solo sentire. E non la possono conoscere nemmeno gli altri. La singolarità è un punto opaco, un punto di resistenza. Si può rinunciare a tutto, ma non a questo punto cieco.

Un punto cieco che ci rende liberi
Per evocare questo punto cieco, nel suo libro lei ricorre all’aneddoto – ben noto, ma mai esaurito nelle sue possibilità di evocazione e indicazione – di Alessandro Magno e Diogene di Sinope: «spostati, mi copri il sole», avrebbe detto Diogene il cinico al giovane Alessandro, già allievo di Aristotele…
Il cinismo come filosofia senza teoria ci mostra un confronto dove possiamo, in maniera icastica e molto evidente, capire che cosa sia la singolarità. Abbiamo un confronto fra la nudità del filosofo, esposto al sole, e dall’altra parte l’uomo in cui si è concentrato il massimo potere del mondo antico. In questo confronto, la battuta di Diogene rammenta all’individuo Alessandro che ciò che gli è realmente proprio non è nulla di quello che lui fa o crede di aver fatto, ma è questo fondo che non è universale, ma comune. Il comune è un fondo di immanenza che abbiamo, appunto, in comune e che, a differenza dell’universalità, esalta le differenze, le fa essere, come il sole. Se l’esperienza viene ricondotta al tema della singolarità, allora questo ci spiega perché, nella storia della nostra cultura, l’esperienza è sempre una forma di rivendicazione di autonomia.
Ciò sembra non accadere nel pensiero antico, dove, se guardiamo ad Aristotele e Platone, l’esperienza non è connessa direttamente al sapere e la dimensione del sapere non si incrementa per esperienza – perché il sapere, divino e chiuso nella sua perfezione, non acquisisce ricchezza, ma solo dispersione e impoverimento, dalla singolarità. Tuttavia, se guardiamo alle filosofie come stili di vita e non come a teorie della conoscenza e del sapere – è ciò che distingue la filosofia antica dalla sua rinascita cartesiana e moderna -, allora la prospettiva si rovescia. Filosofia come scuola di vita, ovvero come esercizio di stilistica dell’esistenza – pensiamo all’insegnamento di Pierre Hadot e all’ultimo Foucault – che valorizza la singolarità, le fa spazio.
Nella modernità, però, il paradigma viene rovesciato. Pensiamo al pensiero sperimentale e ai prodromi di quello scientifico…
Parallelamente a questa inversione di paradigma, però vediamo, come dicevo prima, che proprio la singolarità è l’elemento su cui i teorici dell’empirismo, a partire da Bacone, si concentrano… per eliminarlo. La singolarità, per loro, non deve rientrare nell’esperienza, perché ne vanifica l’universalità, ma soprattutto perché non mette a riparo dall’evento, che è il vero nemico della strategia dell’intellettualismo, vuoi metafisica e ontologica, antica, vuoi scientifica e tecnica, moderna.
Scriveva Giorgio Caproni, in un suo componimento non a caso titolato Esperienza: «tutti i luoghi che ho visto / che ho visitato, / ora so – ne sono certo: / non ci sono mai stato». Caproni, in qualche modo, ci riporta a Walter Benjamin, che parla di distruzione dell’esperienza. Nel suo lavoro lei offre una lettura particolare di “Esperienza e povertà” di Benjamin…
Mi pare significativo, da un lato, il fatto che, come Benjamin stesso afferma, l’esperienza sia il tema della sua filosofia. Dall’altro lato, però, mi rifiuto di fare torto a Benjamin, interpretandolo come un filosofo sistematico. Nella sua opera, infatti, sono presenti varie accezioni dell’idea di esperienza e, tutto sommato, credo che quello che Benjamin costruisce alla fine sia un dispositivo complesso, in cui di fatto possono coesistere molteplici prospettive. Quella che mi sembra più interessante è la connessione tra l’esperienza e il narrare.

Tornando all’aneddoto di Diogene e Alessandro, Jean Genet, in un suo testo breve e folgorante, avanzava l’ipotesi che nulla di ciò che sappiamo, fra i due, fosse accaduto. Ma la narrazione fattane da Diogene, rovesciava il senso in direzione della singolarità, opponendosi alla prevaricazione, con un no inciso nella storia attraverso una critica…
Benjamin, con la sua operazione culturale, mostra infatti un tentativo – riuscito, a mio modo di vedere – di recuperare la narrazione in chiave critica. Questo non significa – cosa banale – che sussistano narrazioni, ma che esista un particolare meccanismo che, tramite la narrazione, produce un’altra esperienza, richiama l’esperienza nell’unico modo in grado di conservarla, quello di metterla in comune. Le esperienze sono sempre due: quella che tu hai fatto e quella che tu racconti, foss’anche solo a te stesso. Benjamin, non a caso, insiste molto su un certo “genere” di racconto, la storiella, la saga, il mito, la leggenda, l’epos, l’aneddoto…
Ma non il romanzo…
Benjamin insiste molto sull’esperienza come evento di senso che si produce nei lettori e negli ascoltatori di una storia e, quindi, insiste su un fuori delle cose, non su uno scavo all’interno dell’individualità. Insiste sulla terza persona, su quella che abbiamo chiamato singolarità. La narrazione fa cadere nell’esperienza e genera esperienza quando l’accesso non è immediato, ma laterale, obliquo. Quando il contenuto della narrazione non è posto sotto il controllo della prima persona, ma ci capita, ne siamo invischiati come la mosca nel miele. Al contrario, nella forma narrativa moderna per antonomasia, ossia il romanzo, Benjamin vede comunque, sempre, un germe di Bildungsroman, una formazione-interrogazione che accompagna gli individui, mentre nelle storie nelle novelle e nelle altre forme brevi del racconto – si pensi al magistero di Kafka – entrano in gioco le singolarità. La singolarità di chi ascolta, la singolarità di chi viene travolto dalla storia, la singolarità di chi, per primo, ha fatto esperienza. Nelle storie le singolarità risuonano e fanno esperienza. Ciò che si gioca nell’esperienza, non è un concetto fisicalista o paradossalmente “realista” di realtà. Ciò che è in gioco nell’esperienza, ciò che è reale nell’esperienza è il fatto di chiamarti in gioco. Il fatto che quel “a cui” capita di fare esperienza. Una delle cose che senza dubbio hanno a che fare con la miseria dell’esperienza e la perdita della capacità di farla, è l’intenzione, il fatto di voler fare esperienza. L’esperienza non è al nominativo, è sempre al dativo: “a me capita di fare esperienza”. Anche nelle storie e nel narrare accade questo. Sia chi ascolta una storia, sia chi la racconta fa esperienza al dativo. Non a caso, l’inizio dell’epos è sempre «Cantami o diva…», è sempre il poeta che già riceve il racconto, che parla perché ascolta, perché viene ispirato. Oggi, se vogliamo azzardare una provocazione, potremmo dire che in certa narrativa fantasy o di genere – da Harry Potter in giù – o, vuoi anche, in quel magnifico cinema non dal vero che è il cinema d’animazione, insomma i cartoni animati, ci sia molta più esperienza e molte più possibilità per farla di quante non ve ne siano in certe narrazioni realistiche che introiettano la cronaca. La fiction no fiction che mobilita gli individui, ma che li lascia, per l’appunto, nel ruolo degli spettatori, senza coinvolgerne intimamente le singolarità. Del resto, non è forse vero che si può sempre cenare tranquilli mentre sullo schermo scorrono gli orrori del telegiornale?
Il problema dell'attenzione
Da questo punto di vista, il consumo dell’esperienza è, anche, consumo di attenzione. Pensiamo ai fenomeni che qualcuno ha definito post-mediali (le serie tv) o all’autoesposizione dell’ego, oramai un ego crossmediale, su facebook o altri dispositivi…
Questi dispositivi sono vittima di un’intenzionalità che non restituisce la singolarità. La singolarità fa esperienza solo se è agita, se si espone, se accetta la sua vulnerabilità. I social network presuppongono delle individualità narcisistiche, un eroismo dell’io che decide e si mostra, che ospita in sé la contraddizione – il voler essere una cosa e insieme il suo contrario – senza mai affrontarla e misurarne il dolore: un homo faber fortunae suae che crede di poter controllare ciò di cui non dispone. Di qui il loro fascino…
Un accadere dell’esperienza fortemente legato alla temporalità…
Il tempo non è quello che sta fuori, il tempo sociale, il tempo cosmico della fisica, quello misurabile e quindi, come diceva Bergson, spazializzabile. Ma è il tempo della vita che dura, che matura e che giunge a compimento. In questo senso, il rovesciamento che la singolarità comporta è completo.
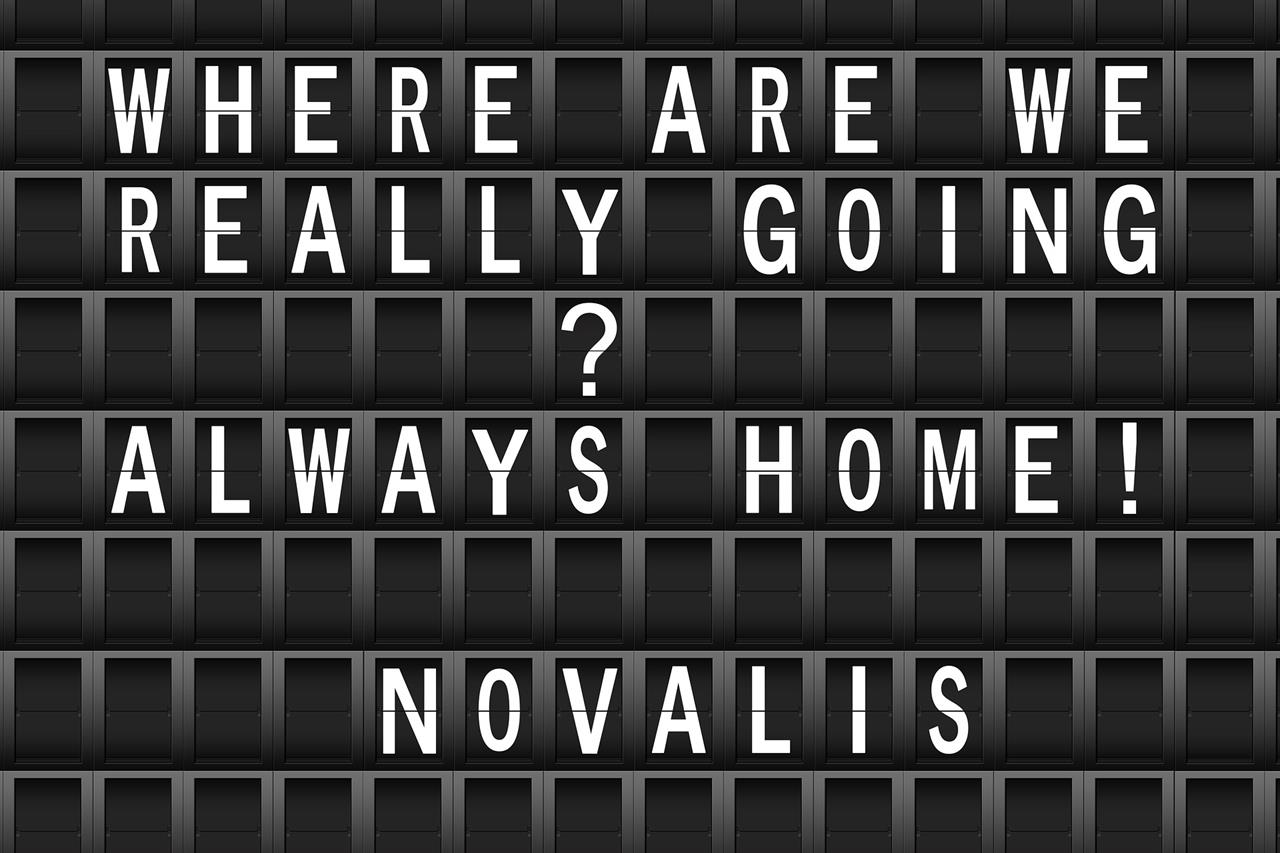
Per esempio?
Per esempio bisognerebbe intendere chi è vecchio, non perché ha ancora poco tempo da vivere, ma come colui che, invece, ha acquisito un sacco di tempo. La sua singolarità, infatti, ha sedimentato il tempo, lo ha fatto crescere in opere, affetti e relazioni. Bisogna allora rivoluzionare queste concezioni dell’esteriorizzazione del tempo. Quando navighiamo su internet, davanti a uno schermo, la rete, il computer, lo schermo non hanno tempo, ma diventano uno scacciatempo. Spesso giochiamo o divaghiamo, come si suol dire, per “passare il tempo”. Ma farsi espropriare del proprio tempo, non pone comunque fine al tempo che siamo e che non possiamo non essere. C’è un tempo che non passa, che è il tempo che siamo e che continuamente si accumula: è questo il tempo della vita, propriamente umano nella forma del racconto, come suggeriva Ricoeur, ma che, in quanto tale, ci accomuna a tutti gli altri esseri viventi.
C’è un tempo sociale, c’è il tempo della fisica minuta, il tempo che passa…
Ma non c’è nulla di peggio per noi che uniformare il tempo che siamo a un tempo che passa e che ci mette nella condizione alienata di coloro che pensano di esserne svuotati, quando invece siamo pieni di tempo. E questa sovrapposizione ci mette in uno stato di completa e integrale alienazione rispetto al tempo e alla sua sedimentazione, ossia alla dimensione delle nostre singolarità. Allora l’esperienza ci sembra impossibile, perduta per fretta del tempo che non c’è più o per impazienza del tempo che non c’è ancora. Le singolarità decantano il tempo che siamo e il racconto mostra, fa sentire il senso di questa decantazione. Ma noi non vogliamo più ascoltare, perché questo significherebbe riconoscere la nostra singolarità. Nell’essere senza tempo, nell’accelerazione e nell’istantaneità veicolate dalla tecnologia c’è il succedaneo contemporaneo dell’eternità religiosa. Invece, essere fatti di tempo significa dover ammettere il limite che si è, non che si ha e che ci si può illudere di aggirare.
Questo accade anche nell’esempio paradigmatico della malattia…
Che non a caso ci richiama il tempo che siamo, impedendoci la routine abitudinaria del tempo sociale, del lavoro, degli appuntamenti e degli svaghi. Improvvisamente questa chiamata al tempo che siamo ci fa riscoprire il corpo. Siamo chiamati, nel caso della malattia nel modo più doloroso, alla nostra intratemporalità. Se non ci pensiamo, infatti, se non siamo richiamati alla nostra singolarità, la nostra vita sembra esaurirsi nella successione di questo “fuori”, ci gettiamo nel flusso e, non a caso, ci sembra di non aver più nulla da raccontare. Il tempo cristallizzato, che non passa, che si sedimenta in una storia: questo, oggi, ci appare schermato dalla noia, perché – come nel celebre episodio della madeleine di Proust – non è intenzionale, voluto, è un evento. È la mémoire involontaire, su cui insiste, non a caso, un traduttore d’eccezione di Proust, Walter Benjamin.
Benjamin che, però, dà un’altra lettura del fenomeno, a partire dalla Opera d’arte nell’epoca della sua riproducibilità tecnica…
Infatti, lì parla di una fruizione distratta dei prodotti delle nuove tecnologie comunicative, come il cinema. Una fruizione distratta attraverso la quale le opere d’arte della riproducibilità tecnica contribuirebbero alla costruzione di un io depotenziato, in grado in questo modo di liberarsi dalle imposizioni della cultura borghese e del mercato. Ma nello scontro fra Eisenstein e Hollywood chi ha vinto? In che direzione è andato quel mondo che Benjamin non ha potuto vedere? L’io della percezione distratta, oggi della distrazione compulsiva degli smartphone in mano ai bambini e ai rimbambiniti di tutto il mondo, è l’io del grande consumo e della grande pastorizzazione della crisi. La distrazione, per essere mantenuta o superata, presuppone l’educazione all’istantaneità, l’essere senza indugiare, il giochetto compulsivo. L’attenzione non è la consapevolezza, ma ciò che la precede, l’affiorare dell’esitazione che la sospensione dello stimolo immediato richiama.
L’uomo come animale che esita, dunque, non l’uomo che appena sfiorato reagisce
Se tu sei schiacciato sull’immediatezza, significa che c’è un rapporto tendenzialmente automatico fra stimolo e risposta, come nel modello animale. Blumenberg diceva che l’uomo è quell’essere che si pensa sempre attraverso ciò che non è. L’istinto è una figura con cui la tradizione occidentale ha elaborato la differenza fra l’uomo e l’animale. C’è un evidente specismo in tutto ciò. Infatti, basterebbe guardarli, gli animali – Linneo, contro Cartesio che credeva che gli animali fossero macchine e non sentissero neppure il dolore, diceva “è evidente che non ha mai visto una scimmia” – per capire che le cose sono più complesse. Perché anche l’animale, in particolare gli animali superiori di cui riusciamo ad intepretare i comportamenti, sono perplessi davanti alle situazioni nuove. Insomma, anche l’animale esita. Collego questa esitazione, questa perplessità, questa dilazione rispetto ad una risposta immediata con l’affiorare della temporalità che consente l’esperienza. Perché l’esperienza è proprio questo: non soltanto riconoscere lo stimolo e rispondervi, ma sospendere la risposta e aggirare lo stimolo, ovvero la possibilità della non risposta. L’esperienza è proprio questa negatività rispetto all’automatismo, potenzialmente istantaneo, che concatena lo stimolo alla risposta. Esperienza è un prendere tempo. Credo sia questo il nucleo immanente, sensomotorio e, comunque, non di tipo esclusivamente cognitivo della parola “coscienza”. Essere cosciente, significa non esaurirsi nella risposta, ma temporalizzare la possibilità di eludere lo stimolo. In questo senso, l’eterodosso filosofo e psicologo della mente Jullian Jaynes in una famosa conferenza a San Giorgio, a Venezia, all’inizio degli anni Novanta, parlava di struttura diacronica della coscienza. La coscienza è essenzialmente questo.
Non il movimento di ricostruzione temporale…
Quando dormiamo, se non sogniamo, la coscienza sembra essersi dileguata. La coscienza inizia nel momento in cui cominciamo a temporalizzare, ossia a raccontare. Il sogno si sogna alla notte e, a detta dei neurologi, dura pochi minuti, ma si racconta di giorno, da svegli. Se ne siamo consapevoli, queste storie collegate con la nostra situazionalità e con la nostra temporalità diventano racconto, ossia tempo condiviso, tempo raccontato, il tempo vissuto che traduce il tempo che siamo, la durata della singolarità addormentata. E il tempo del racconto è assai più lungo della durata del sogno, mentre ancor più lungo appare il tempo raccontato dal sogno, che talvolta sembra poter riassumere la durata di una vita intera. È in relazione alla singolarità che il tempo diventa un enigma.
Famosa la distinzione di Agostino: il tempo è quella cosa che, se non me la chiedi, so, ma se me la chiedi, non so…
Perché questa distinzione? Perché se non me lo chiedi il tempo è l’intratemporalità del tempo che non passa, se me lo chiedi te lo devo spiegare e quindi devo tradurre il tempo della durata della singolarità in tempo spazializzato e quindi, lo devo tradurre in quello che non è.
Occupare il tempo
L’accelerazione, oggi, impone di non esitare…
Indiscutibilmente, la questione del tempo, oggi, è la questione dell’eliminazione del tempo nella simultaneità. Sincronia, contro diacronia della coscienza. Istantaneità contro esitazione, sul lavoro come nello studio. Oggi non si chiede a un lavoro di essere ben fatto, si domanda che soprattutto venga fatto nel minor tempo possibile.
Altra questione sono i tempi morti, il tempo della noia, il tempo in cui qualcosa, l’imprevisto, può accadere. Le cose accadono comunque, ma se guardiamo alla fermata degli autobus o della metropolitana, oramai la gente è intenta nemmeno più a comunicare, ma a giocare. L’industria dei casual games, da Candy crash in poi, è una delle più fiorenti, parliamo di circa 106miliardi di dollari di utili, quest’anno… Il tempo libero è un tempo colonizzato e messo a valore…
Nel suo corso forse più bello, quello sui “Concetti fondamentali della metafisica”, Heidegger, all’inizio degli anni Trenta, chiamava tutti i dispositivi fatti per combattere la forme più superficiali di noia, “scacciatempo”. Il problema è che il tempo spazializzato, che viviamo fuori di noi, nel lavoro e nelle forme di esteriorizzazione che ci circondano, continua anche negli intervalli. Intervalli che presentano il rischio di un ritorno al proprio tempo, all’intratemporalità del tempo che siamo. Tornare al tempo che siamo produce dolore, perché il tempo che siamo non passa e non anestetizza. Se sei in una piccola stazione ferroviaria di campagna e il treno è in ritardo, come in uno degli esempi che faceva Heidegger, che cosa fai per far passare il tempo? Conti gli alberi del viale che porta alla stazione, riguardi l’orologio e non è passato ancora un minuto. Oggi, l’uomo dell’esempio avrebbe ammazzato il tempo giochicciando con lo smartphone. Il casual game è lo scacciatempo. Quanto alla noia, questo tipo di noia superficiale, anzi questa percezione superficiale della noia è quella che sembra avere un oggetto, una causa, per esempio il ritardo del treno, l’incepparsi della macchina del tempo spazializzato. In passato c’era il libro. Uno leggeva e entrava in un’altra temporalità. Oggi, invece, continua a rimanere in una temporalità esteriore, seriale, ma rassicurante. Rassicura essere sempre fuori, perché l’intratemporalità, il tempo che siamo, ci misura, ci espone, è péras, è limite: è questo e non quello. E, soprattutto, ci riporta ai limiti e alla misura segnata dagli estremi della nostra singolarità, ovvero alla morte come alla nostra nascita. Nella parola esperienza è fondamentale il richiamo al termine greco péras, al limite, ma péras significa anche legame. Se è pur vero che l’esperienza è un passare attraverso, questo passare è possibile perché c’è il limite (péras), che rimane sul fondo dell’esperienza, come l’inattraversabile – l’apéiron – che l’attraversamento porta con sé. L’inattraversabile è quel mare che non si attraversa perché, come l’Oceano dei Greci, ha una sola sponda, circonda tutto, e le cose assumono un senso se si rapportano a questo mare-oceano, a questa totalità finita che circoscrive.
Mentre l’esteriorità del tempo che passa sarebbe costitutivamente infinita…
Ma è un cattivo infinito. È l’infinità della serie matematica che ci illude di non fare mai i conti con la puntuazione del senso, che ci trasforma in esseri frustrati e frustranti, perché ci colloca stabilmente nella contraddizione del non senso. Infatti, anche proclamare il “non senso della vita” è pur sempre dare alla vita un senso, come dicendo la parola “nulla” si dice pur sempre qualcosa.
Homo legens
Lei accennava prima alla lettura..
La lettura, la pratica dell’homo legens, è una grande forma simbolica di esitazione, perché il lettore è colui che non si fa travolgere dal mondo dell’immagine e dell’apparenza e si pone in un rapporto di continuo scavo e contemporaneamente si fa scavare dal libro. I libri infatti ci leggono e la scrittura, come dicevano gli antichi esegeti, cresce con chi la legge. I lettori della Bibliothèque Nationale di Rilke, ripresi da Wenders ne Il cielo sopra Berlino, sono delle splendide figure della singolarità. Il fenomeno della lettura non è immediatezza istintiva, ma mediazione. Si legge tutto, si possono leggere i fondi del caffè o, come insegnava Borges, anche le macchie della pelliccia di un giaguaro. Dobbiamo intendere la lettura come questa capacità simbolica di esitare che non è il ripiegarsi sulla parola scritta come medium specifico ma, utilizzando il modello fornitoci dal medium, il rapportarsi alla realtà in una forma di leggibilità discreta e non di sua immediatezza irriflessa. Il fatto di leggere la realtà significa sempre prenderne le distanze, porre una questione critica.
“Dire di no” – come esempio massimo della critica – è un’altra forma di esitazione. Ne “Il dono del filosofo”(Einaudi), lei sosteneva che la filosofia è una sorta di costruzione di una figura concettuale, il filosofo appunto, la cui caratteristica consiste in un’ostinata capacità di critica. Una critica che è tutt’uno con una forma di esitazione…
Pensiamo al Bartleby di Melville, uno scrivano che, come Socrate, non scrive “nulla”. «I prefer not to», preferirei di no, dice Bartleby. In quel “preferirei” c’è un’esitazione che si ritaglia una riserva che consente di non concepirsi come pura opposizione. È più intimo dire “preferirei di no” rispetto al semplice “no!”. Il “preferirei” tiene conto del tuo possibile “dire di sì” e “dire di no”. In qualche modo comprende l’altro, ma non rinuncia al segreto incondizionato della propria diversità. Una diversità di cui Bartleby stesso può non essere consapevole.
Dire “preferirei di no” non significa sapere bene cosa si preferisce, in positivo. Il deuteragonista del racconto di Melville, l’avvocato datore di lavoro dello scrivano, è colto da un grande imbarazzo e il gioco sta proprio in questo “preferirei” che non si esaurisce in un rapporto autoritativo, ma si manifesta in un inizio del riconoscimento senza riconoscere. La formula “I prefer not to” è ospitale in questo, nega ma accoglie, crea uno spazio interstiziale. Allo stesso tempo, custodisce la propria intimità.
Che cosa realmente preferisce Bartleby?
Non lo saprà nessuno. Bartleby è l’eroe della singolarità e del pudore.
Di una singolarità esitante e pensante, che fa esitare e dà da pensare...
Noi non pensiamo perché pensiamo di pensare, pensiamo perché ci capita di pensare. Non pensiamo continuamente, né il pensiero può essere identificato in una forma dell’agire e del fare. Certo, il pensiero calcolatore sembra simile ad un fare volontario e intenzionale, ma, a ben vedere, il suo modello concreto è l’automatismo. C’è un’arroganza metafisica del pensiero che si ritiene capace di “vincere la morte” mediante il piano di continuità della logica. Io invece credo che le cose che ci fanno pensare e degne di essere pensate siano proprio le discontinuità. La costruzione del Logos, con Platone, è la costruzione di uno spazio che, a prescindere dalle singolarità e dalle loro rotture, istituisce una continuità trascendente e trascendentale. Al contrario della continuità – che sia la continuità di una trascendenza iperuranica, del piano trascendentale della logica o che sia la continuità contemporanea della tecnica come infinità capacità di produrre scopi -, credo che la singolarità ci conduca a valorizzare la discontinuità. E la discontinuità è sia la nostra finitudine, sia la nostra debolezza, ma anche la possibilità che ci siano gli altri, anche la possibilità che ci sia la libertà. La libertà è discontinuità e il caso, l’irruzione dell’evento, l’inatteso diventa l’operatore ontologico della libertà.
«Un lancio di dadi non abolirà il caso…», scriveva Mallarmé, il cui pensiero-poetante potremmo idealmente gettare contro tutte le gabbie della contingenza…
Gabbie che inerzialmente continuano a realizzare un mandato che è quello del Logos. Il fascino del Logos, l’intraducibile parola che significa, insieme, pensiero, linguaggio, ragione – e che nell’etimologia evoca la forza di ciò che lega – è quello di assicurare la continuità, di vincolare gli esseri discontinui che siamo. Quando, nell’omonimo dialogo, Socrate diceva a Fedone che vero motivo di lutto sarebbe stata non la sua morte bevendo la cicuta, ma se si fosse bloccato il meccanismo del Logos, rivelava l’obiettivo autentico del dialogo, dell’intera filosofia di Platone, vuoi anche il movente primo della razionalità occidentale: la continuità. Se il Logos non dovesse aver ragione del proprio avversario. Se dovesse incepparsi nelle discontinuità del singolare concreto, allora vi sarà la vera sconfitta. La questione è tutta qui. Ma Socrate sta dimostrando che se il Logos è continuo e se il discorso non ha fine, se esiste il linguaggio, se esiste una comunità che parla e pensa, allora questa è la garanzia che la morte sarà sconfitta. Non nella singolarità. E, quindi, la singolarità si può e si deve rimuovere e obliterare. Eppure, la grandezza di Platone è che la sua messa in scena, il teatro filosofico dei Dialoghi, mediante i personaggi e le loro caratterizzazioni, dice anche altro rispetto alla continuità del Logos. Appaiono le singolarità di Fedone, di Socrate, di Fedro, di Teeteto, di Alcibiade, ecc., infine di Platone stesso, che con tocco magistrale dice la sua assenza: “Platone credo fosse malato”. Ecco il velo che copre il corpo di Socrate, ma ecco anche quell’aoristo dissonante, come lo chiamava Jankélévitch, che descrive l’istante mortale, l’irruzione dell’evento, la discontinuità della singolarità. Operazioni raffinatissime, palinsesti del testo filosofico – evidentissimi in Platone, ma presenti nella testualità di tutta la grande tradizione filosofica – che complicano la scena del Logos e ci danno un’altra possibilità per pensare. Gli aneddoti del pensiero sono potentissime occasioni di pensosità, ovvero per fare libera esperienza del pensiero e della sua anarchia. Altri discorsi, altri lanci sono possibili anche se i dadi rimanessero gli stessi. Ma chi può dirlo?
17 centesimi al giorno sono troppi?
Poco più di un euro a settimana, un caffè al bar o forse meno. 60 euro l’anno per tutti i contenuti di VITA, gli articoli online senza pubblicità, i magazine, le newsletter, i podcast, le infografiche e i libri digitali. Ma soprattutto per aiutarci a raccontare il sociale con sempre maggiore forza e incisività.

