«Sono ancora vivo ma mi sento come se non avessi un’anima e, quando cammino per le strade, persino i cani e i gatti fanno finta di non vedermi. Guardo le notizie in TV ogni giorno e scorrono sempre gli stessi filmati di migranti bloccati (…), senza una soluzione. Mi sento come un fantasma, e i migranti sono come bombe a orologeria, che potrebbero togliersi la vita da un momento all’altro. Il nostro futuro è in bilico. Sebbene ci siano diritti per gli animali, non ci sono diritti per noi 2000 migranti. Chiedo sempre alla gente qui con me dove vuole andare e non ricevo risposta… Mettetevi nei nostri panni. Non ci state aiutando ma distruggendo… Mi sembra di essere pazzo». (Moataz Attawil, ingegnere, attore, e giovane padre di Aleppo, tra i 160 migranti, che a marzo scorso erano accolti nel centro di Adesevci fuori Sid, cittadina serba al confine con la Croazia.)
La chiusura ufficiale della rotta balcanica decisa a inizio marzo, quando Croazia, Slovenia, Serbia e Macedonia – sotto pressioni da parte dell’Austria – hanno sbarrato i confini all’ondata di persone verso l’Europa occidentale, non ha messo fine alle lunghe e rischiose peregrinazioni di migliaia di uomini, donne e bambini, e i numeri di chi cerca imperterrito di raggiungere terre promesse e sconosciute, affrontando un ostacolo dopo l’altro, aumentano invece di decrescere. Chi per via dei blocchi e delle nuove politiche si è arenato nella dimenticata terra di transito che è la Serbia, dove oltre a non volere, sa di non poter rimanere, tenta disperatamente di andarsene.
Sono ancora vivo ma mi sento come se non avessi un’anima e, quando cammino per le strade, persino i cani e i gatti fanno finta di non vedermi.
Moataz Attawil
«Nel 2015 più di 600,000 persone sono passate per la Serbia senza fermarsi», raccontava qualche tempo fa Ivan Miskovic, portavoce del Commissariato governativo per i Rifugiati e le Migrazioni, organo responsabile dei casi di asilo nel Paese dal 2008. «Oggi 2000 persone sono bloccate qui e… Sai perché sono bloccate? Perché non siamo la loro destinazione finale». Nonostante il supporto delle organizzazioni non governative, queste persone si sentono abbandonate a loro stesse e dimenticate da tutti; sono vittime non solo della non curanza della gente ma anche di un sistema che non ne consente il reintegro. «Cerchiamo di soddisfare i loro bisogni primari e dare supporto psicologico e sociale», spiegava Zorana Parezanovic dell’organizzazione serba ATINA, nota per le campagne in difesa delle vittime di traffico umano, «ma quello che li sta distruggendo è non sapere che ne sarà di loro e, separati come sono dalle loro famiglie, si domandano se riusciranno mai a rivederle».
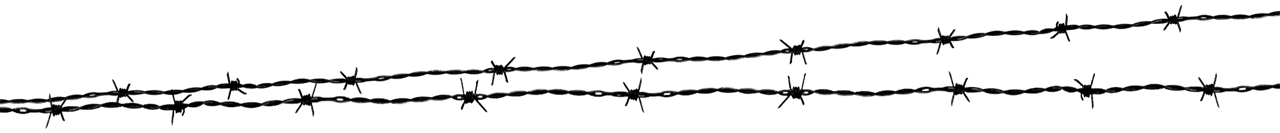
Il campo di Presevo al confine meridionale con la Macedonia, che era stato fino a quel momento un campo di transito, ospitava in una fabbrica di tabacco in disuso quasi 650 persone respinte dalla Slovenia o dalla Croazia poco dopo il sigillo dei confini, o arrivate illegalmente dalla Macedonia e dalla Bulgaria. Fatta eccezione per lo stato di pesante vigilanza, non certo favorito dalla presenza di centinaia di militari, e la sensazione diffusa tra i migranti, di essere trattati da detenuti e non da rifugiati, il campo vanta strutture nuove e pulite, distribuzione di cibo e vestiti e un’area adibita allo svago dove, il giorno della nostra visita, si sfidavano in un torneo di calcetto migranti di diversi paesi – per la maggior parte siriani, iracheni, curdi e afgani – e le guardie del posto.
Tra i pochi che se ne stavano lontani dagli spalti, c’era una donna cui avrei dato l’età di mia madre, ma che scoprii essere anagraficamente più vicina a mia sorella; una donna dallo sguardo triste e determinato, intenta a leggere un libro, noncurante delle grida di festa che ronzavano tutt’attorno. Rukia Khan fino all’ottobre scorso viveva a Homs, la terza città siriana per dimensioni e una delle località più selvaggiamente colpite da una guerra entrata nel suo quinto anno. «Fino all’ultimo non volevo andarmene ma vivere lì era diventato impossibile», diceva Rukia, ritornando rapidamente con la mente a un passato ancora vivo. «Non c’erano né cibo né acqua e le case erano in macerie. Anche la gente era cambiata per via della guerra e alla foga di accaparrarsi il poco rimasto, a discapito degli altri, si aggiungeva una corruzione dilagante». Rukia era solo una tra le tante donne in viaggio dalla Siria all’Europa con due figli adolescenti ma, a distinguerla, era la ferma lucidità con cui raccontava ogni passo della sua estenuante odissea. Da Homs si era recata Damasco, e da lì a Beirut. Grazie ai soldi raccolti dalla sua famiglia, che aveva deciso di restare indietro per dare a lei e ai suoi figli una speranza di vita normale, era volata a Istanbul e quindi a Izmir. Per 750euro a testa un trafficante li aveva schiacciati in uno dei tanti gommoni diretti all’isola di Lesbo, dove si erano registrati, prima di proseguire verso il continente. Da Atene avevano camminato per ore fino al confine con la Macedonia e alla cittadina di Gevgelija, e quindi avevano viaggiato su un treno diretto in Serbia. Qui Rukia si era premurata di prendere le carte di transito – in uso fintanto che la rotta balcanica era ancora aperta, per permettere ai migranti di attraversare il paese senza fermarsi – e procedere velocemente verso la Croazia e la Slovenia.
«È stato proprio in Slovenia, il 25 febbraio, mentre aspettavamo con tutti gli incartamenti in regola di essere convocati per l’intervista di rito, che ci hanno detto che dovevamo andarcene», spiegava Rukia, a cui non era stato detto che la Slovenia si stava preparando, accettando un massimo di 580 migranti al giorno e respingendo i tanti restanti, a chiudere ufficialmente i confini. «Non ho un piano e nessuna speranza», diceva, abbozzando una smorfia. «Staremo qui fintanto che qualcuno si prenderà la briga di spiegarci cosa succede». Senza inibizioni, Rukia aveva poi fatto un appello a «chi siede lì in alto e parla di noi come se fossimo solo numeri». «Perché me ne sono andata di casa? Credete mi facesse piacere? No. Ci ho provato a restare ma era troppo dura. Sono andata in Turchia e mi hanno trattata male, malissimo, poi ho messo piede in Grecia, in Europa, e ho visto tanta di quella gente dormire per le strade ed essere trattata senza dignità… Vi prego, fermate questa fabbrica umana». Le parole e il tono di Rukia erano molto simili a quelli di Moataz, l’aleppino con moglie e figlio costretto nella miseria di Sid. «Per scappare da morte certa ho deciso di andare in Europa via mare», diceva con verve teatrale, «e ricordo che l’Europa aveva promesso che ci avrebbe protetto da tutti quei trafficanti senza scrupoli. Sbaglio? Non hanno fatto nulla e oggi i problemi con i trafficanti sono ancora peggio di prima. Io ho pagato 1700, o 1800 euro per arrivare fin qui, ma altri si sono venduti gli organi…».
Perché me ne sono andata di casa? Credete mi facesse piacere? No. Ci ho provato a restare ma era troppo dura
Rukia Khan
A confermare un aumento e peggioramento delle attività illegali, cui ricorrono ancora in tantissimi migranti intrappolati a pochi chilometri dai confini europei, sono le organizzazioni non governative serbe, animate da tanti professionisti e volontari. «Queste persone sono depresse, in attesa di sapere qualcosa mentre i loro familiari sono dispersi in giro per l’Europa», spiega Marija Cvejic dell’ONG Atina, che da settembre fornisce supporto psicologico nei campi di Sid. «Per questo non la smetteranno di mettersi nelle mani dei trafficanti; i prezzi saliranno e, visto che non tutti si potranno permettere queste tariffe, ricorreranno ad altri servizi, affrontando rischi sempre maggiori». Chi ha soldi per pagare, come Surwar e la sua famiglia che, da Mosul fino a Belgrado, non senza alcuni imprevisti che li hanno visti rinchiusi per giorni in un campo in Bulgaria e camminare per ore nella notte fino al confine, si sono affidati a un amico-trafficante per 22000 euro e, al momento dell’intervista con VITA, stavano varando nuove dispendiose vie per uscire da lì. Chi i soldi non ce li ha, non si rassegna a non andarsene e, com’è già successo in alcuni casi e confermato da Jelena Hrnjak, collega di Marija ad ATINA, «deciderà se vendere gli organi per pagarsi il viaggio, ricorrere alla “prostituzione per sopravvivenza”, già diffusa tra donne e minori, o rischiare la vita».
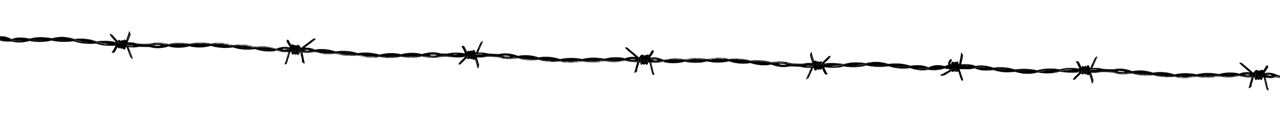
Tra i tanti che hanno rischiato di non farcela, c’è anche il 22enne Reijane, originario della provincia afghana di Nangarhar. Alle spalle della stazione principale dei bus di Belgrado si trova un piccolo cortile su cui si aprono dei prefabbricati, che offrono gratuitamente ai migranti diversi servizi – come la raccolta e distribuzione di scarpe e vestiti, un ristorante-bar, child friendly spaces per donne e bambini e un’area ricreativa – gestiti da ONG locali e non. Quella mattina, com’è stato confermato dalla portavoce dell’Info Centre, Maja Dragovic, «il numero di persone di passaggio si era più che duplicato, raggiungendo le 300/350 presenze, forse a causa della paura nata dall’accordo di rimpatrio siglato, ma non ancora implementato, dalla Turchia e l’UE». Tra i giovani e le famiglie provenienti dal sud ed est del Paese, c’erano anche loro: Bilal e Danyal, due cugini pakistani che avevo incontrato tempo prima a Bodrum, sulle coste turche del Mar Egeo, e che, per garantirsi un posto in barca fino in Grecia, a volte facevano da mediatori tra la gente arrivata da lontano, con la foga di entrare in Europa il prima possibile, e i trafficanti del posto.
Nessuno dei due parlava bene inglese ma, neanche a farlo apposta, giunti sull’isola greca di Kos dalla Turchia, i due avevano conosciuto Reijane, un loro coetaneo che dimostrava il doppio dei loro anni e che, da ufficiale di comando nell’esercito afghano a contatto con gli americani, parlava l’inglese alla perfezione. Con lui sono arrivati in Serbia. «Sono partito da casa due anni fa e me ne sono andato solo quando i talebani hanno sparato e ucciso a mio fratello minore e mio padre mi ha supplicato di prendere le mie cose e andarmene», spiegava Reijane, con tono e sguardo impenetrabili. «È stato mio padre a organizzare il mio viaggio con un trafficante dall’Afghanistan al Pakistan, e quindi all’Iran e – dopo 14 ore di camminata – fino a Van, in Turchia». Quando è arrivato a Istanbul e ha saldato il conto del viaggio fin lì, pari a 20000 euro, non aveva più niente e si è rimboccato le maniche per continuare la traversata.

Per alcuni mesi Reijane ha lavorato sottopagato in una fabbrica di Istanbul, ma poi ha preferito dare una mano ai curdi a tagliare il legno nei boschi. Dopo un anno aveva finalmente racimolato abbastanza soldi per proseguire il viaggio e, pagati altri 700euro all’ennesimo trafficante, era sbarcato a Kos, dove ha conosciuto i cugini. «Dopo aver lavorato come volontario per tre mesi alla Croce Rossa, mi sono spostato ad Atene con loro ma la situazione era ingestibile e abbiamo deciso di andarcene in fretta», raccontava. Il primo tentativo è fallito quando, scavalcato il filo spinato, il trio è stato beccato dalla polizia macedone che, dopo averli minacciati e malmenati, li ha spediti in un campo greco al confine, da cui sarebbero dovuti tornare ad Atene il giorno successivo. Le prime luci dell’alba avevano però in serbo una sorpresa per loro. «Abbiamo visto un treno che viaggiava in direzione Macedonia e, dopo aver fatto un paio di ricerche, abbiamo scoperto che proseguiva fino in Serbia», racconta Reijane. «Non appena si è fermato vicino al nostro nascondiglio, siamo saliti ma, poiché non potevamo viaggiare come passeggeri normali, ci siamo incastrati sotto tra le ruote. Siamo stati in quella posizione per due giorni interi.” Dopo quarantotto ore i giovani non avevano più la forza di tenersi su, e sono usciti da lì. “Non puoi immaginare la nostra gioia quando abbiamo visto una macchina avvicinarsi con la targa SRB…Eravamo salvi».
Dopo aver lavorato come volontario per tre mesi alla Croce Rossa, mi sono spostato ad Atene con loro ma la situazione era ingestibile e abbiamo deciso di andarcene in fretta
Reijane
Se per siriani e iracheni quello che sta avvenendo è ingiusto e terribile, a pagare il prezzo più alto dei compromessi diplomatici del momento, sono afghani e pakistani. «In tanti sono già stati rispediti in Turchia e da lì in Afghanistan», raccontava Reijane, prima che la pratica illegale fosse confermata anche da Amnesty International, «ma se davvero il mondo è convinto che nel mio Paese non ci sia la guerra, lo sfido a recarsi lì per un giorno e poi tornare e riflettere. L’Afghanistan è in guerra da anni, sotto il dominio prima dei russi, poi dei talebani, dell’America, oggi anche dell’ISIS, e i cinque anni di conflitto in Siria e Iraq al confronto sembrano cosa da niente». Con uno sguardo pieno d’orgoglio, come a rimarcare il suo passato da comandante nell’esercito, ha aggiunto: «Per questo motivo tenteremo di chiedere asilo in Serbia e magari… avremo fortuna».



















Mentre chi lavora all’Info Centre di Belgrado si dedica anima e corpo a tutti quegli sconosciuti venuti da lontano – garantendo connessione internet e telefonate internazionali gratuite, informazioni sul sistema d’asilo, sui trasporti, sulla geografia del posto nelle diverse lingue grazie ai mediatori culturali, e aiuto psico-fisico, cibo, medicine e vestiti -, le possibilità concrete per queste persone bloccate alle porte d’Europa, senza sapere dove sono e cosa faranno, sono “poche e non allettanti”, come conferma Dragojevic. «Possono tornare al loro paese d’origine – e mi riferisco solo a chi proviene dal Marocco o dall’Algeria – o provare a chiedere asilo, se non altro per trovare un posto per dormire in uno dei centri, o andare a sud e provare a chiedere le carte di transito per procedere verso ovest o nord – cosa che fino a poco fa valeva per chi si era registrato regolarmente di paese in paese ma ora, non so davvero…» Dragojevic ammette che con tutti quei cambiamenti improvvisi anche a loro non resta che attendere, e sperare, mentre Jelena Hrnjak di Atina si dimostra critica e pessimistica nei confronti del sistema. «Anche se i migranti si decidessero a chiedere asilo in Serbia, non glielo garantirebbero, perché dal 2008 – anno in cui è stata ratificata la legge – solo 5 persone l’hanno ottenuto secondo i dati del Ministero degli Interni,” spiegava. “Richiedere protezione sussidiaria, che non fornisce loro documento identificativo e li costringe a ritornarsene a casa quando la crisi nel loro paese è terminata, è un altro buco nell’acqua, perché è stata accordata a solo 7 individui. L’unica opzione reale è andarsene… o aspettare di ricevere asilo in un limbo logorante e senza fine».
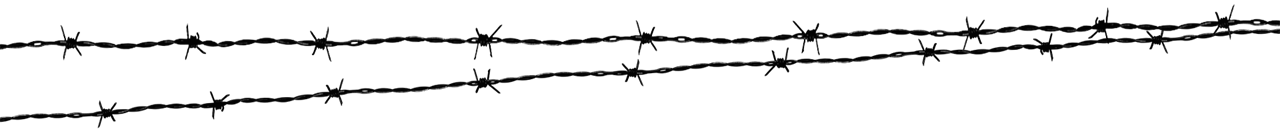
Reijane, giovane intraprendente messo di fronte a un’amara realtà, ha deciso di restare, e così anche Sumaya che, nonostante sia siriana – e quindi per la politica del momento più privilegiata – e con un marito, un figlio piccolo e un altro in dolce attesa, non vuole più aspettare che un miracolo la porti in Germania. «Abbiamo speso tutto per arrivare qui; non abbiamo più nulla. Vedo così tanta gente pagare i trafficanti e andarsene altrove ma noi, che non abbiamo mai pensato di farlo, anche se volessimo, non potremmo permettercelo», spiegava con la voce rotta, senza però mai lasciarsi andare alle lacrime. «Le altre persone ci dicono di non chiedere asilo qui, fuori dall’Unione Europea, perché anche quel poco che ci spetta non ci verrà dato ma noi… Vogliamo solo un po’ di pace».
«Viviamo nel paradosso», dice Hrnjak sconsolata. «Se vuoi che la gente smetta di mettersi in pericolo e viaggiare illegalmente, devi offrire qualcosa, dare loro un’occasione, non puoi chiudere le porte come stanno facendo il nostro e molti altri paesi».
Viviamo nel paradosso. Se vuoi che la gente smetta di mettersi in pericolo e viaggiare illegalmente, devi offrire qualcosa, dare loro un’occasione, non puoi chiudere le porte come stanno facendo il nostro e molti altri paesi
Hrnjak
Mentre qualche giorno fa è passata la notizia che il campo di Presevo, nel sud della Serbia, si sta velocemente svuotando, e ci sono solo trenta delle 650 persone che prima stavano lì, in 50 sono in trepidante attesa al confine di Horgos, a pochi metri dall’Ungheria, e in centinaia, dopo aver attraversato illegalmente in preda al panico, sono detenuti in centri di detenzione e campi straboccanti, in attesa di essere spediti indietro o altrove. Queste persone hanno aspettato notizie sul loro futuro e, quando sono arrivate, hanno deciso di raccogliere le loro cose e andarsene. In Europa, invece di essere accolti, sono trattati come bestie, ignorati, rinchiusi in solitudine, e mandati via con disprezzo, magari in un’altra Europa che erge muri, da loro la caccia e propone referendum contrari alla legge, o vicino, alla nostra bella Europa, dove i governi se ne fregano, e continuano a rimbalzarli di confine in confine, in un limbo infinito. A loro non rimane che una cosa da fare: voltarsi e fuggire ancora.
I 2mila fantasmi di Sid
Testi, immagini di Eleonora Vio
Video di Marco Cacioppo e Tommaso Zerbini
Nessuno ti regala niente, noi sì
Hai letto questo articolo liberamente, senza essere bloccato dopo le prime righe. Ti è piaciuto? L’hai trovato interessante e utile? Gli articoli online di VITA sono in larga parte accessibili gratuitamente. Ci teniamo sia così per sempre, perché l’informazione è un diritto di tutti. E possiamo farlo grazie al supporto di chi si abbona.



