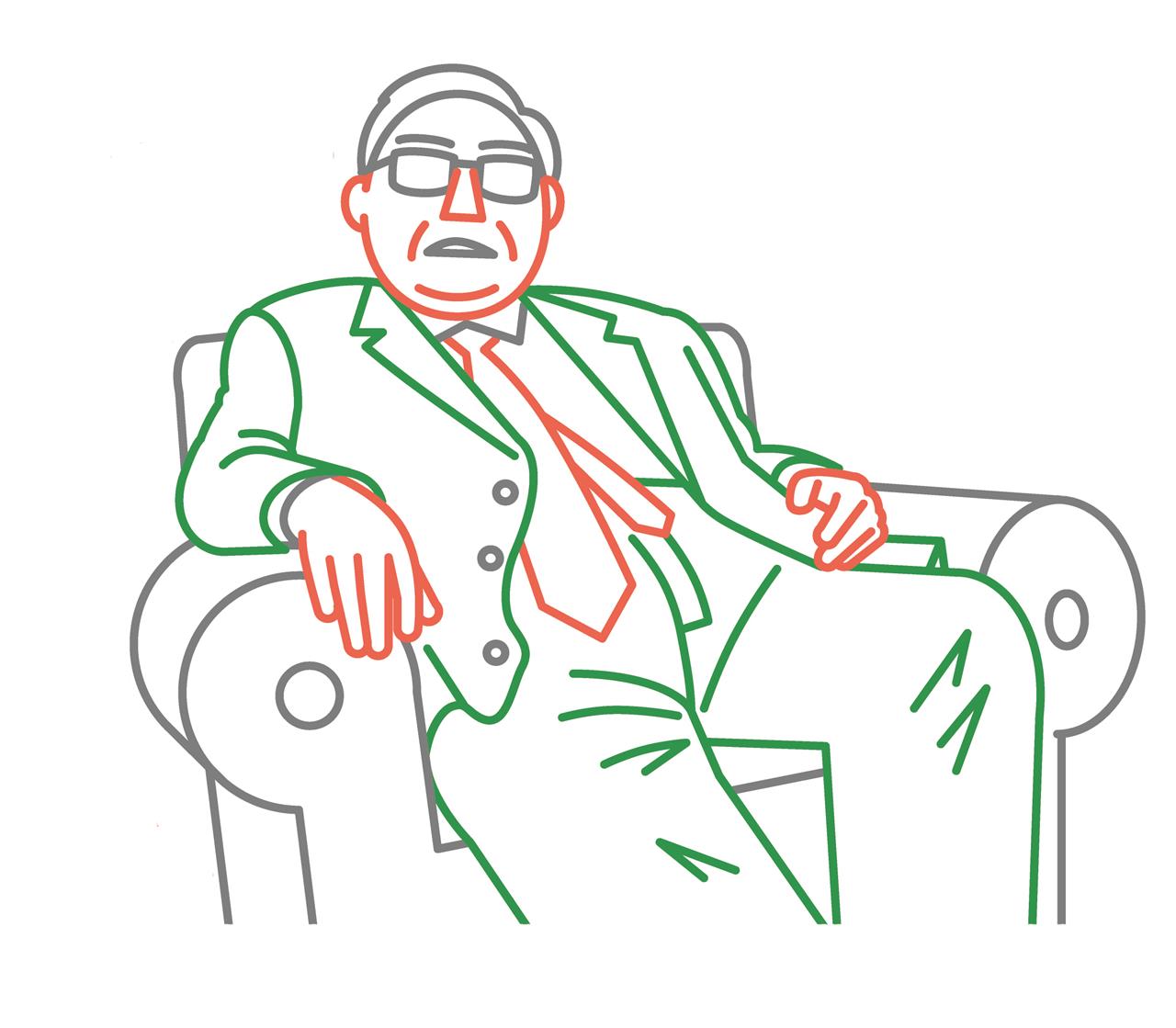
«Il primo esercizio da fare nell’affrontare il discorso su cosa sia il welfare aziendale è vederne la storia e poi osservare cosa accade oggi. In primo luogo però sarebbe meglio definirlo». Così Giulio Sapelli, storico ed economista italiano, inizia la sua lectio privata per noi di Vita. Un dialogo che è avvenuto nel salotto della sua casa milanese. Il prof. con la sua verve inconfondibile attacca: «Possiamo usare il termine welfare solo quando abbiamo diritti civili e sociali pienamente dispiegati. Cioè quando ci sono i sindacati e le loro organizzazioni, i lavoratori e abbiamo un concetto di società non organica ma in cui il più grande problema è capire come ci sia l’ordine, come si tengono insieme le varie componenti». Il più grande problema inafatti con cui ogni organizzazione umana deve fare i conti è che «le società creano conflitti».
Il welfare nasce dal conflitto
Ed è proprio da questi conflitti che nasce quello che oggi chiamiamo welfare o Stato sociale. «Da una presa di possesso di diritti, da parte di coloro che se li sono visti negati fino a quel momento», sottolinea Sapelli. «Questi diritti li chiameremo di cittadinanza sociale. Penso a cose come la salute, lo studio, il tempo libero e la riduzione dell’orario di lavoro».
Il welfare nasce dal conflitto sociale. Da una presa di possesso di diritti, da parte di coloro che se li sono visti negati fino a quel momento
Crespi D’Adda e Michelin
«Mi rendo conto naturalmente che si tratta di caratteristiche che, nell’ambito del mondo industriale, sono rintracciabili nel villaggio operaio di Crespi D’Adda o alla Michelin». Ma il prof. ha le idee chiare: «Sono due esempi della nascita della grande industria moderna. Ma non possiamo tuttavia parlare di prodromi di welfare aziendale». Sapelli ci tiene a prendere le distanze da quegli storici che, riferendosi alle forme di attenzione nei confronti dei lavoratori messe in campo dal cotonificio di Silvio Crespi e dalla grande industria francese, parlano di paternalismo.
«Si tratta di strumenti che nascono per stroncare la schiena ai sindacati e nel tentativo di impedire la predicazione socialista. Ecco perché non si può parlare di welfare aziendale. Erano forme con cui l’industria cercava di eliminare il conflitto. Ma non si può neanche limitare quelle esperienze ad un dispregiativo paternalismo. Questa è la visione di chi ritiene che gli imprenditori non sono in grado di avere una dimensione morale. Non erano welfare ma erano comunque forme di sostegno sociale. Sono state positive».

La nascita del welfare d’azienda
«I prodromi del welfare aziendale vengono da due esempi», arriva al cuore della questione Sapelli, «uno era la Fiat e il modello vallettiano. Ma non è puro perché Vittorio Valletta fa la mutua di fabbrica, con servizi sanitati molto importanti, fa le colonie per i bambini e i servizi di mensa ma discrimina il sindacato. In piena guerra fredda, nel mezzo di uno scontro sociale così forte, la Fiat aveva contrasti fortissimi con la Fiom. Chi era iscritto alla Fiom per questo durava poco, veniva licenziato. Quindi parlare di welfare aziendale diventa complicato con queste premesse». «L’altro esempio», e qui Sapelli tradisce una certa emozione, «è l’impresa pubblica che fa le stesse cose, come l’Eni».
Il vero inizio di questa storia è ad Ivrea con Camillo e Adriano Olivetti. Che creano un sistema di relazioni interne che cominciano dalla mutua, alle borse di studio per i ragazzi fino alla formazione, alle biblioteche e alle attività di studio
Olivetti e Mattei
«Il vero inizio di questa storia è ad Ivrea con Camillo e Adriano Olivetti. Che creano un sistema di relazioni interne che cominciano dalla mutua, con anche il dentista, alle borse di studio per i ragazzi che si comportano bene a scuola, fino alla formazione, alle biblioteche e alle attività di studio».

Ma si va oltre: «Adriano, che io non ho conosciuto – sono arrivato alla Olivetti nel ’66, lui muore nel ’60, ma so molte cose giuntemi per tradizione orale dal mio maestro Franco Modigliani – quando assumeva un operaio canavesano – erano quasi tutti canavesani l’immigrazione lavorativa si fermava a Torino- si preoccupava, conoscendo il nome di tutte le cascine del Canavese e della Val Chiusella, che in quella famiglia rimanesse almeno uno dei figli a coltivare la terra. Questo perché non voleva che la fabbrica distruggesse il passato agricolo. Dovevano rimanere la terra e l’agricoltura». Un ragionamento molto moderno a ripensarci oggi. «Una delle cose piuù d’impatto di Ivrea, per chi andava a visitare l’azienda, era il momento del pasto. Alla Olivetti dirigenti e operai mangiavano allo stesso tavolo. La mensa era per tutti, si mangiava spalla a spalla, dalla proprietà all’ultimo dei garzoni. D’altra parte i miei maestri mi hanno sempre insegnato che per essere un grande imprenditore devi amare le persone».
Al fianco di Olivetti c’è poi la Eni di Enrico Mattei. «Mi ha sempre colpito che quando Mattei morì, il 27 ottobre 1962, il Cda di Eni votò una pensione vitalizia per la vedova. Pensate che non aveva una casa, né soldi da parte. Abitava anche lui in una delle case pensate per gli operai di San Donato Milanese, quella più vicina alla chiesa. Il suo stipendio andava al convento di clausura delle suore di Matelica. Sapete cosa significa Snam? Tutti pensano sia l’acronimo di Società Nazionale Metanodotti. E invece era l’acronimo di Siano nati a Materica», spiega il prof. ridendo. Per capire l’aproccio Mattei sul lavoro bastano pochi altri esempi. «Crea le Stazioni di Servizio. I camionisti vivevano come tuareg nel deserto. Trovano una casa, un posto dove mangiare un pasto caldo, fare un doccia o bere un caffè. Una rivoluzione». L’altro esempio commuove Sapelli: «La Eni di Mattei in Etiopia, creando la rete dell’azienda in Africa, costruisce gli alberghi per i lavoratori.

Detta così non significa molto. Ma io ricordo mio padre, quando andò a visitare con una delegazione l’esposizione universale del ’61 a Bruxelles. Tornò molto arrabbiato perché c’era una gabbia con un cartello che recitava “Ne pas jeter de la nourriture” (non buttate da mangiare ndr). Dentro, nudi, degli uomini congolesi. Questo era il mondo in cui Olivetti e Mattei emersero. Erano dei pionieri».
L’utopia religiosa
«Tutto questo deriva dal fatto che Olivetti era un uomo divorato dalla religione, un utopista religioso». Sapelli non ha dubbi sul fatto che in qualche modo il werlfare aziendale sia stato reso possibile da un certo humus religioso. «Era un ebreo convertito al cattolicesimo. L’unica foto che si fa fare Pio XII lo ritrae vestito di bianco che scrive su una Olivetti». Perché lo fa? «Perché è la fabbrica di un ebreo convertito che aveva detto che il cattolicesimo è una religione teologicamente superiore. Suo padre Camillo era addirittura Unitarista, una religione sincretista che vuole mettere insieme cattolicesimo, protestantesimo e ebraismo. La mamma invece era Valdese. Quello che ci insegna Olivetti, insieme a Mattei, è che in queste industrie la libertà sindacale era piena. Erano due cattolici ma in quelle aziende la Cgil era più forte della Cisl».
Sapelli chiarisce: «Trovo difficile sviluppare un welfare aziendale oggi dove non c’è un imput religioso. Non a caso la filantropia c’è dove c’è una tradizione ebraica, in America, o dove c’è una filosofia Protestante. Penso che Lutero sia stato un evento tragico nella storia dell’umanità perché l’antisemitismo e la crudeltà del protestantesimo sono note, però ha inaugurato la questione della responsabilità, del fatto di essere soli davanti a Dio e del doversi riscattare. E poi c’è il cattolicesimo che ha scritto pagine meravigliose. Pensiamo ai santi sociali in tutto il mondo. Io sono torinese e sono cresciuto in mezzo ai santi sociali come Don Bosco. Recentemente ero a Cattolica a parlare di Don Orione».
Anche se nel mio piccolo sono stato protagonista di alcuni esempi pioneristici nella fine degli 80 anni per la fondazione di Tim devo dire che oggi vedo cose che mi fanno ribrezzo. Ad esempio gli asili aziendali a pagamento, che con tutta evidenza non sono welfare

Il welfare aziendale oggi
Oggi il welfare aziendale va inteso nell’ambito di uno schema teorico. «Soprattutto se parliamo di quello aziendale, cioè promosso da una partnership tra organizzazioni datoriali e organizzazioni di prestatori d’opera. È molto importante perché si fa luce sul concetto delle relazioni industriali su cui in Italia siamo enormemente indietro», spiega il prof. Le relazioni industriali sono l’insieme di due distinte pratiche sociali: le cosiddette relazioni interne e le cosiddette relazioni sindacali.
«In questo Paese abbiamo avuto la disgrazia di avere come presidente delle Camere due grandi sindacalisti – uno, Fausto Bertinotti, che si vantava di non aver mai fatto un contratto e l’altro, Franco Marini, di essere sempre stato filo governativo – e per questo pensiamo che le relazioni industriali siano tout court quelle sindacali. Invece ci sono anche le relazioni interne che sono le politiche che autonomamente il datore di lavoro adotta nei confronti dei suoi dipendenti. Che possono essere in contrasto con le relazioni sindacali, di solito per motivazioni politiche, ma non sempre. Il welfare aziendale è un segmento di queste relazioni interne. Cioè è un’iniziativa che il datore di lavoro, o i suoi rappresentati, autonomamente pongono in essere. Quando le pongono in essere in una situazione sociale in cui esistono i diritti sociali e politici possiamo parlare di vero welfare aziendale».
Naturalmente oggi il welfare aziendale è tornato di moda sull’onda della responsabilità sociale d’impresa. «Devo dire che però, anche se nel mio piccolo sono stato protagonista di alcuni esempi pioneristici nella fine degli 80 anni per la fondazione di Tim, vedo cose che mi fanno ribrezzo», chiarisce con la consueta schiettezza il prof. «Ad esempio gli asili aziendali a pagamento, che con tutta evidenza non sono welfare.
Le cose migliori le vedo in Federchimica dove c’è un contratto nazionale che contempla l’assicurazione medica o l’accesso ad alcuni servizi, forme di salario sociale». Insomma ieri come oggi forme di attenzione del datore di lavoro nei confronti del lavoratore, che favoriscano un sindacato più partecipativo, in stile americano. «E soprattutto che fanno sentire la vicinanza della fabbrica al lavoratore», aggiunge Sapelli, «il fatto di sapere che l’organizzazione in cui lavori pensa a te è fondamentale, non è affatto buonismo o paternalismo. Soprattutto in una società in cui l’anonia e il disordine sono prevalenti. Solo chi non ha mai lavorato in fabbrica scambia questo con il paternalismo».
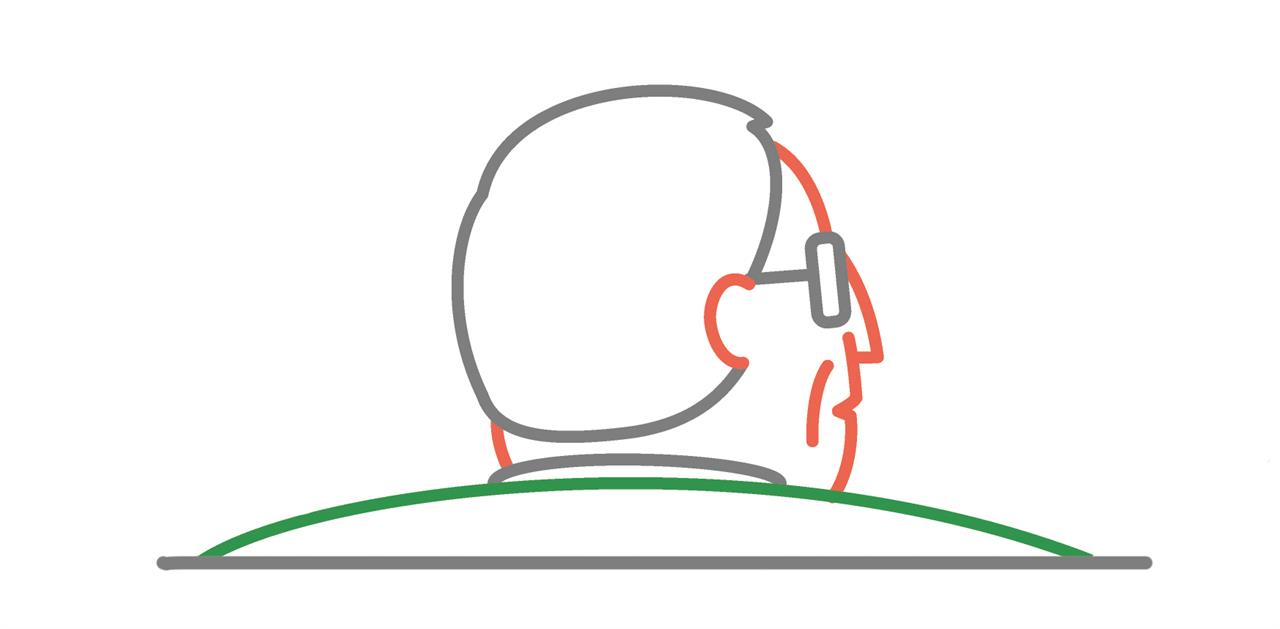
Giulio Sapelli, un Virgilio del Welfare Aziendale
Illustrazioni a cura di Jacopo Rosati
Testi e immagini a cura di Lorenzo Maria Alvaro
Montaggio e post produzione video a cura di Pietro Cedone
Vuoi accedere all'archivio di VITA?
Con un abbonamento annuale potrai sfogliare più di 50 numeri del nostro magazine, da gennaio 2020 ad oggi: ogni numero una storia sempre attuale. Oltre a tutti i contenuti extra come le newsletter tematiche, i podcast, le infografiche e gli approfondimenti.



