«I divieti di viaggio di Schengen non fermeranno l’immigrazione non bianca. Né lo farà l’apartheid in frontiera», spiega il giornalista e regista Gabriele Del Grande, autore del libro “Il Secolo Mobile – storia dell’immigrazione illegale in Europa”. Il racconto degli ultimi trent’anni in cui tre milioni e mezzo di viaggiatori senza visto hanno attraversato il Mediterraneo, mentre i corpi di altri cinquantamila giacciono tuttora sul fondo del mare mangiati dai pesci
È il racconto della prima storia dell’immigrazione illegale in Europa. Un lavoro dettagliato e meticoloso. Si chiama Il Secolo Mobile – storia dell’immigrazione illegale in Europa, (636 pagine, Mondadori). L’ha firmato il giornalista, scrittore e regista Gabriele Del Grande. Il suo è un libro che spazia dallo sbarco delle truppe africane a Marsiglia nel 1914 fino alla crisi delle organizzazioni non governative a Lampedusa, passando per il divieto di espatrio dal blocco comunista, la messa al bando dell’immigrazione non bianca, il crollo del muro di Berlino, il doppio cortocircuito dell’asilo e dei ricongiungimenti familiari e la stretta sui visti che dal 1991 alimenta il mercato nero dei viaggi. Del Grande ha lavorato per oltre dieci anni come reporter sul tema delle migrazioni tra Africa e Europa ed è esperto di migrazioni e guerre nel Mediterraneo. Nel 2006 ha fondato il blog Fortress Europe, il primo osservatorio europeo a fare luce sui naufragi dei migranti senza visto annegati lungo le rotte del contrabbando nel Mediterraneo. Il 9 aprile 2017 Del Grande è viene arrestato in Turchia, vicino al confine con la Siria, nel corso di un’intervista a un disertore dell’Isis. In seguito a una campagna di mobilitazione in Italia e all’interessamento del ministro degli Esteri, il 24 aprile 2017, dopo quindici giorni di detenzione, dei quali undici trascorsi in isolamento, viene liberato. Negli ultimi trent’anni hanno attraversato il Mediterraneo tre milioni e mezzo di viaggiatori senza visto, mentre i corpi di altri cinquantamila giacciono tuttora sul fondo del mare mangiati dai pesci. Come siamo arrivati fin qui? E soprattutto, come ne usciremo? Ecco come ha risposto Del Grande.
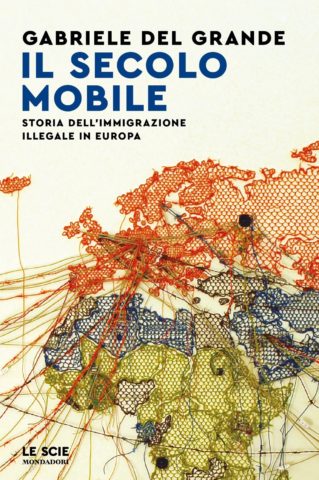
Come nasce e perché nasce Il secolo mobile – storia dell’immigrazione illegale in Europa?
In Italia, come in Europa, il dibattito sulle migrazioni è da anni incagliato in un vicolo cieco. Schiacciato sulle emergenze del tempo presente. Incapace di elaborare una narrazione alternativa al fuggono dalla fame e dalla disperazione. E troppo pavido per inseguire un’utopia sul lungo termine che non sia un generico appello alla solidarietà o un’autoconsolatoria campagna di sensibilizzazione sul dolore degli altri. Il secolo mobile è il tentativo di scardinare quel dibattito in due mosse. Da un lato inquadrando gli sbarchi nella prospettiva storica della progressiva illegalizzazione delle migrazioni non bianche che l’Europa persegue dai primi anni Ottanta. Dall’altro chiedendosi, dati alla mano, se la liberalizzazione dei visti non sarebbe paradossalmente la più efficace delle soluzioni.
Il libro è un lavoro minuzioso, dettagliato, molto corposo. Per chi l’hai pensato?
Apprezzo l’eleganza del non averlo definito un mattone. Cinquecento e passa pagine, senza contare le note, possono spaventare chi vive di slogan. Non chi ha la curiosità di imparare, mettere in crisi le proprie certezze e lasciarsi provocare da una certa idea di futuro. Il libro è per loro.
Qual è l’obiettivo finale? Cosa speri che capisca il lettore?
L’obiettivo è che intorno al libro si generi un dibattito. A partire dai miei pochi lettori. Ciascuno dei quali giunto all’ultima pagina avrà un buon motivo per non essere pienamente d’accordo con le mie tesi non allineate. Ma che al tempo stesso, dopo una serie di momenti eureka, avrà finalmente compreso la trama di questi ultimi quarant’anni di politiche frontaliere.
Nei ringraziamenti scrivi “Dietro a questo libro ci sono un decennio di storie raccolte sul campo, tre anni di studio matto e disperatissimo”. Quindi quanto è durata, complessivamente, tutta la stesura?
Ricerca e scrittura sono iniziate nell’estate del 2019. Ma non sarebbero state possibili senza quei dieci anni di viaggi trascorsi dalla mia prima visita in Marocco nel 2006 e il mio arresto in Turchia nel 2017. Altro ingrediente essenziale è stata la piena libertà di parola che l’editore mi ha assicurato e che non ho esitato a esercitare avendo imparato con l’età che all’auto-censura della militanza è di gran lunga preferibile la militanza della verità. Leggere per capire.
L’inizio del libro ci riporta in questo futuro che spesso percepiamo come lontano, invece è a un passo da noi. Scrivi: “Nel 2050 Cina e India guideranno per distacco la classifica dei paesi più ricchi del mondo davanti agli Stati Uniti e all’Unione europea. Indonesia, Brasile e Messico siederanno con loro al G7 e l’Unione africana festeggerà il suo terzo decennio ininterrotto di boom economico. Nel frattempo gli abitanti della Terra dagli 8 miliardi di oggi saranno arrivati a sfiorare i 10, per metà grazie all’esplosione demografica dei paesi a sud del Sahara nei quali, nel frattempo, saranno nati 1 miliardo di africani in più. La Nigeria da sola avrà 400 milioni di cittadini, tanti quanti l’intera Ue. D’altronde la popolazione europea, sempre più anziana e in declino, continuerà a diminuire fino a non rappresentare che il 5% di quella mondiale. L’umanità del futuro, infatti, vivrà per metà in Asia e per un quarto in Africa”. Perché facciamo così fatica a immaginarlo?
Fra trent’anni la sola Nigeria avrà più abitanti dell’Ue, India e Cina saranno più ricche degli Stati Uniti. In effetti cominciare un libro di storia con una carrellata di immagini dal futuro è inusuale. Ma prepara il lettore a guardare al passato dalla giusta prospettiva. Sapendo che nel mondo di domani il peso demografico, economico, culturale e politico dell’Europa sarà del tutto ridimensionato. Forse è per questo che facciamo fatica a immaginare la portata dei cambiamenti in arrivo. Perché significa ammettere la fine di un’egemonia, la nostra, sul pianeta.
Agli indesiderati di domani non rimarrà che continuare a viaggiare a rischio della propria vita. A meno che la prossima generazione non trovi il coraggio di estendere a tutti gli esseri umani il diritto a spostare il proprio corpo nel mondo
Gabriele Del Grande
I fatti che riporti sono tutti certamente fondamentali, ma ne possiamo evidenziare uno che più di tutti segna un punto di svolta, su tutto il fenomeno migratorio?
Forse l’adesione di Italia, Spagna e Grecia al trattato di Schengen. Era il 1990. Per entrare a far parte della futura area di libera circolazione, i tre soci euro-mediterranei dovettero adottare il codice dei visti di Francia e Germania che avevano da poco dichiarato lo stop all’immigrazione non europea. Per la mobilità tra le due sponde fu un punto di non ritorno. I viaggiatori dei ceti medi e popolari di Maghreb, Sahel e Turchia che sino ad allora si imbarcavano regolarmente sui voli per Roma con il solo passaporto ritirando all’arrivo il visto di tre mesi, dal 1991 si ritrovarono costretti a fare la fila davanti alle ambasciate. Salvo ricevere nella maggior parte dei casi un diniego. Fino a quando le mafie del contrabbando dei porti franchi del Mediterraneo, intuito l’affare, iniziarono a offrire loro il servizio di traghettamento senza visto. I primi a muoversi furono i contrabbandieri dell’Albania e del Marocco. Quindi fu la volta di Turchia, Ucraina, Libano, Siria, Egitto e Tunisia. E infine della Libia. Trentadue anni dopo la dinamica è ancora la stessa.
Scrivi: “La verità è che, come abbiamo già visto parlando dell’immigrazione in Europa, anche a livello globale esistono due popolazioni in movimento. Distinte l’una dall’altra per l’estrazione sociale, per il potere dei loro passaporti e per la capacità dei propri tratti somatici e dei propri simboli religiosi di passare più o meno inosservati una volta arrivati a destinazione. Stiamo parlando da un lato degli espatriati della classe media dei paesi ad alto reddito e prevalentemente bianchi del blocco occidentale: portatori di golosi denari e rassicurante bianchezza, liberi di circolare senza visti all’interno del mondo ricco e posizionati dalla parte egemone della linea del colore. Dall’altro, dei lavoratori dei ceti popolari dei rimanenti paesi a medio e basso reddito e prevalentemente non bianchi. Portatori di miseria e desiderio, di dei diversi e sospetta melanina. E per questo interdetti dall’ingresso nelle fortezze dorate dell’area euro-atlantica, bianca e cristiana, se non nella stretta misura dei necessari inservienti e dei loro ristretti familiari, purché per la sola durata del contratto di lavoro”. Insisto su questa parte perché, dati alla mano, diventa chiarissima e concreta l’espressione “due pesi, due misure”. Come usciamo da questo tunnel?
Già dai primi anni Duemila, mentre le correnti del cimitero Mediterraneo risputavano a terra i cadaveri rigonfi di migliaia di proletari arabi e africani indesiderati, a Bruxelles la Commissione lavorava all’abolizione dei controlli in frontiera con i paesi a est della vecchia cortina di ferro e alla liberalizzazione dei visti con gli Stati dei Balcani occidentali e dell’America Latina. Certo, la storica apertura a Est dei confini europei era la contropartita del processo d’integrazione del vecchio blocco orientale. Così come gli accordi per l’esenzione dei visti con i paesi a medio e alto reddito del Sudamerica erano il risultato di legami storici e imponenti progetti di partenariato economico. Tuttavia c’era e c’è tuttora dell’altro. Ed è la convinzione, neanche troppo celata, che l’Ue in pieno inverno demografico, non potendo fare a meno della manodopera immigrata, debba facilitare la mobilità dei gruppi etnici più facilmente assimilabili. A partire dalle popolazioni bianche e in larga parte cristiane dell’Est europeo e da quelle a maggioranza latina e cristiana del Sudamerica. Gli emigranti in arrivo da quelle aree dopotutto condividono la fede, i valori e il vincolo di appartenenza etnica all’Europa bianca occidentale. E quella comunanza identitaria con i locali rende la loro adesione all’etica, e dunque al destino, delle nazioni europee molto meno problematica. Senza parlare del fatto che, essendo sostanzialmente identici ai nativi dal punto di vista somatico, non verranno eternamente percepiti come corpi estranei. Il che è l’esatto contrario di quanto accade da decenni con l’immigrazione nera, musulmana e asiatica, i cui discendenti, a distanza di due o tre generazioni dall’arrivo dei propri avi in Europa, per quanto possano essere perfettamente inseriti nella società continuano a essere visti come corpi di troppo. Tanto più dopo i due decenni dell’islamismo militante e della guerra al terrore.
Perché facciamo ancora così fatica a guardare al continente africano come una ricchezza?
Perché all’esplosione demografica del continente africano corrispondono le culle vuote della flaccida Europa. Così come al fermento culturale ed economico della gioventù a sud del Sahara corrisponde l’ansia da fine impero delle anziane popolazioni europee. Mantenere in piedi il racconto dell’Africa come eterna sconfitta aiuta a vivere di nostalgia. Forse è per questo che quel racconto fuori tempo massimo continua ad essere strenuamente difeso. Sia da chi in nome della purezza del sangue, o più sobriamente dell’identità, chiede a gran voce di respingere i miserabili che si accalcano alle porte della civile Europa. Sia da chi dalle opposte tribune ma col medesimo sguardo sfocato invoca, nel nome di una generica bontà, la concessione dell’asilo politico e dell’assistenza sociale a chiunque riesca a scampare all’inferno. Come se il mondo a sud del Sahara fosse rimasto fermo ai devastanti anni Novanta.
I divieti di viaggio di Schengen non fermeranno l’immigrazione non bianca. Né lo faranno l’apartheid in frontiera e i rigurgiti identitari fuori tempo massimo
Gabriele Del Grande
Nel libro parli di apartheid in frontiera. Come lo spiegheresti? E soprattutto cosa dobbiamo fare oggi per superarlo domani?
I morti nel Mediterraneo non sono bianchi. Così come non lo sono le viaggiatrici stuprate dalle milizie libiche al soldo di Roma, i passeggeri sbattuti giù dai treni dalla polizia di frontiera a Ventimiglia, o le persone fermate nelle nostre città per un banale controllo di documenti e portate via da una volante per poi essere rinchiuse nei centri di detenzione, caricate coi polsi legati sul primo aereo e rispedite come vuoti a rendere dall’altra parte del mondo. Per dirla con Mbembe (filosofo, africanista e storico camerunese ndr), il confine abita le strade delle nostre città. Le nostre scuole. I nostri luoghi di lavoro. La nostra movida. Ha il colore dei corpi degli afro-discendenti, i tratti somatici degli asiatici, i copricapo delle donne musulmane e la stessa medesima colpa. Quella di avere abbandonato le riserve senza l’autorizzazione dell’uomo bianco. E di minacciare anche soltanto con la loro presenza la il presunto primato dei popoli europei. Come uscirne? La mia proposta è la liberalizzazione dell’immigrazione non bianca. Partendo da un assunto. Che per quanto il regime dei visti abbia trasformato la mobilità in un percorso a ostacoli, la frontiera è sempre rimasta aperta. Il grande equivoco sta tutto qui. I divieti di viaggio non hanno fermato i flussi. Né li hanno particolarmente contenuti. Li hanno semplicemente dirottati sui canali illegali. Al prezzo di 50 mila e passa morti. Al cospetto dei quali è giunto il momento di decidere se la mobilità internazionale nel XXI secolo debba continuare a essere un privilegio appannaggio dei cittadini bianchi dei paesi ad alto reddito. O se invece deve essere riconosciuta come un diritto fondamentale. Per tutti. Quanti emigranti tenterebbero la sorte in Europa a quel punto? Nel libro provo a rispondere. E vi assicuro che c’è di che sorprendersi.
Quindi, alla fine che mondo verrà?
I divieti di viaggio di Schengen non fermeranno l’immigrazione non bianca. Né lo faranno l’apartheid in frontiera e i rigurgiti identitari fuori tempo massimo. Per il semplice fatto che i più continueranno ad attraversare legalmente il confine. Vedendosi riconosciuto il diritto inalienabile al ricongiungimento familiare con i pionieri dell’immigrazione illegale. Ovvero quei 3 milioni e mezzo di avventurieri, in gran parte africani, che tra gli anni Novanta del secolo scorso e i primi anni Venti di questo hanno osato buttare i propri corpi al di là delle fosse comuni del cimitero Mediterraneo facendosi beffe della schizofrenia delle leggi europee in materia d’asilo. Nel frattempo, con tutta probabilità, l’invenzione dell’Africa come stato d’eccezione avrà cessato di esistere nell’immaginario europeo finalmente decolonizzato. Vuoi perché ogni abitante della riva nord del Mediterraneo avrà almeno un parente alla lontana sull’altra sponda. Vuoi perché la nuova ricchezza del continente africano e la fama delle sue icone pop globali avranno redento le ataviche colpe dei neri. Gli unici neri del futuro rimarranno i poveri. Il razzismo rientrerà nei recinti del classismo. Svestite le maschere bianche e abbandonato il discorso sulla razza, la nuova e multicolore classe media europea si limiterà a odiare i poveri in quanto tali. E continuerà a fare di tutto per tenerli lontani dalla fortezza dorata. Agli indesiderati di domani non rimarrà allora che continuare a viaggiare di nascosto e a rischio della propria vita. A meno che la prossima generazione cosmopolita e transnazionale non trovi il coraggio di estendere a tutti gli esseri umani il diritto a spostare il proprio corpo nel mondo.
Gabriele Del Grande ha lavorato per oltre dieci anni come reporter sul tema delle migrazioni tra Africa e Europa. Nel 2006 ha creato il primo osservatorio sulle vittime della frontiera, Fortress Europe. Da allora ha condotto ricerche in una trentina di paesi tra le due sponde del Mediterraneo e il Sahel, realizzando numerosi reportage per la stampa italiana e internazionale. È co-regista del film Io sto con la sposa (2014) e autore di diversi libri, tradotti anche in spagnolo e in tedesco. Per Mondadori ha pubblicato Dawla. La storia dello Stato islamico raccontata dai suoi disertori (2018).
Credit foto apertura LaPresse
Scegli la rivista
dell’innovazione sociale
Sostieni VITA e aiuta a
supportare la nostra missione
Vuoi accedere all'archivio di VITA?
Con un abbonamento annuale potrai sfogliare più di 50 numeri del nostro magazine, da gennaio 2020 ad oggi: ogni numero una storia sempre attuale. Oltre a tutti i contenuti extra come le newsletter tematiche, i podcast, le infografiche e gli approfondimenti.

