«Forse dovete impegnarvi a lasciarci essere i ragazzi che siamo», dice Rakel rassegnata davanti al parterre delle buone occasioni: preside, psicologo e assistente sociale schierati. In Tutti gli eroi che conosco (Mondadori) ti ritrovi sbalzato senza paracadute tra gli adolescenti di oggi. In mezzo a parole piuma e parole pietra. È un romanzo duro, durissimo, ma sembra proprio di essere lì, dentro le aule, nelle piazze e sulle panchine con loro. Lo ha scritto Michele Arena, educatore alla cooperativa sociale Macramè, che nel 2010 a Campi Bisenzio, in provincia di Firenze, ha avviato il progetto Porto delle Storie. È una scuola di scrittura non profit itinerante per adolescenti di 11-18 anni, nata con l’obiettivo di creare degli spazi di libertà, i ragazzi possano scrivere senza la paura dei voti o del giudizio degli altri. «Ogni essere terrestre o marino che entra al Porto delle Storie ha il diritto di scrivere indipendentemente dal paese di provenienza, età, sesso, genere, lingua parlata, gusti musicali e voti in pagella» è la regola base. Nell’introduzione al volume che i ragazzi hanno scritto l’anno scorso, intitolato Fuori dal cassetto, si legge così: «Potrebbero esserci errori e refusi, abbiamo cercato di correggere il meno possibile le storie, perché al Porto gli errori fanno parte del viaggio per imparare a scrivere». E anche: «Molte parti di questo libro sono state scritte su cellulari o tablet ascoltando musica intervallata da partite di Brawl Stars». Con buona pace dei benpensanti.
«Io ho fatto un professionale, ho preso 38 alla maturità, se ci fosse stata l’etichetta della povertà educativa io e la mia famiglia l’avremmo avuta», racconta Michele. «Il mio percorso mi ha fatto guardare al lavoro nel sociale con uno sguardo diverso, lo sguardo di chi proviene da questi contesti. Invece spesso nei progetti sociali si fa tanta riduzione del danno e poi, solo poi, si prova a fare quello che diceva Danilo Dolci, cioè sognare i ragazzi in modo diverso».
Il sogno di Michele allora qual è? Rispondere ad una scuola inaccogliente (per non dire esplusiva) immaginando un’altra scuola. Tutti gli eroi che conosco così racconta, in forma di romanzo, la nascita della scuola di scrittura del Porto delle Storie. Di un gruppo di ragazzini con background migratorio che «entrano in aula con la promessa che la scuola sarà lo strumento che gli permetterà di realizzare i loro sogni» e invece si scontrano con una realtà «che li spinge verso un’altra direzione, quella della mediocrità, perché sono nati in un posto che non è quello giusto, non parlano la lingua giusta, non hanno una famiglia considerata giusta né i codici culturali giusti. Non è un caso che in Italia si laurea solo il 6% di ragazzi che hanno genitori senza titolo di studio, che nei professionali ci sia uno studente con disabilità o Bes ogni 15 alunni e al classico solo uno ogni 134», afferma Arena.
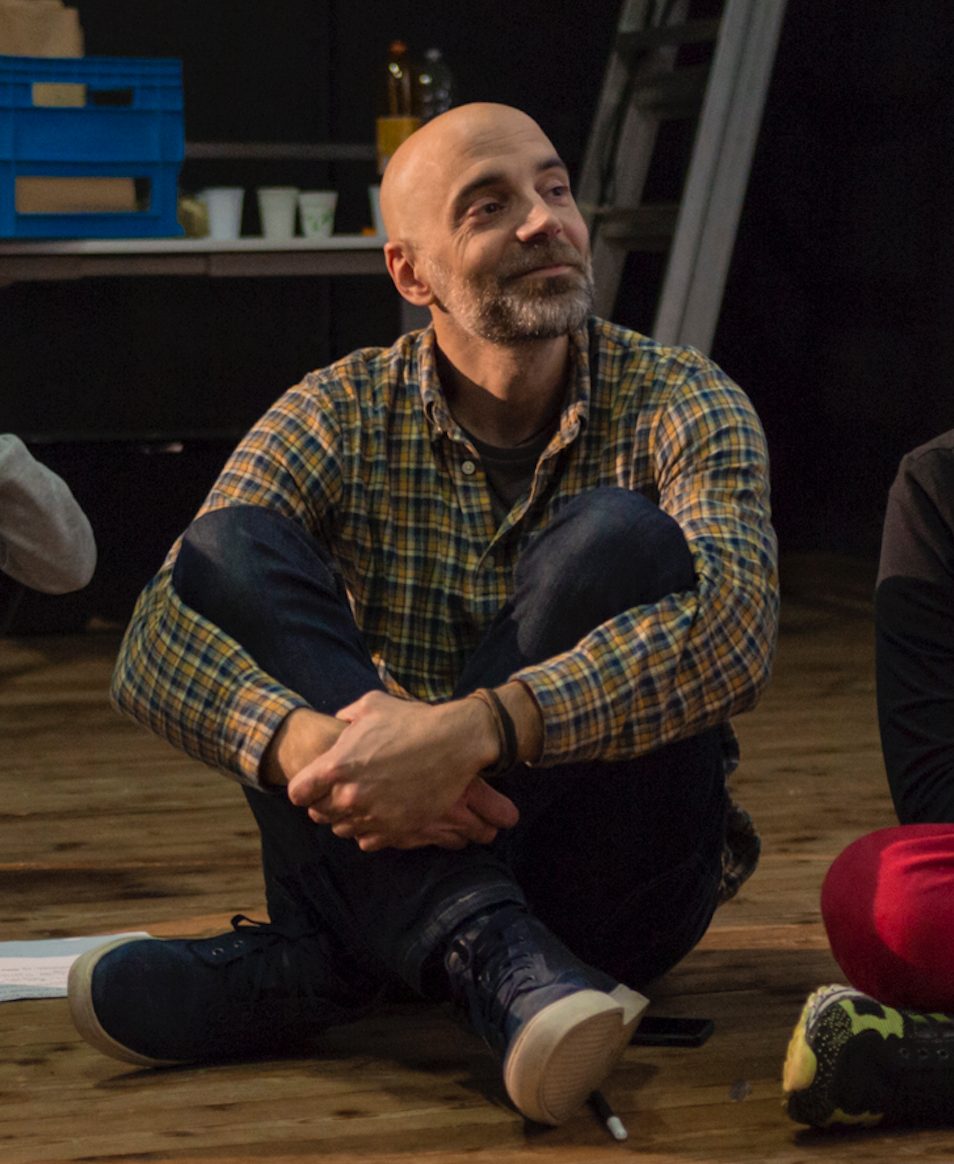
Invece di spaccare tutto, questi ragazzi aprono una scuola pomeridiana di scrittura dentro una lavanderia a gettoni, in cui accolgono i piccoli del quartiere. La dedicano a Buzz Aldrin, il secondo uomo arrivato sulla Luna, quello di cui nessuno si ricorda mai e che ha sofferto di depressione una volta tornato sulla Terra. Buzz è il diminutivo di Buzzer, cioè il nome con cui la sorellina lo chiamava da piccola, quando per via di un difetto di pronuncia non riusciva a dire bene la parola brother. «È bello che non l’ha presa in giro per il suo errore», dice Mario, che è il personaggio preferito di Michele. Io invece ho adorato Rakel. In una delle ultime pagine, c’è la lettera che nonna Dorina, dall’Albania, scrive a Zanushe: «Tutti gli eroi che conosco hanno meno di 18 anni».
Partiamo dal fatto che riesce a restituire con una vividezza incredibile le parole, le emozioni, i pensieri e il linguaggio degli adolescenti. Come c’è riuscito?
Io vivo con i ragazzi, lavoro con adolescenti per la maggior parte tempo del mio tempo: non è stata una cosa studiata, l’ho assorbito da loro. Quello che però volevo è che la scrittura mantenesse quell’aspetto di follia e di sogno che c’è nella nascita del Porto delle Storie.
Facciamo un passo indietro: chi è Michele Arena?
Il mio percorso è particolare. Ho cominciato a fare l’educatore una ventina di anni fa, senza particolari titoli studio: mi sono laureato l’anno scorso in scienze dell’educazione con una tesi sulle dinamiche di potere in educare. Io vengo da un contesto non di agio, sono cresciuto in una casa popolare, in un quartiere periferico di Firenze, in una famiglia con difficoltà economiche. Se ai tempi ci fosse stata l’etichetta della povertà educativa, l’avremmo avuta di sicuro. Sono arrivato a fare l’educatore nel 2004, a 26 anni: prima facevo l’allenatore e ad un certo punto sono finito a lavorare al centro diurno per adolescenti di Macramé. Ho fatto un istituto professionale, non andavo bene a scuola: questo aspetto mi ha portato a guardare il lavoro nel sociale con lo sguardo di chi proviene da questi contesti, con una “rivendicazione di classe” se vogliamo. Spesso invece nei progetti sociali si fa tanta riduzione del danno e poi, solo poi, si prova a fare quello che diceva Danilo Dolci, cioè sognare i ragazzi in modo diverso.
La voce di chi ha fatto esperienza di povertà non arriva ai tavoli dove si fa ricerca o dove si decidono le politiche. Questo inficia le narrazioni. La conseguenza è che si tende a dare risposte primarie: per esempio tamponare l’abbandono scolastico, non ambire a portarli alla laurea
Perché questo punto prospettico è importante?
Perché i poveri non arrivano a fare ricerca. E questo inficia le narrazioni. Su tante altre dinamiche di discrimianzione e oppressione, gli esponenti di altre minoranze hanno fatto sentire la propria voce, condizionando il racconto: il punto di vista delle donne, dei neri in America, delle persone Lgbtq. La voce di chi ha fatto esperienza di povertà invece continua a non arrivare ai tavoli dove si fa ricerca o dove si decidono le politiche. La conseguenza è che in tanti progetti si tende poi ad “abbassare” il livello, dando risposte primarie ma senza alzare il tiro: con i ragazzi, per esempio, si punta a tamponare l’abbandono scolastico ma non si ambisce a portarli alla laurea.

Quando dice che se fosse esistita l’etichetta di “povertà educativa” la sua famiglia l’avrebbe avuta… lo fa con una vena critica?
La povertà educativa per me è un’espressione controversa. Nel libro c’è un passaggio su questo, con l’assistente sociale che sciorina parole «che per noi non hanno alcun senso» ed elenca progetti. «Improvvisamente scopriamo l’esistenza di un servizio di assistenza scolastica per studenti che vivono, come dice lei, una situazione di povertà educativa». I ragazzi rispondono che «solo il nome ti fa pensare di essere uno con un problema» e che «stiamo bene qui dove non c’è nessuno che ci fa sentire un problema usando parole come disagio o povertà educativa». Penso che questa espressione andrebbe usata con cautela, perché mi pare che vada a sminuire le risorse educative che in questi nuclei familiari esistono, anche se sono diverse da quelle che abbiamo in mente noi. Mi concentrerei di più sul tema della povertà economica, che impatta tantissimo sulle traiettorie scolastiche dei ragazzi.
«Dentro la scuola ci sono tutte le parti di noi che non vanno». «La nostra lavanderia non era un posto per quelli che stanno male, ma quando qualcuno stava male non facevamo finta di niente come a scuola». È davvero un tale disastro la nostra scuola?
Noam Chomsky nel suo Dis-educazione. Perché la scuola ha bisogno del pensiero critico dice una cosa che io sentivo ma che lui esprime molto bene: dice che la scuola incarna sia l’ideologia dominante sia la possibilità di lotta. La scuola è entrambe le cose e i ragazzi quindi vivono entrambe le cose. Ragazzi come quelli del libro arrivano a scuola con la promessa che la scuola è strumento che li emanciperà e gli farà realizzare i loro sogni, ma la scuola si rivela poi quella che li spinge verso una direzione di mediocrità, perché sono nati in un posto che non è quello giusto, non parlano la lingua giusta, non hanno i codici culturali giusti, hanno una famiglia che non è considerata giusta. Così vivono un tradimento del patto educativo. Nella testa delle persone c’è l’idea che con la scuola tu ti puoi realizzare, ma questo è vero solo per una parte della popolazione. Questa rottura del patto educativo per alcuni porta a reazioni che vengono etichettate come abbandono, disagio.
L’espressione povertà educativa andrebbe usata con cautela, perché va a sminuire le risorse educative che in questi nuclei familiari esistono, anche se sono diverse da quelle che abbiamo in mente noi. Mi concentrerei di più sul tema della povertà economica
Cosa la preoccupa?
A me preoccupa molto l’aspetto della diseguaglianza, il fatto che le bocciature tra gli studenti con cittadinanza non italiana siano tre volte più alte che fra gli italiani, che i professionali si facciano carico di tutti gli studenti fragili, con uno studente con disabilità ogni 15 iscritti mentre al classico sono uno ogni 134. Questo ci dice che nella nostra scuola c’è un tema di disuguaglianze forte, che è intersezionale: ed è un aspetto strutturale.
I ragazzi, nel libro, di fronte a tutto questo discutono ma alla fine tra l’ipotesi di bruciare tutto e quella di fare una scuola, scelgono di fare una scuola. Perché?
Perché come dice Paulo Freire, se sei un oppresso non devi aspettare che sia l’oppressore a salvarti. Il ruolo di un educatore e di un insegnante è creare per te spazi di libertà in cui tu puoi prendere parola, che è quello che abbiamo fatto con il Porto delle Storie. Spazi in cui la voce dell’adulto non è mai dominante ma è solo sostegno alla voce degli adolescenti. Sono loro a decidere di cosa parlare nei loro libri. Quelli che scrivono ogni anno sono libri in cui loro autori e noi editor, cercando di non contaminare il loro stile. Vanno loro a presentarli, sono loro a raccontare perché hanno fatto alcune scelte narrative e non altre. È questa la condivisione del potere. E io adulto devo provare a cederne pezzi.

Cos’è Porto delle Storie, detto in sintesi da lei?
Porto delle Storie è uno scopiazzamento riuscito bene di “826 Valencia”, la scuola di scrittura creativa non-profit fondata a San Francisco dallo scrittore Dave Eggers. Quello era uno spazio pomeridiano in cui i bambini che parlavano ingelse come seconda lingua andavano a fare i compiti e a scrivere. Noi lo abbiamo fatto a Campi Bisenzio. Invece di aprire la scuola in un negozio di pirati o in una lavanderia a gettoni, come racconta il libro, l’abbiamo aperta all’interno del centro per adolescenti di Macramé. I ragazzi vengono a fare i compiti due o tre giorni a settimana e poi un giorno a settimana fanno con noi il laboratorio di scrittura: noi non abbiamo messo l’aggettivo “creativa”. Questo è l’accordo. Vengono volentieri, perché è uno spazio di libertà. La proposta è partita nel 2014 e poi ha contaminato alcune biblioteche del territorio che oggi ospitano l’esperienza: complessivamente abbiamo circa 150 ragazzi l’anno. I temi sono vari, c’è chi scrive di fortnite e chi anoressia… Negli ultimi anni sicuramente il tema della salute mentale è esploso, i ragazzi stanno raccontando tante storie di depressione, di disturbi alimentari, temi che dieci anni fa non erano così centrali. Credo che sia cresciuto il problema ma anche la voglia di parlarne, sono due cose che si alimentano a vicenda. Io racconto sempre di Luca, che ha fatto il laboratorio di scrittura con noi cinque anni fa e ha scritto una storia in cui delle bottiglie di alcolici picchiavano le bottiglie di succhi di frutta. Una storia di bullismo. Quell’anno venne bocciato a scuola. Per lui fu un trauma. Alla presentazione del libro, la giornalista – senza sapere nulla – disse che la storia che l’aveva più colpita era proprio quella di Luca: per lui è stato importantissimo. Lo ha fatto sentire forte, competente. Ancora viene a trovarci. È questo il senso: riparare le fratture che i nostri adolescenti incontrano nella vita.

La scrittura allora cosa fa? Salva?
Non so se salva: a volte sì, a volte no. Sarei più concreto. Il punto di partenza per noi è il fatto che la scrittura è un diritto. I nostri non sono laboratori di scrittura creativa, perché se aggiungi quell’aggettivo lasci intendere che la scrittura sia qualcosa che serve per scrivere i libri o per fare arte. No, la scrittura ti serve per trovare lavoro, per confessare i tuoi sentimenti alla persona che ami, per sciogliere un conflitto. Forse non salva, ma sicuramente è fondamentale. Chi riesce a maneggiare questa cosa, avrà una vita migliore.
Non so se la scrittura salva: a volte sì, a volte no. Sarei più concreto. Il punto di partenza per noi è il fatto che la scrittura è un diritto. Chi riesce a maneggiare questa cosa, avrà una vita migliore
Prima parlava della necessità di cedere potere ai giovani. Facile a dirsi, difficile a farsi. Come cooperativa e al Porto come lo avete fatto?
Di partecipazione giovanile parliamo tutti, ma poi nei fatti… Io credo che la partecipazione debba permeare tutta l’azione educativa: se cedi potere lo cedi in maniera coerente. In cooperativa abbiamo fatto tanta autoformazione all’inizio e poi una formazione costante agli operatori nuovi che arrivano. Formazione in particolare su come si crea uno spazio di non giudizio, su come tenere una postura orizzontale, su quali parole e frasi non usare. Ci spendiamo molto tempo. lI punto è che la partecipazione giovanile non è tanto uno strumento per fare un progetto più bello: deve essere l’obiettivo. L’obiettivo è dare spazi di decisione agli adolescenti.
Spesso gli adulti lamentano di non capire gli adolescenti e viceversa.
Gli adolescenti spesso non hanno voglia di parlare con adulti perché percepiscono che tutto è già deciso. Allora, perché sperdersi? Dobbiamo iniziare a dire le decisioni non sono già prese. Questo nei laboratori di scrittura lo chiariamo subito, non c’è uno spazio predeterminato, ma uno spazio che costruiamo insieme. Ovviamente non funziona subito perché i ragazzi non ci sono abituati.

Il titolo del libro riprende la frase che nonna Dorina, dall’Albania, scrive a Zanushe: «Tutti gli eroi che conosco hanno meno di 18 anni». Che vuol dire?
Il concetto che i ragazzi vogliono trasmettere non è quello di un eroe alla Marvel o con un significato etico: vuol dire “cari adulti, ricordatevi quanto è complesso crescere in un ambiente come quello della scuola, come è difficile essere adolescenti”. Come mai tutti viviamo l’adolescenza in termini conflittuali e poi da adulti riproduciamo quelle stesse cose che ci hanno fatto soffrire?
Il libro mette a tema in maniera esplicita la questione dell’errore. «Siamo fatti all’80% di errori, perché allora vogliamo essere solo il 20% di ciò che siamo?», si chiede. Però non è che questa enfasi sull’errore – esplicitata e messa a tema al punto che c’è si moltiplicano le “scuole dell’errore” e del fallimento, intesi nella loro valenza pedagogica – rende poi difficile chiedere ai ragazzi di “dare il meglio”?
A nostra discolpa possiamo dire che il tema dell’errore quando abbiamo avviato la scuola non era così diffuso… Ma anche qui, se non diventa metodo educativo quotidiano, non è trasformativo. Non serve creare una scuola dell’errore ma far sì che nella scuola – nella didattica e nella valutazione – l’apprendimento dall’errore non sia condannato, ma sostenuto. Buzz Aldrin è questo: prende una cosa sbagliata e lo porta a ottenere di più. Io ho preso 38 alla maturità. A me capita di fare errori di grammatica, ma nessuno si appoggia sui miei errori per dire “tu non puoi parlare”. La differenza sta qui. Il potere è come trattiamo gli errori degli altri.
Le foto dei laboratori di Porto delle Storie sono state inviate dall’intervistato.
Cosa fa VITA?
Da 30 anni VITA è la testata di riferimento dell’innovazione sociale, dell’attivismo civico e del Terzo settore. Siamo un’impresa sociale senza scopo di lucro: raccontiamo storie, promuoviamo campagne, interpelliamo le imprese, la politica e le istituzioni per promuovere i valori dell’interesse generale e del bene comune. Se riusciamo a farlo è grazie a chi decide di sostenerci.



