La fotografia di ciò che accade quando uno stabilimento si addentra sul sentiero di una crisi: i lavoratori che restano a casa, gli edifici che si svuotano e la produzione che si trasferisce altrove. Ci vuole coraggio a raccontare la parte negativa delle storie. Secondo Mario Calderini, portavoce di Torino Social Impact, ecosistema di oltre 360 attori per l’imprenditorialità e gli investimenti a impatto sociale, «questa città ha uno straordinario patrimonio di cattive esperienze da cui imparare, perché i fallimenti sono lezioni preziose». Lo ha detto nella prima tappa dell’itinerario giornalistico che VITA sta compiendo nell’impatto sociale (si legge qui), un ottimo spunto per proseguire il viaggio. La valutazione di impatto della chiusura di due stabilimenti industriali presentata la scorsa settimana a Torino si muove proprio in questa direzione: un lavoro di analisi innovativa fortemente voluto da Fiom Cgil, finanziato dalla Camera di commercio nell’ambito di Torino Social Impact e realizzata dal CeVIS, il Centro di competenze per la misurazione e valutazione dell’impatto sociale.
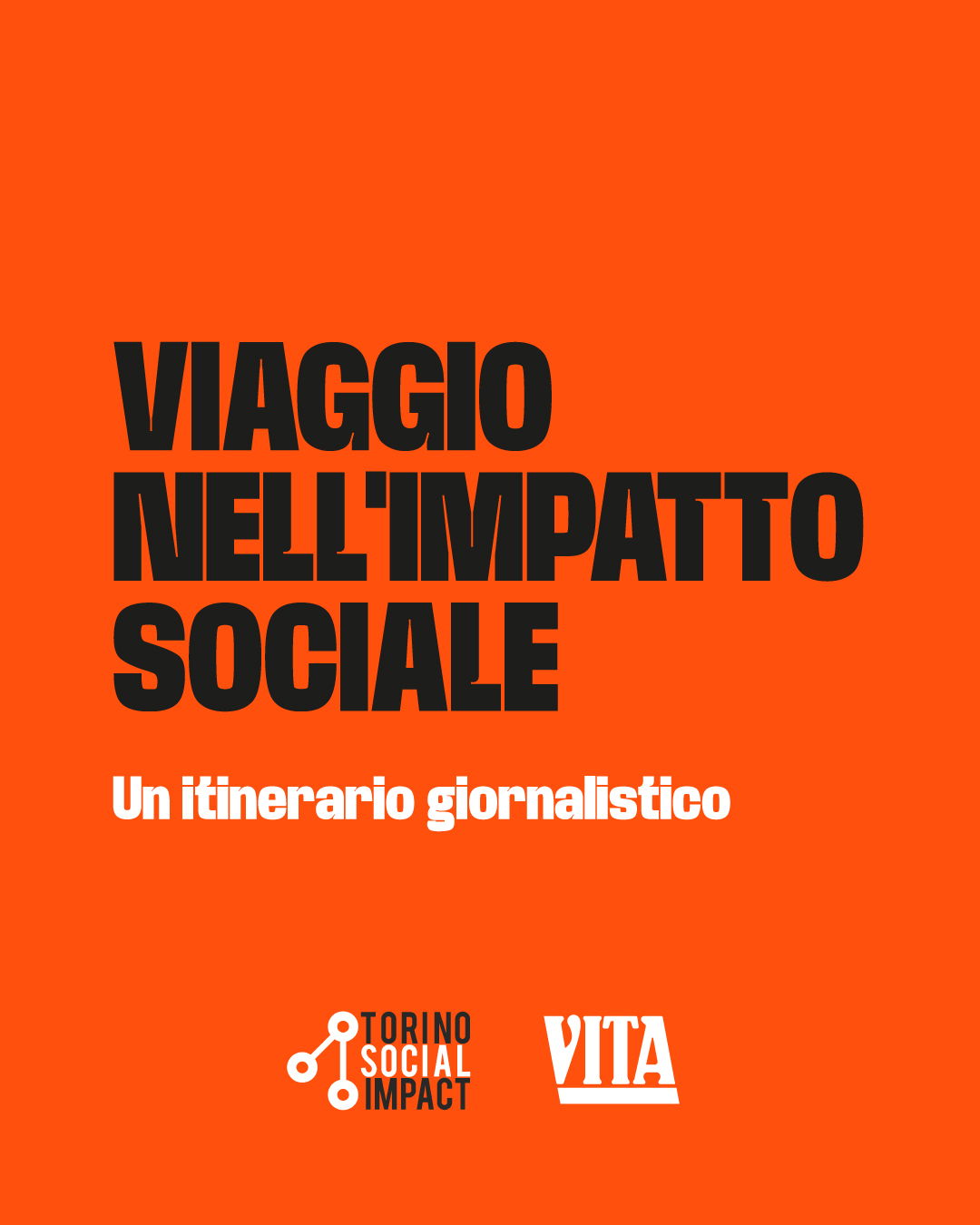
Ribaltare l’approccio
C’è una premessa fondamentale prima di leggere questo studio. «Siamo abituati a pensare all’impatto come al valore aggiunto generato da un’azione, cerchi concentrici di effetti positivi. Qui l’oggetto di indagine è esattamente l’opposto: calcoliamo l’impatto in negativo». Lo spiega Marella Caramazza, direttrice strategica del CeVIS che, grazie a un accordo tra la Camera di commercio e la Fondazione Cottino, ha sede al Cottino Social Impact Campus. «Sta proprio qui l’elemento di innovazione: applicare lo stesso framework concettuale per valutare l’impatto negativo generato dalla chiusura di due grandi stabilimenti, Lear Corporation a Grugliasco e Te Connectivity a Collegno».
Sotto la lente di ingrandimento ci sono due realtà storiche piemontesi, ma il fine ultimo non riguarda soltanto la cintura torinese: «Consiste nella costruzione di un modello che possa servire all’azione sindacale, alle istituzioni e ai territori per affrontare la gestione di future procedure di crisi, grazie alla definizione di una serie di elementi con cui prevenire, monitorare e se possibile riparare l’impatto negativo». La vera forza del progetto, continua Caramazza, «è nell’approccio indipendente, la chiave per dare al metodo gambe per poter essere utilizzato anche altrove».
I numeri
Una chiusura non è soltanto un fatto economico, è un evento traumatico che tocca le vite e il futuro di centinaia di persone: i dipendenti, le loro famiglie e l’intero tessuto socioeconomico. Le due vicende selezionate per effettuare l’indagine coinvolgono in modo diretto 600 persone: 380 dipendenti Lear, 220 Te Connectivity.

Ci sono alcuni dati che saltano subito all’occhio nella prima analisi di contesto. Il 45% dei dipendenti Lear e il 37% di Te Connectivity appartengono a famiglie monoreddito: perdere il lavoro per loro significa non avere più la fonte di sostentamento principale. Questa situazione si è già tradotta in effetti concreti: il 75% dei lavoratori Lear e il 52% di quelli di Te Connectivity hanno dichiarato una riduzione della capacità di spesa, il 36% del totale segnala sintomi di ansia o depressione e il 40% ha manifestato segnali di un isolamento crescente.
Un’analisi in quattro tappe
«A partire dall’osservazione di dati empirici, raccolta di storie e vissuti, interviste a opinion leader e stakeholder, abbiamo esaminato gli impatti su quattro categorie di soggetti: dipendenti e famiglie, fornitori e indotto, istituzioni e comunità, mercato del lavoro», spiega Caterina Rosini che ha curato la ricerca.

I primi interlocutori sono stati i dipendenti degli stabilimenti e le loro famiglie. Non hanno subìto soltanto una perdita di reddito, ma anche un drastico cambiamento delle condizioni di vita e delle prospettive future. Il CeVIS evidenzia impatti in cinque aree chiave, misurati attraverso specifici indici. Il 75% dei dipendenti Lear e il 52% di quelli Te Connectivity hanno segnalato difficoltà economiche significative, il 36% ha dichiarato sintomi di ansia e depressione, mentre il 40% degli intervistati ha ridotto la partecipazione a eventi sociali e comunitari, mostrando quanto il capitale relazionale venga messo a rischio da una crisi industriale. La fiducia nelle istituzioni è scarsa (due dipendenti su tre dichiarano di non sentirsi tutelati) e soltanto il 12% delle persone che hanno risposto al questionario mostra una buona adattabilità al cambiamento, si considera facilmente reimpiegabile e ha avviato percorsi di formazione. Tutto ciò si traduce in maggiore vulnerabilità economica per le famiglie monoreddito, rischio di disoccupazione prolungata soprattutto per gli over50, impatti sulla salute mentale e fisica con aumento dello stress e della precarietà emotiva e difficoltà di ricollocamento per chi ha competenze altamente specializzate nel settore automotive.
Collegno e Grugliasco, due aree con una forte tradizione industriale, si trovano ora ad affrontare nuove sfide, che potrebbero avere effetti di medio-lungo periodo sul tessuto produttivo e sulla coesione sociale. Oltre all’impatto immediato sulla disoccupazione e sul sistema delle imprese locali, la crisi ha evidenziato la difficoltà delle amministrazioni locali di intervenire in modo efficace: i sindaci delle due città hanno segnalato una scarsa capacità di azione diretta sulle chiusure aziendali e il rischio di un aumento della pressione sui servizi sociali, oltre al fenomeno della scheletrizzazione industriale.

La perdita di posti di lavoro stabili e qualificati si inserisce in un contesto già fragile, caratterizzato da difficoltà di reinserimento, da un aumento della precarizzazione e da una ridotta capacità di assorbimento del tessuto economico locale. «Per comprendere meglio questi effetti, ci siamo concentrati su un caso studio emblematico», aggiunge Caramazza: «un’azienda reale che ha assunto tre dipendenti Lear, con le caratteristiche tipiche del modello diffuso sul territorio, ovvero medie dimensioni e un business coerente con la vocazione metalmeccanica dell’area. Ne è emerso il quadro di un mercato del lavoro che è abbastanza reattivo nei confronti delle crisi ma anche frammentato e con un potenziale di assorbimento limitato. Questo processo non è guidato né accompagnato. Se non si interviene con politiche attive, il mercato del lavoro locale rischia di perdere risorse professionali strategiche e di accentuare il problema del precariato».
L’analisi si è estesa all’indotto e ai fornitori, «anche se non tutti si sono resi disponibili. La maggior parte di loro ha già sviluppato strategie di adattamento. I meno colpiti sono quelli che si sono mostrati più agili e veloci a cambiare, mentre i fornitori più a rischio sono quelli monocliente, che dipendono in modo significativo dalle commesse degli stabilimenti in crisi».
Strategie per il futuro
La valutazione non si ferma all’analisi, ma immagina una serie di strategie per rispondere in modo nuovo a situazioni che si ripetono da anni, soprattutto nel Torinese. «Un anno fa abbiamo individuato queste due vicende perché in quel momento erano emblematiche di quello che stava accadendo sul territorio», spiega Federico Bellono, segretario generale Cgil Torino. «Erano le prime avvisaglie di una fase di depressione industriale che oggi viviamo in maniera più drammatica, dovuta a una molteplicità di cause, dalle incertezze a livello globale alla crisi del settore automotive. Si tratta di due stabilimenti diversi che si differenziano per competenze, età media dei dipendenti e tipo di produzione. Questa sperimentazione può diventare uno degli strumenti dell’azione sindacale: ci permette di andare oltre a una visione ordinaria degli effetti della crisi e degli strumenti a disposizione, e di assumere una prospettiva più ampia sulle responsabilità e sui contributi che i diversi soggetti possono dare alla soluzione di vicende di questa natura».
Il CeVIS definisce questi due casi «un banco di prova per il futuro dell’occupazione industriale in Piemonte. Senza una strategia chiara e condivisa, il rischio è quello di una progressiva perdita di competenze e di un aumento della vulnerabilità occupazionale». Secondo Caramazza, «la chiusura genera un pattern specifico: dismissione industriale decisa da una multinazionale che riassesta il suo modello a cui segue un impatto sui quattro ambiti che abbiamo indicato. Se non gestito, deteriora le capacità soggettive e collettive di ripresa economica. Si rompono i legami nella società, si genera frammentazione e incominciano a emergere comportamenti opportunistici di convenienze soggettive e di breve periodo: si adotta una visione emergenziale senza costruire una traiettoria». In questo modo l’impatto negativo non può che crescere: «Bisogna evitare di farsi travolgere, altrimenti ci si ritrova in un sistema incapace di invertire la tendenza sia da un punto di vista strutturale che emotivo».
Che cosa ci insegna questa valutazione? «Che il tempo è una risorsa ma non infinita. Che sarebbe utile creare percorsi di transizione delle competenze attraverso misure di supporto alla formazione e di accompagnamento. Che non esiste un archivio di dati su questi temi ed è per questo che abbiamo iniziato a costruire un database».
In apertura, una manifestazione davanti ai cancelli della Te Connectivity (la fotografia è di Fiom Cgil). Le fotografie nel testo sono state fornite dagli intervistati
Si può usare la Carta docente per abbonarsi a VITA?
Certo che sì! Basta emettere un buono sulla piattaforma del ministero del valore dell’abbonamento che si intende acquistare (1 anno carta + digital a 80€ o 1 anno digital a 60€) e inviarci il codice del buono a abbonamenti@vita.it



