Salute Mentale
Sono Elena: non una diagnosi, ma una persona piena di risorse
Nelle librerie è uscito "Sono schizofrenica e amo la mia follia" (Meltemi), un memoir in cui una donna con disturbo mentale racconta la sua storia di emancipazione, riuscita grazie alla cura gentile nei servizi di salute mentale e al sostegno dei suoi familiari

Elena Cerkvenič era laureata in lingue con 110 e lode, era sposata, insegnava tedesco nelle scuole. Poi un giorno, la follia è piombata nella sua vita come un fulmine a ciel sereno, mentre si trovava a Monaco di Baviera per un corso di perfezionamento. E da lì è iniziato il suo cammino all’interno dei servizi, che dimostra come la cura – quella vera, gentile, fatta di vicinanza, presenza e ascolto – possa davvero restituire la vita a una persona. Oggi la storia di Elena è diventata un libro, Sono schizofrenica e amo la mia follia, edito da Meltemi nella Collana 180 – Archivio critico della salute mentale.
Partiamo dal titolo: sono schizofrenica e amo la mia follia. Ce lo spiega?
Questo libro è il risultato di un lunghissimo percorso di consapevolezza rispetto alla diagnosi, che sappiamo è da mettere tra parentesi, come diceva Franco Basaglia. Io ho vissuto dei momenti, quando sono venuta a sapere della mia diagnosi in cui mi sono un po’ identificata con essa, che ha una connotazione molto negativa nella nostra società. È servito un lungo lavoro, mio sicuramente, ma anche dei servizi, per arrivare alla consapevolezza che in realtà schizofrenia, disturbo schizoaffettivo o depressione maggiore, insomma tutte le diagnosi, non hanno niente a che vedere con ciò che un individuo è come persona. Io sono una donna attiva, con molti talenti, opportunità e creatività. Perché quindi il titolo? Perché ho voluto dire che amo me stessa per quella che sono, anche avendo la diagnosi. E che ho gli stessi diritti di chi di diagnosi non ne ha.
Ho voluto dire che amo me stessa per quella che sono, anche avendo la diagnosi. E che ho gli stessi diritti di chi diagnosi non ne ha.
Lei ha anche vissuto un’esperienza con un’istituzione, la clinica in Germania.
È stato terribile, era il primo esordio psicotico che ho vissuto e non sapevo cosa stesse accadendo. Questa pazzia è esplosa e in un attimo ha annullato tutto quello che avevo raggiunto fino a quel momento, la laurea, i progetti per il futuro. Sono stata portata in un’istituzione psichiatrica chiusa, di cui ricordo il bianco delle lenzuola, dei camici degli operatori e degli infermieri. Era come se questo avesse annullato totalmente la mia persona; l’unica cosa che mi dava speranza e fiducia quando ero lì era il pensiero che sarebbe venuto mio marito a prendermi. Ecco, avevo mantenuto la consapevolezza di essere sposata nel mio intimo, ma tutto il resto era stato spazzato via dalla mia mente, come se ci fosse stato un uragano. Non c’era più nulla di ciò che avevo raggiunto fino a quel momento, il fatto che fossi una giovane donna piena di sogni e di progetti. Sono stata annientata e mi trovavo in un luogo in cui ero messa lì, come un oggetto. Nessuno si occupava di me.
Suo marito è stato un prezioso aiuto per lei.
Io devo la mia vita, ciò che sono ora, anche a mio marito oltre che ai servizi di salute mentale di Trieste. Lui mi ha sempre supportato, anche in momenti molto, molto difficili e pesanti. C’è sempre stato. Era una rassicurazione per me.
Quanto è importante la presenza e il supporto degli affetti più cari per chi vive un disturbo mentale?
È importantissimo. Se mio marito avesse chiesto sin dall’inizio la separazione, come sarebbe stato umano, perché non è facile trovarsi con una moglie tornata in quelle condizioni da un viaggio in cui avrebbe dovuto perfezionarsi e approfondire le sue conoscenze, sarebbe stata un’ulteriore catastrofe nella catastrofe che stavo già vivendo.
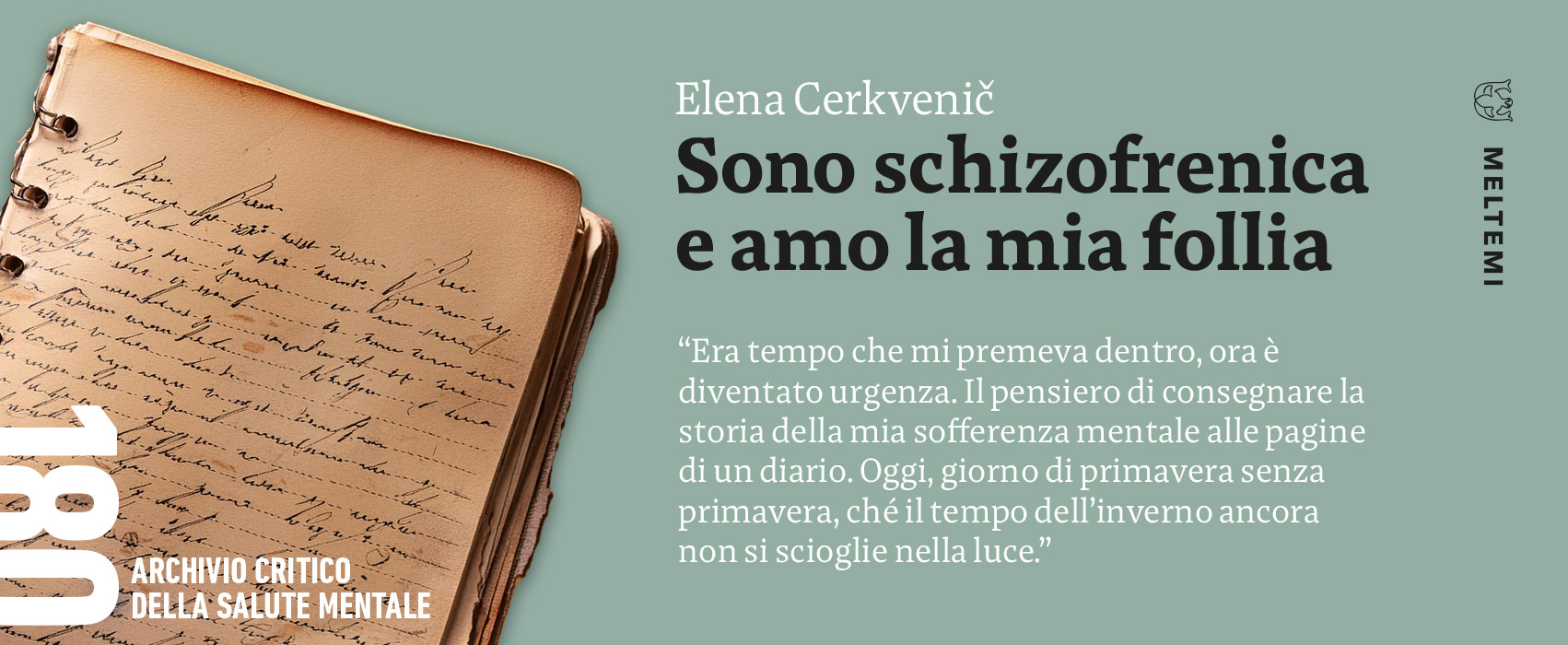
Che consiglio darebbe a chi soffre ora come ha sofferto lei?
Di avere la forza di chiedere un sostegno, essendo consapevoli che è un diritto avere delle cure gentili e umane. E, comunque, di nutrire la speranza e di aprirti a un altro che sia in grado di ricevere il tuo vissuto e di sostenerti in maniera da assicurarti una cura con la tenerezza di cui parla Eugenio Borgna, senza l’arroganza di saperne di più di chi soffre o creare quella situazione gerarchica per cui io sono più forte perché sono lo psichiatra e tu sei dalla parte della debolezza.
E qual è il suo vissuto?
A Trieste ho vissuto un approccio terapeutico in cui lo psichiatra era in grado di “togliersi il ruolo” e di mettersi alla pari del paziente. Questa è la cosa che mi ha dato fiducia, mi ha rassicurata e mi ha dato la volontà di guarire.
Da frequentatrice dei servizi, cosa pensa stia cambiando negli ultimi anni?
I servizi sono veramente fondamentali per noi persone che viviamo un disturbo mentale, però fanno molta fatica, perché ci sono pochi operatori e sono costretti a lavorare in condizioni di forte difficoltà e pressione. Credo che i servizi di salute mentale debbano essere messi in grado, con i finanziamenti adeguati, di garantire una cura gentile – anche attraverso personale formato – ai cittadini e alle cittadine. Purtroppo non si va in questa direzione, ma continuo a essere fiduciosa. È importante anche il servizio aperto 24 ore su 24: è fondamentale che in qualsiasi momento della giornata tu possa avere la possibilità di chiamare, di chiedere aiuto o ascolto. Se non c’è personale, però, questo è impossibile. Per questo anche noi persone che utilizziamo i servizi dobbiamo lottare e informare la cittadinanza su queste tematiche. Sono molto contenta di aver fatto uscire questo libro, perché si parla di questi problemi in maniera un po’ diversa, attraverso la mia testimonianza, che vuole essere un messaggio che aiuti a ragionare su come si possano migliorare i servizi e salvaguardare la Legge 180, fondamentale per tutti e non solo per chi vive il disturbo.
Quanto stigma – e quanto autostigma – c’è ancora rispetto alla salute mentale?
Mi ricordo di un periodo in cui mi sentivo in colpa, provavo vergogna per quanto mi era successo e per questa diagnosi. Poi l’ho superato, anche grazie all’incoraggiamento delle persone a me care e degli operatori dei servizi, che mi dicevano: «Elena, tu non sei una diagnosi, sei una persona con risorse e con un potenziale da sviluppare». Ho osservato che quando mi sono tolta di dosso l’autostigma, anche gli altri mi vedevano diversamente.
Foto nell’articolo fornite dall’autrice
Vuoi accedere all'archivio di VITA?
Con un abbonamento annuale potrai sfogliare più di 50 numeri del nostro magazine, da gennaio 2020 ad oggi: ogni numero una storia sempre attuale. Oltre a tutti i contenuti extra come le newsletter tematiche, i podcast, le infografiche e gli approfondimenti.
