Economia
Quando parliamo di sharing economy?
La sharing economy attiene a forme di relazione di scambio (non unicamente di consumo) eticamente consapevoli basate sulla condivisione di beni spesso sottoutilizzati
di Marco Dotti
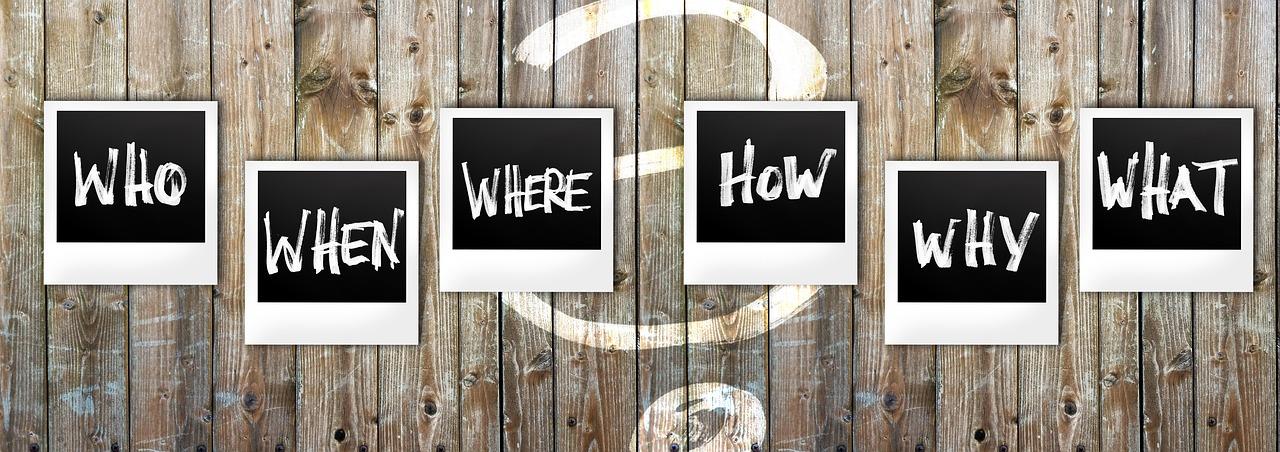
Quando diciamo economia della condivisione, diciamo qualcosa di preciso e specifico. Non diciamo, ad esempio, Uber. La società californiana, con la sua app e le sue piattaforme digitali per il trasporto privato, ha tentato – in gran parte riuscendovi, con danni evidenti – di imporsi nell’immaginario sociale come “modello vincente” di sharing economy. La sua narrazione si è imposta quasi senza incontrare resistenze, ma oramai è chiaro pressoché a tutti che la realtà dell’azienda fondata nel 2009 a San Francisco e presente in più di 69 Paesi, non rispetti l’assunto di base di un fenomeno che ha sì molti volti e ancor più nomi (anche il solo tradurlo è impresa non da poco: c’è chi parla di consumo collaborativo, chi di economia partecipata e si sta diffondendo anche un più gergale economia del popolo), ma anche radici che affondano chiaramente e inequivocabilmente nel sociale.
Condividere la relazione vs. monopolio delle interazioni
Come spiega Rachel Botsman, autrice con Boo Rodgers di un testo ancora oggi cruciale per comprendere la questione, What’s mine is yours (Harper Collins, 2010), la sharing economy attiene a forme di relazione di scambio (non unicamente di consumo) eticamente consapevoli basate sulla condivisione di beni spesso sottoutilizzati. Il fatto di produrre valore, rimettendo in circolazione underused assets (spazi, mezzi di produzione o trasporto, oggetti) è forse l’elemento chiave per scardinare la questione. È qui, infatti, che i sociale può e deve fare la sua parte: la sharing economy non è solo un diverso modo di far incontrare domanda e offerta. È o dovrebbe essere, piuttosto, una pratica di vera innovazione sociale. Nella sharing economy, il valore si crea nella circolazione da un soggetto (individuale o collettivo) a un altro: ecco perché l’accento va posto sull’accesso piuttosto che sulla proprietà, sulla fiducia, la collaborazione in rete e la partecipazione civica orizzontali piuttosto che su una disintermediazione “dall’alto” operata da piattaforme verticali come Uber.
Quando parliamo di sharing economy parliamo allora di una serie di ecosistemi, di relazioni e di pratiche a forte vocazione civica e sociale in grado, attraverso piattaforme aperte, di mettere in condivisione fra privati o organizzazioni, gratuitamente o dietro un corrispettivo non necessariamente in denaro determinati assets. In questo caso, rientrerebbero nella categoria tanto BlaBlacar – la cui storia raccontiamo nel fumetto di questo numero – quanto, secondo i più, un’azienda for profit ma non only for business come Cohealo, che condivide apparecchiature sottoutilizzate fra strutture ospedaliere e istituti di cura.
Comunità, piattaforme, algoritmi
L’Oxford Dictionary, riferimento per la lingua inglese, ha introdotto il lemma solamente nel 2015. Alla voce, “sharing economy” leggiamo una definizione semplice e al tempo stesso efficace: «An economic system in which assets or services are shared between private individuals, either free or for a fee, typically by means of the Internet» [Un sistema economico in cui i beni o servizi sono condivisi fra individui privati, con o senza un pagamento, solitamente attraverso internet].
Quattro sono le condizioni fondamentali affinché vi sia sharing economy: la presenza di una piattaforma; la presenza di persone (community); la convenienza; la tecnologia (algoritmi). Il modello della sharing economy si fonda, quindi, non sull’erogazione di servizi dall’alto, ma sulla possibilità – attraverso piattaforma e tecnologia – per la community di condividere orizzontalmente beni e servizi.
Il problema sorge però sul controllo di piattaforma e tecnologia e, quindi, sulla messa a profitto dei dati che gli utenti si scambiano. In alcuni Paesi (la Finlandia), questi dati, quando immessi in piattaforme di sharing, sono sottoposti a una disciplina speciale che ne impedisce il trattamento “privatistico” da parte di aziende. Ma anche questo è un rimedio imperfetto allo sfruttamento della sharing economy da parte di multinazionali senza troppi scrupoli. Attualmente precisa Jean-Gabriel Ganascia, professore di informatica, intelligenza artificiale e scienze cognitive all’Università di Parigi VI, i nostri sistemi non possiedono strumenti legislativi per scongiurare questo rischio. In tal senso, ci spiega il fisico teorico Fritjof Capra, considerato un guru dai primi pionieri della Silicon Valley, esperto di sistemi complessi e co-autore con il giurista Ugo Mattei di The Ecology of Law (McGraw-Hill Europe, 2015), «la conversione dell’economia in economia di condivisione è un aspetto di un tessuto ecologico e sociale complessivo nel quale si sta facendo largo una nuova visione d’insieme che, a dispetto di cifre, rating e disavanzi di bilancio, oppone una crescita qualitativa ai troppi numeri che vorrebbero limitare la vita sociale a meri rapporti di quantità».
Diventa allora fondamentale arrestare lo storytelling modello-Uber, contrapponendogli un racconto sociale basato su altri codici. Ecco perché è più che mai necessario distinguere il grano della sharing economy, che può avere benefici effetti e ridare slancio al sociale, dalla pula di ciò che non lo è: processi come quello di Uber, infatti, da un lato disintermediano la relazione di scambio spazzando via la società di mezzo (dalle associazioni di categoria a quelle dei consumatori), dall’altro stanno costituendo dei veri e propri monopoli di intermediazione commerciale verticale, diventando gli interlocutori obbligati in molti, forse troppi settori. Terzo settore incluso. Ma la condivisione non c’entra con questi tentativi di costruire monopoli digitali basati sulla proprietà di piattaforme inevitabilmente chiuse, delocalizzate e rese efficaci da algoritmi incompatibili con gli ecosistemi di della solidarietà e forse persino della convivenza umana. Il sociale viene ridotto a dati e reso funzione di un algoritmo. Il filosofo coreano Byung-Chul Han ha chiamato “dataismo” – dati al posto di senso – questo vuoto di sociale che si cerca di colmare con dati, numeri, codici. Non a caso, sul terreno di coltura di questa falsa sharing economy prospera ciò che A. Annesh, influente ricercatore dell’Università del Wisconsin, ha chiamato algocracy, algocrazia ovvero il potere degli algoritmi: un sistema di governance informatizzata dove è il codice (algoritmo) e non l’elemento umano a determinare, organizzare e infine a stringere in una forza mortale il tutto. Le relazioni umane si trasformano, sotto la spinta dell’algocrazia, in mere interazioni. Il sociale scompare: è il trionfo dei dati sugli uomini.
La condivisione e i suoi parassiti: gig economy e uberizzazione sociale
Per questa ragione, quando diciamo economia della condivisione non diciamo nemmeno Airbnnb, società capitalizzata in borsa per oltre 1miliardo di dollari, anch’essa con sede a San Francisco, che intermedia il 17% degli affitti a New York e il 10% di quelli a Parigi e oggi è accusata di favorire l’elusione e l’evasione fiscale di locatori e locatari. La risposta degli uffici stampa di Airbn e Uber è sempre la stessa e fa parte della (loro) strategia di storytelling: «noi ci limitiamo a intermediare fra chi vuole condividere». Ma proprio qui sta il trucco. E sta il problema, se è vero che questa disintermediazione radicale, unitamente ad altri salti d’epoca della cosiddetta “quarta rivoluzione industriale” prodotta dalla tecnologie digitali (dal machine learning alla robotica) e della skill distruption (distruzione di competenze), nel giro dei prossimi tre anni, secondo gli analisti del World Economic Forum di Davos spazzerà via il 48% degli posti di lavoro nella sola Italia. Quando diciamo economia della condivisione non diciamo nemmeno Foodora o Deliveroo, piattaforme proprietarie per la consegna a domicilio di cibo, in mano a pochi e con poche decine di dipendenti effettivi, che di collaborativo e di condiviso hanno ben poco.
Quando parliamo di Uber, Foodora o Deliveroo ci riferiamo a un fenomeno particolare, che della sharing economy mantiene solo l’apparenza, ma non la sostanza e assomiglia più al caporalato o al lavoro a cottimo digitale. È il fenomeno della gig economy. Ma che cos'è la gig economy, perché è tanto importante capirne natura e dinamiche per comprendere meglio la (vera) economia della condivisione e perché questa distinzione è tanto importante per il sociale? La gig economy è un modello dove le prestazioni lavorative stabili sono azzerate e, di conseguenza, gli impiegati e i dipendenti a tempo indeterminato praticamente non esistono. La dimensione sociale e relazionale del lavoro non è contemplata con rilevanti ricadute in termini di esclusione sociale e tutele di welfare. L'espressione gig economy deriva dal termine inglese “gig”, lavoretto. Nel mondo dello spettacolo “gig” è il cachet. Il precario 4.0 è chiamato gig worker e il modello è quello dell'on-demand economy, completamente disintermediata grazie a app, algoritmi e piattaforme digitali proprietarie. E qui – tra app, algoritmi e piattaforme digitali – il problema si complica.
Innovare o distruggere?
Nella gig economy l’incontro tra domanda e offerta fa letteralmente fuori il sociale, è gestito online da algoritmi che intrecciano dati e li elaborano a una velocità impressionante, ma il “gestore” – Foodora, Deliverooo e potenze aziendali emergenti parte di quel microcosmo che, con un termine eletto a neologismo dell’anno, in Francia nel 2015, vengono chiamate NATU: Netflix, Airbn, Tesla, Uber – non è un arbitro imparziale e non innova socialmente. Anzi, distrugge la cornice giuridica e il fondamento sociale di ogni relazione innovativa. In questo mondo di neolingua che sembra uscito dalla penna di George Orwell, il modus operandi di Uber ha dato origine a un altro neologismo – “uberizzazione”, sul quale conviene soffermarsi. “Uberizzazione”nasce all'incrocio fra economia della condivisione e innovazione tecnologica, toccando tanto la ricerca di una maggiore competitività delle imprese quanto – e questo è il lato spesso lasciato nell'ombra – il desiderio di libertà e indipendenza di moltissimi cittadini e consumatori. Si tratta di un fenomeno che, partito da un micro segmento delle nostre economie (i trasporti), sta impattando con conseguenze davvero radicali su tutto il settore dell'offerta di beni e servizi, dalle banche, alle professioni giuridiche e intellettuali in genere, fino alle professioni paramediche. L’uberizzazione è il software che gira sull’hardware di un sistema che molti ricercatori hanno già ribattezzato Plattform-Kapitalismus, capitalismo delle piattaforme.
«Distruggi o sarai distrutto» afferma il venture capitalist Josh Linkner. Una convinzione che sembra guidare gran parte di quella teoria del cambiamento che, dal 1995, va sotto il nome di “disruptive innovatio”". Tutto il contrario di ciò che un’economia della condivisione potrebbe e dovrebbe essere: innovazione sociale. Il sospetto è che dietro la disruptive innovation della gig economy si celi un'aspirazione gerarchica, una sorta di neofeudalesimo espiatorio la cui vittima principale, una volta chiuso il cerchio, sarebbero, manco a dirlo cooperazione e collaborazione. Il sociale verrebbe allora "sussunto" in un algoritmo. E sparirebbe.
Le piattaforme della gig economy – racconta a “Vita” il sociologo bielorusso Evgeny Morozov, columnist di punta del “New York Times”, autore di best sellers globali come L’ingenuità della rete e Internet non salverà il mondo – agiscono come veri e propri parassiti del sociale. Una piattaforma, spiega Morozov, «è proprio un parassita: si nutre delle relazioni sociali ed economiche esistenti, non produce niente, ma rimescola parti e pezzi sviluppati da altri. Il mondo delle piattaforme, nonostante l’inebriante retorica che lo ammanta, non è poi così diverso dal sistema economico che l’ha preceduto. L’unica cosa che è cambiata è chi intasca i soldi». Ma possono esistere piattaforme non parassitarie che, in qualche modo, sfuggano alla logica descritta da Morozov?
Platform Cooperativism e corpi intermedi digitali
Davanti a questo scenario, al quale l’innovazione distruttiva sta imprimendo un’accelerazione senza precedenti, si pone una alternativa secca e, non di meno, necessaria: la sharing economy o sarà sociale o non sarà. In questa direzione, vanno alcune riflessioni di Trevor Scholtz, autore del recente Uberworked and Underpaid. How Workers Are Disrupting the Digital Economy (Polity Press, 2016). Davanti a critiche crescenti, fra gli economisti e nell’opinione pubblica, che per colpire la gig economy rischiano di travolgere ogni positiva idea e ogni possibile sviluppo della sharing economy, per gli operatori di un Terzo settore che, volenti o no, si devono rendere conto che nella disarticolazione completa del rapporto fra mercato e lavoro si ritrovano a essere Primo settore, la sfida è quella di non farsi travolgere dallo storytelling di Uber e non essere succubi della potenza eversiva della disruption. Come? Rovesciando in senso positivo il cosiddetto dilemma etico dell’innovatore sociale: «quanto possiamo distruggere per innovare?».
Scholtz, che ha elaborato un manifesto di lavoro in tal senso, parla di Platform Cooperativism (Cooperazione di piattaforma) e di un nuovo mutuo appoggio sociale mediato dalla forma cooperativa e innestato su piattaforme digitali egualmente cooperative che permettano di ampliare il raggio tanto della condivisione, quanto di una trasformazione complessiva del sistema. La cooperazione è per noi un sistema antico, ma solo ora sta prendendo piede negli Stati Uniti. Siamo quindi avanti nelle forme, indietro nella capacità di innestarle nel moderno. Gli attori della condivisione e della trasformazione sociale oggi più che mai devono affrontare il nodo oggi cruciale della questione: quanto ancora possiamo reggere l’impatto con un’innovazione che non produce valore sociale ma disuguaglianza? Da parte sua, Mariana Mazzucato, docente di “Economics of Innovation” all’Università del Sussex avverte: «le multinazionali si proclamano creatrici di benessere e occupazione, ma il loro modo di fare impresa in realtà è parassitario e quindi mette a rischio l'innovazione futura». La sharing economy intermediata dalla cooperazione di piattaforma può però essere la chiave di volta per «riportare il sociale nei social», come ci spiega il teorico dei media Geert Lovink, e per abbattere la spirale perversa della disruption, dell’uberizzazione e della gig economy. La pensa così anche la “sharepreneur”, l’imprenditrice della sharing Chelsea Rustrum, che per questa ritiene possibile anche una rinascita della Silicon Valley, ispirata a nuovi modelli di cooperativismo, alcuni dei quali oramai incontrano i favori anche dei venture capitalist. «Siamo ad un punto di svolta – ci spiega – e dobbiamo integrare il mondo della sharing economy nelle nostre strutture e modelli economici. Senza questa integrazione, la disuguaglianza economica raggiungerà livelli inauditi, mettendo a rischio la stabilità della società». Insomma, la sharing economy o sarà di mutuo soccorso, cooperativa e sociale o non sarà.
17 centesimi al giorno sono troppi?
Poco più di un euro a settimana, un caffè al bar o forse meno. 60 euro l’anno per tutti i contenuti di VITA, gli articoli online senza pubblicità, i magazine, le newsletter, i podcast, le infografiche e i libri digitali. Ma soprattutto per aiutarci a raccontare il sociale con sempre maggiore forza e incisività.
