Letteratura
Premio Strega, cosa c’è dopo lo «sbriciolamento dell’io»?
Autobiografia e autofiction, sbriciolamento dell'io, ritorno alle proprie radici e largo uso del dialetto: questo il fil rouge che accomuna i 12 libri candidati al Premio Strega. Per Melania Mazzucco, presidente del Comitato direttivo del premio, «nel 2025 la salute mentale è un’emergenza sociale, ma anche letteraria». Perché? In dialogo con lo scrittore Crocifisso Dentello
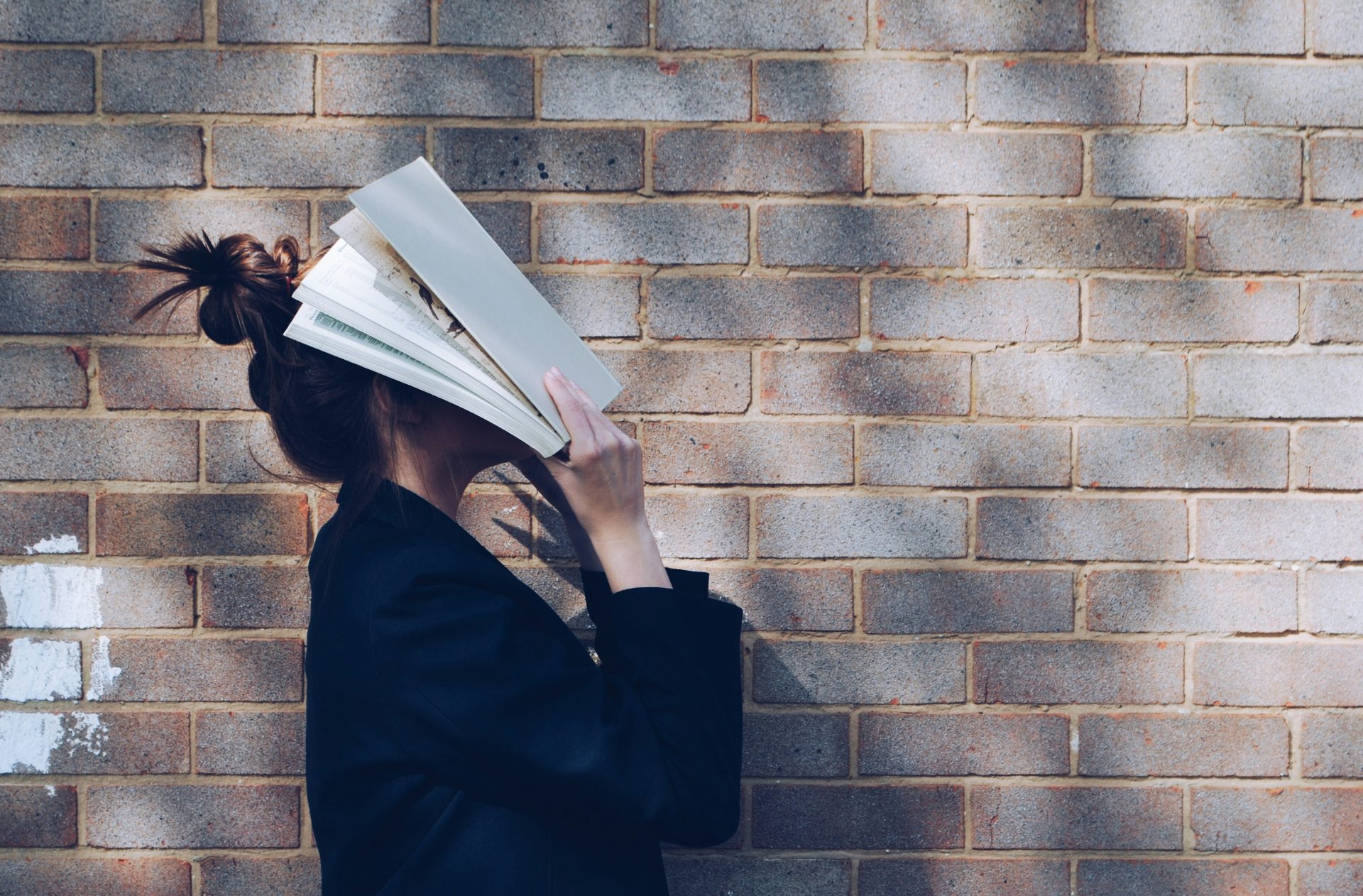
Predomina «il racconto dell’io: la cosiddetta autofiction o l’autobiografia vera e propria che ricorre, coi suoi fasti e le sue miserie». Questo il giudizio a caldo di Melania G. Mazzucco, presidente del Comitato direttivo del Premio Strega, che ha tratteggiato alcune caratteristiche in comune tra i 12 libri che continuano la corsa, scelti tra gli 81 proposti dagli Amici della domenica. «Il leit motiv di quest’anno è la follia. Sbriciolamento dell’Io, depressione, crollo psichico. Nel 2025 la salute mentale è un’emergenza sociale, ma anche letteraria», ha continuato.
Abbiamo chiesto di commentare questo fil rouge che lega i titoli in lizza per il premio letterario italiano allo scrittore Crocifisso Dentello. Il suo terzo libro Tuamore (La Nave di Teseo) è un memoir dedicato alla madre, nel quale fa i conti con il dolore della perdita affidandosi alla letteratura e alla parola scritta. Il suo ultimo libro Scuola di solitudine (La Nave di Teseo) è una narrazione autobiografica della propria infanzia e adolescenza.
Perché, secondo lei, il disagio psichico/la follia lega i libri in corsa allo Strega? Vede questo fil rouge, in generale?
Può essere ci sia un tema del disagio psichico nella nostra narrativa recente. Penso sia inevitabile se è vero che molti, anche senza rivelarlo, si rivolgono agli psicanalisti e se è vero che è in aumento l’uso di psicofarmaci. Del resto come potrebbe non deragliare la nostra psiche in mezzo a questo clima perenne di insicurezza e di precarietà?
Se guardiamo la storia della letteratura, non è vero che oggi c’è, come ha detto Mazzucco, uno «sbriciolamento dell’io». Se ripercorro il ‘900, dalla Lettera al Padre di Kafka, a Simone de Beauvoir, che ha scritto di sua madre in Una morte dolcissima, per non parlare di tanti capolavori della letteratura italiana, da Lessico famigliare di Natalia Ginzburg fino a Via Gemito di Domenico Starnone, la letteratura è piena di scrittori che, forse col genere romanzo, hanno voluto raccontare la famiglia.
Morte le ideologie, esasperati nei nostri individualismi, l’unica idea di comunità che oggi sopravvive è la famiglia
Crocifisso Dentello, scrittore
Perché, secondo lei?
Perché alla fine, a ben guardare, da quello veniamo. La famiglia è tutto ciò che noi siamo, nel bene e nel male, anche in assenza dei rapporti col padre o con la madre. Veniamo da quella storia e quindi, forse, oggi è arrivato il momento, più di altri, di interrogarci. Forse anche per la moda social, per questa tendenza tutta contemporanea di esporsi, di esibirsi. Ma io penso che il valore di un libro si misuri sul valore in sé, non già sui contenuti o meno.
Che cosa pensa del predominio del «racconto dell’io» che lega la dozzina?
Io ho scritto dei memoir, ho praticato la memorialistica, l’autobiografia. Penso che, morte e trapassate le ideologie, esasperati nei nostri individualismi, l’unica idea di comunità che oggi sopravvive è la famiglia, sono i vincoli filiali, gli affetti familiari. Ed è per questo probabilmente che tanti di noi (io e i colleghi scrittori e le colleghe scrittrici) hanno pensato di tornare alle radici, di ripercorrere, di capire bene che cosa sono stati i nostri genitori, le nostre origini.

Ci siamo cimentati in questo perché ci resta questo da indagare. Per quanto mi riguarda, ho espresso senza reticenza e senza pudore il dolore perché, a differenza del passato, quando il dolore era qualcosa che bisognava vivere al riparo dagli sguardi, con discrezione, penso che oggi possa essere condiviso. E lo dico al netto degli eccessi, delle derive che pure ci sono. Per me condividere il dolore è stato fondamentale per esorcizzarlo.
«Il dialetto impiegato nella narrativa di consumo come vezzo di colore, quasi un arredo di scena, diventa ormai nei romanzi di ambientazione contemporanea una scelta voluta di personaggi italofoni, il ricordo (anche polemico o comico) delle radici nella piccola patria, ormai aperta al mondo globale», ha detto Mazzucco, sottolineando come l’uso del dialetto accomuni i libri in gara.
Il dialetto unisce più di qualsiasi altra cosa, non è altro che un ritorno al recupero delle proprie origini, delle proprie radici. Su questo non c’è dubbio. Io, per esempio, sono nato e vissuto a Milano ma sono figlio di siciliani. Il dialetto della terra dei miei genitori per me è un richiamo identitario, perché era la lingua praticata nella quotidianità da mia madre e da mio padre in casa.
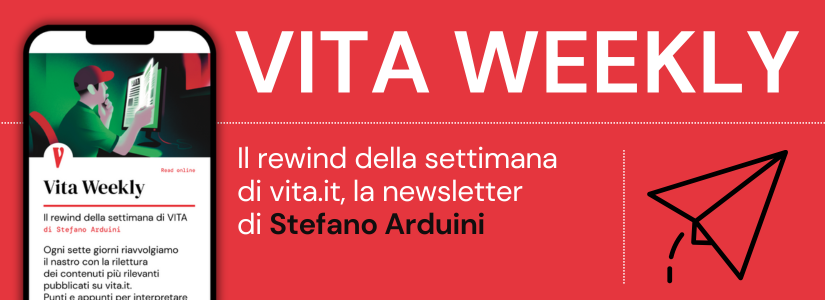
La dozzina in corsa
Valerio Aiolli con Portofino blues (Voland), Saba Anglana con La signora Meraviglia (Sellerio Editore), Andrea Bajani con L’anniversario (Feltrinelli), Elvio Carrieri con Poveri a noi (Ventanas). E ancora Deborah Gambetta con Incompletezza. Una storia di Kurt Gödel (Ponte alle Grazie), Wanda Marasco con Di spalle a questo mondo (Neri Pozza), Renato Martinoni con Ricordi di suoni e di luci. Storia di un poeta e della sua follia (Manni), Paolo Nori con Chiudo la porta e urlo (Mondadori), Elisabetta Rasy, con Perduto è questo mare (Rizzoli). Infine, Michele Ruol, con Inventario di quel che resta dopo che la foresta brucia (TerraRossa), Nadia Terranova con Quello che so di te (Guanda) e Giorgio van Straten con La ribelle. Vita straordinaria di Nada Parri (Laterza). La proclamazione dei finalisti sarà il 4 giugno e il vincitore sarà decretato il 3 luglio.
Foto di Siora Photography su Unsplash e nell’articolo, foto dell’intervistato
Cosa fa VITA?
Da 30 anni VITA è la testata di riferimento dell’innovazione sociale, dell’attivismo civico e del Terzo settore. Siamo un’impresa sociale senza scopo di lucro: raccontiamo storie, promuoviamo campagne, interpelliamo le imprese, la politica e le istituzioni per promuovere i valori dell’interesse generale e del bene comune. Se riusciamo a farlo è grazie a chi decide di sostenerci.
