Libri
Perché non basta “rammendare” le periferie
Renato Quaglia è il direttore di Fondazione Foqus di Napoli. È autore del libro “Il laboratorio della città nuova – Foqus nei Quartieri Spagnoli” dove racconta come uno dei luoghi più fragili d'Europa è diventato protagonista delle sfide del futuro. «Oggi le periferie rappresentano la parte preponderante delle città», dice. «Il rammendo delle periferie chiede ai suoi personaggi di sorridere nella foto, anche se non ne hanno lo spirito e la voglia, perché il racconto deve essere concluso felicemente e il lieto fine è obbligatorio. Per le periferie delle città il rammendo è diventato un dannoso equivoco»
di Anna Spena

“Il laboratorio della città nuova – Foqus nei Quartieri Spagnoli” di Renato Quaglia, edito da Rubbettino, è il racconto di un’esperienza che a Napoli, in uno dei quartieri più fragili d’Europa, è stata al tempo stesso una visione e una sfida al futuro. Quaglia, insieme a Rachele Furfaro, è stato ideatore del progetto e fondatore della Fondazione Foqus, di cui è tuttora direttore.
Luoghi come Scampia, lo Zen, Corviale, le Dighe, San Paolo e Quarto Oggiaro non sono più casi isolati, ma simboli di una diffusa inadeguatezza che si riscontra in molte periferie anonime di ogni città. Tuttavia, Quaglia sostiene che queste aree non rappresentino solo criticità irrisolvibili, ma anzi le uniche da cui può iniziare la progettazione di una nuova città. La sede della Fondazione Foqus si trova nell’ex Istituto Montecalvario, un complesso di circa 10mila mq situato nel quartiere Montecalvario. Nel 2012, la Congregazione delle Figlie della Carità di San Vincenzo de’ Paoli e Santa Luisa di Marillac ha deciso di interrompere le attività educative e ha proposto all’Impresa Sociale Dalla Parte Dei Bambini di Rachele Furfaro di rilevare l’impegno nel quartiere. Nel 2014 Dalla Parte Dei Bambini ha costituito la Fondazione Quartieri Spagnoli ets Foqus, affidandole un progetto di responsabilità sociale inedito in Italia: la riqualificazione del ruolo e delle funzioni dell’Istituto per lo sviluppo dei Quartieri Spagnoli. Da allora, Foqus è l’unica responsabile di questo progetto di rigenerazione urbana.
I risultati parlano chiaro: il numero di bambini e ragazzi iscritti negli istituti pubblici dei Quartieri è passato da poco più di trecento nel 2014 a oltre 1.500 oggi, di cui mille frequentano le scuole di Foqus. Due anni dopo la sua nascita, l’Accademia di Belle Arti ha aperto una sede distaccata presso Foqus, portando oltre 700 studenti di design, moda e grafica. Nel 2016 è stato inaugurato anche un centro per persone con disabilità cognitiva. Inoltre, le sedi per attività comunitarie e socio-culturali sono raddoppiate in dieci anni, e la corte di Foqus è diventata un punto di riferimento per la vita pubblica del quartiere e dell’intera città. Attualmente, la Fondazione accoglie annualmente più di 35mila persone, tra genitori che accompagnano i bambini a scuola, lavoratori, partecipanti a eventi culturali di vario genere e visitatori.
Direttore, partiamo dalla copertina del libro: i Quartieri Spagnoli visti dall’alto
Avete visto la struttura? È ortogonale. Un assetto cinquecentesco che deriva dall’insediamento dell’esercito spagnolo a seguito della conquista di Napoli. Gli spagnoli, per proteggere i palazzi del potere occupati dalla nobiltà iberica, allestirono un accampamento ricalcante il modello del castrum romano, con la sua caratteristica pianta ortogonale e cardo-decumano centrale. Questo insediamento temporaneo, evolutosi poi in edifici stabili, ha lasciato come eredità la persistente struttura urbanistica di tipo romano.
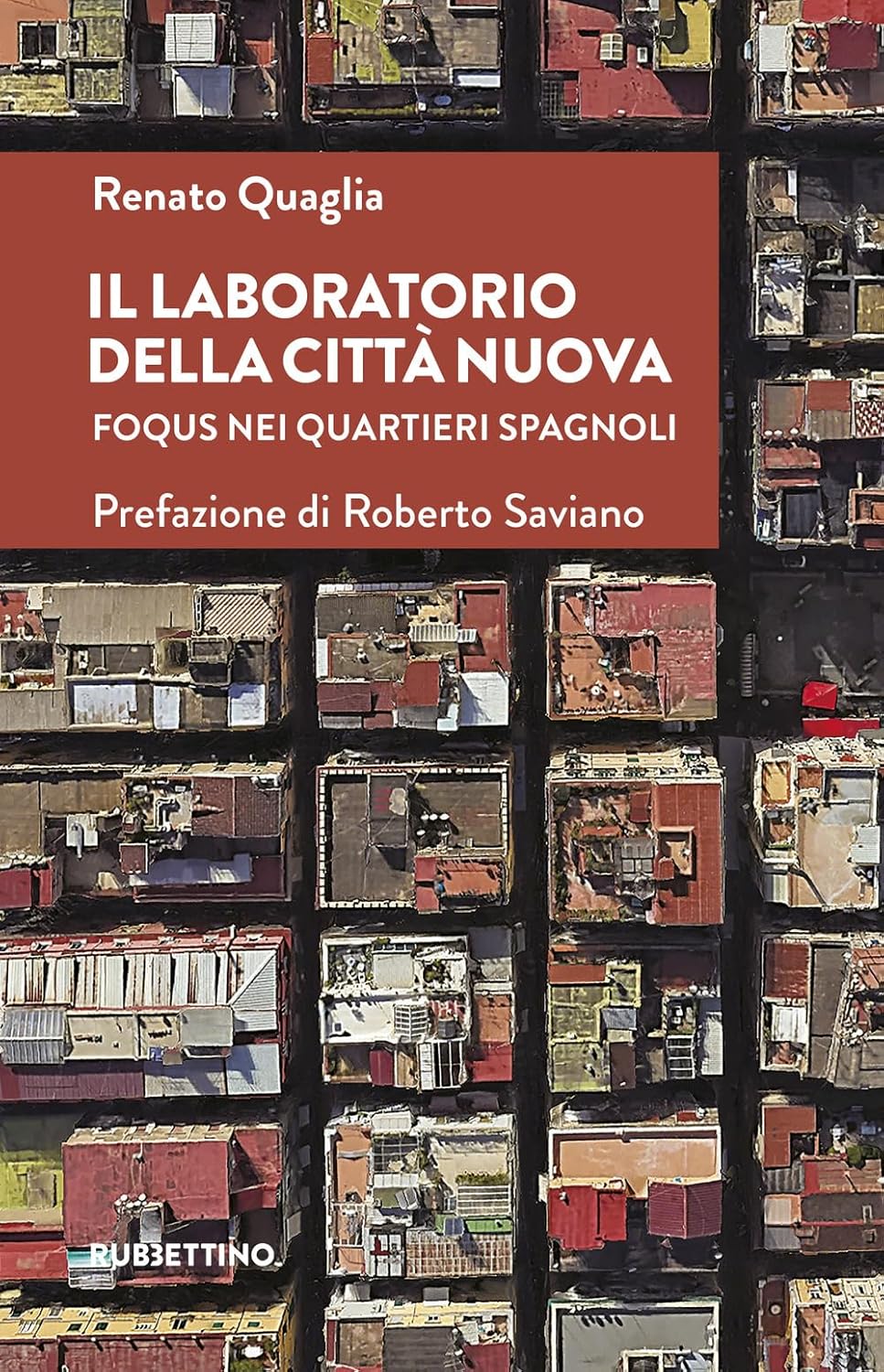
La prefazione del libro è firmata dallo scrittore e giornalista Roberto Saviano. E inizia così: “La Fondazione Foqus è un piccolo grande miracolo partenopeo. Mi capita spesso di utilizzare la metafora del sangue di san Gennaro, perché in una città complessa come Napoli, il sangue che ogni anno rinnova il suo patto, sciogliendo i grumi, ovvero le questioni irrisolte, stabilisce la primazia della vita che, nonostante tutto, scorre, continua a manifestarsi, finanche a vincere. Dicevo, Foqus è un piccolo grande miracolo; piccolo perché è una esperienza unica in una terra in cui servirebbero decine di percorsi simili; grande perché Foqus lavora proprio dove e come serve, con bambine e bambini, ragazze e ragazzi in un quartiere che, sebbene centralissimo rispetto alle rotte del turismo (i Quartieri Spagnoli), vive un tasso di dispersione scolastica da far tremare i polsi”. Sicuramente Foqus è il risultato di una visione straordinaria. Ma davanti a tutti i fatti di cronaca che riguardano il quartiere e la città, a volte non perde la speranza?
No. Io credo che la speranza non sia solamente l’aspettativa che qualcosa possa cambiare, ma sia la consapevolezza che è necessario che qualcosa debba cambiare. E quindi la speranza sicuramente non è qualcosa che viene lanciato al futuro, è qualcosa che riguarda la necessità di un impegno presente.
Quindi non possiamo chiedere a questi progetti le “soluzioni”?
Questi progetti di rigenerazione e iniziative focalizzate, al pari di altri interventi sistemici consolidati, producono delle premesse, non delle soluzioni definitive per i territori. In questo contesto, la realtà è vista come quartiere, e gli edifici dismessi simboleggiano un’eversività. L’interesse primario è rivolto alla condizione sociale dei quartieri, più che all’aspetto urbanistico. Questo si ricollega a quanto osservato riguardo alle nuove generazioni, un fenomeno emergente qui, che è anche legato all’esperienza del Covid.

La sospensione della scuola, della socialità e delle relazioni ha avuto inevitabilmente delle ripercussioni su una o due generazioni. Tutto ciò evidenzia che la crisi non riguarda solo la città o il singolo quartiere, ma un modello socioeconomico più ampio. Per questo, anche nel libro, definisco superficiale chi parla di rammendo delle periferie.
In che senso?
Come scrivo nel libro di fronte a questa condizione sociale sempre più diffusa, insostenibile per chi la vive, insopportabile per chi ne misura quotidianamente effetti e conseguenze, l’immagine del rammendo delle periferie che accompagna e a volte titola la riflessione e le intenzioni politiche di politici e personalità nazionali, pare incomprensibile, stonata, distante sideralmente dalla realtà delle cose e della città. Si rammenda per poter continuare a usare quel certo vestito che, anche se chiederebbe di essere cambiato, non possiamo permetterci di cambiare. Si rammenda nella speranza che la perizia con cui si è ritessuta la stoffa logorata o strappata, non renda troppo visibile lo strappo, sempre e solo in apparenza. Il rammendo è un mascheramento, un camuffamento, l’occultamento di una lacerazione, del risultato di un danno, una caduta occasionale, un errore di movimento. Il rammendo delle periferie è il titolo di un racconto che cerca di dissimulare quanto è davvero accaduto, che prova a coprire le cicatrici con cipria copiosa e biacca teatrale, che chiede ai suoi personaggi di sorridere nella foto, anche se non ne hanno lo spirito e la voglia, perché il racconto deve essere concluso felicemente e il lieto fine è obbligatorio. Per le periferie delle città il rammendo è diventato un dannoso equivoco, un gioco lessicale da salotto che ha banalizzato e continua a banalizzare le effettive dimensioni del problema sociale che sottende. È un invito a guardare ciò che resta in superficie, ciò che appare tranquillizzante perché facilmente recuperabile. Il rammendo delle periferie è niente di più che un ammonimento, un cautionary tale, direbbero gli inglesi. Invece, purtroppo, non ci sono soluzioni semplici o favolistiche per le periferie. Alle vicende di queste parti di città forse non è concessa nemmeno una fine, si procede per inerzia, in un continuum fatto di infinitesimi avanzamenti e smisurate regressioni. Dovremmo smettere di considerare le periferie come anomalie di sistema da rammendare e riportare a una presunta normalità. È semmai in questi quartieri che la città si offre finalmente come campo di trasformazione, dove è possibile affrontare senza soggezione la permacrisi dei suoi molti modelli e sperimentare con irriverenza le sue alternative.

Le periferie non sono distaccate dalla città, ne sono l’emblema
Ad oggi rappresentano la parte preponderante della città. Durante il boom economico queste zone, sebbene in costruzione e spesso incomplete dal punto di vista dei servizi essenziali, si trovavano ai margini a causa della continua espansione urbana, rappresentando i veri e propri confini cittadini. Oggi, il concetto di periferia è mutato: si tratta di aree urbane che possono trovarsi anche all’interno del centro storico.
Tre parole per descrivere il modello Foqus
Ascolto e inclusione sono le prime due parole chiave. Inclusione intesa in senso ampio, non come semplice riferimento alla disabilità, ma come apertura a idee, progetti e iniziative esterne. Infatti, metà delle attività di Foqus nasce da proposte esterne, ritenute coerenti o comunque meritevoli di attenzione. Il quartiere e poi la città si sono appropriati di Foqus. La comunità si è presa Foqus, trasformandolo da un vuoto a un pezzo vivo della città. La terza parola è trasformazione – non riqualificazione – un cambiamento profondo.
Gli enti locali, le amministrazioni, osservano il vostro modello, lo elogiano…
Ma non lo assumono. Esitano ad adottarlo ed integrarlo nonostante riconoscano il disagio a cui proviamo a dare una risposta. E questa cosa rappresenta un problema perché il rischio che corriamo è quello di rimanere esempi non raccolti, esempio che non si trasformano in politiche pubbliche.
Nei Quartieri Spagnoli però c’è un aspetto di bellezza innegabile che in altre zone fragili, come per esempio Scampia o Caivano, non troviamo.
La bellezza, però, va costruita ora. Non so se hai visto le nuove aree delle nostre scuole. Abbiamo creato nuove aule per circa 400 bambini in un edificio storico, chiuso per un secolo, all’interno di un progetto che si concentra su educazione, quartieri e ambiente. Abbiamo adottato un principio diffuso nelle scuole del Nord Europa: non è detto che bambini di cinque anni debbano stare in classe solo con coetanei; il confronto con bambini di 10 anni è utile per diverse ragioni, tra cui l’abbassamento della tensione che può portare a bullismo. Come abbiamo agito? Lo spazio ampio è stato diviso in modo che le aule adiacenti abbiano una parete mobile. Gli insegnanti possono decidere di aprirla, unendo due aule fino a creare un open space di circa 80 metri per 10. Uno spazio inatteso in un contesto fragile. Non abbiamo banchi, solo tavoli cooperativi. Questi tavoli, con la loro forma arrotondata garantiscono che nessuno sia escluso dalla discussione. È insolito, in quartieri come i Quartieri Spagnoli, che le madri possano portare i bambini in un posto così bello. L’abbiamo realizzato, facendo il massimo possibile, pur sapendo che si può sempre migliorare. Il principio di bellezza, fondamentale per ogni prospettiva di trasformazione, riguarda sia la preesistenza che il nostro approccio. Bisogna dire a chi vive in questi luoghi che la loro condizione non è immutabile, ma può essere trasformata radicalmente, non solo riparata. C’è una frattura, non uno strappo da ricucire.
Nel libro parla di Agenzie miste
Per prevenire e contrastare la crisi sociale prodotta dalle conseguenze della città, occorrerebbe una convinta compartecipazione innanzitutto tra pubblico e privato e non profit. Un ente pubblico che si ponga in consapevole, informata osservazione e interessata valutazione dei molti laboratori sociali in corso, di cui analizzi le diverse potenzialità, caratteristiche, impatti, modalità, per infine scegliere quali, o quali parti di quelle esperienze, tradurre in politiche pubbliche, e a quali laboratori, o a quali progetti, garantire continuità effettiva. Un ente pubblico che costituisca, con le organizzazioni in grado di apportare com- petenze ed esperienze utili a radicare sui territori nuovi servizi e continuare la ricerca di modelli innovativi, agenzie miste di interesse pubblico, da gestire insieme, ente pubblico ed enti del Terzo settore più avanzato. Si potrebbe così disegnare una rete territoriale di presidi di innovazione sociale, ognuno caratterizzato per vocazioni costitutive e strategie individualizzate di intervento, disseminati tra quartieri, città e aree disagiate. I cui programmi, a vocazione educativa, culturale, socio-assistenziale, produttiva, occupazionale, sarebbero risultato di un impegno congiunto, negoziato tra Stato, ente locale, organizzazioni non profit e comunità protagoniste degli interventi.
Cosa dovrebbe fare l’ente pubblico?
Per adempiere al proprio compito, l’ente pubblico deve rinnovare profondamente il proprio approccio, improntandolo all’apertura e a una riorganizzazione delle modalità operative. Il fine ultimo deve essere il miglioramento della qualità della vita urbana. Si potrebbe persino riprendere una definizione di modernità secondo cui essa si afferma quando una città assicura la sicurezza non solo al potere sovrano, ma a tutti i cittadini. Questo segna l’inizio della modernità e del successo urbano. Oggi, è fondamentale sottolineare che, parlando di sicurezza, non ci riferiamo a politiche securitarie. Oggi, la città ci garantisce ancora sicurezza? O piuttosto viviamo in un malessere e in un’irrisolutezza diffusi? Sembra che abbiamo smarrito la promessa fondamentale: la città deve garantire tutti i suoi cittadini. Per recuperare questa promessa, è la città stessa, ovvero chi la governa, che deve cambiare il proprio approccio. Non si tratta solo di risolvere problemi superficiali come le buche nei marciapiedi o la gestione amministrativa di base. Dobbiamo tornare a garantire la sicurezza come benessere all’interno della città. La città ha questo compito. Pertanto, le amministrazioni pubbliche, i funzionari, i dirigenti e la politica (attenzione, non intendo posizioni qualunquiste) devono riprendere e onorare la promessa originaria della città: garantire tutti i cittadini.
Cosa fa VITA?
Da 30 anni VITA è la testata di riferimento dell’innovazione sociale, dell’attivismo civico e del Terzo settore. Siamo un’impresa sociale senza scopo di lucro: raccontiamo storie, promuoviamo campagne, interpelliamo le imprese, la politica e le istituzioni per promuovere i valori dell’interesse generale e del bene comune. Se riusciamo a farlo è grazie a chi decide di sostenerci.
