Welfare
Perché alla cura serve la speranza
La speranza trae fondamento dalle buone relazioni. Un aspetto di cui bisognerà tener conto sempre più nell'organizzazione dei sistemi sanitari tanto più in un momento in cui la pressione di fattori economici rischia di far trascurare i fattori umani in nome di una presunta "razionalizzazione". Ne parliamo con Carlo Alfredo Clerici dell'Università di Milano
di Marco Dotti

Ci sono questioni sulle quali conviene riflettere a voce alta. Una di queste è la speranza. Nelle pratiche della cura, spesso la speranza è confinata su un piano privato e individuale, quasi coincidesse con una solitaria illusione. Ma la dimensione della speranza rimanda non solo agli orizzonti possibili della guarigione – la salvezza – ma anche a quelli attuali della relazione – la cura. Temi, questi, che saranno al centro del Convegno "Cura della speranza, speranza nella cura" che si terrà nell'Aula Magna dell'Istituto Nazionale dei Tumori, venerdì 27 novembre 2015, alle 14,30,
Ne parliamo con Carlo Alfredo Clerici, che figura tra i promotori del convegno. Medico specialista in psicologia clinica, psicoterapeuta, il dottor Clerici lavora come ricercatore confermato presso l'Università degli Studi di Milano e come dirigente medico di I livello presso l'Istituto dei Tumori di Milano. Il suo ambito principale di studio è l'adattamento psichico alle malattie organiche, in particolare in oncologia pediatrica, settore in cui svolge da anni attività di psicologia clinica di collegamento. Autore di numerose pubblicazioni scientifiche su riviste internazionali ha pubblicato con Laura Veneroni un innovativo manuale di psicologia clinica ospedaliera dedicato all'integrazione multidisciplinare, La psicologia clinica in ospedale. Consulenza e modelli d'intervento (Il Mulino, Bologna 2014).

Pubblicata su Tumori Journal (TJ), la ricerca titolata “Hope in cancer patients: the relational domain as a crucial factor” ha coinvolto 320 pazienti malati di neoplasie gravi. A condurla, un’équipe di lavoro multidisciplinare composta da oncologi, statistici, psicologi clinici e –novità – un cappellano ospedaliero, don Tullio Proserpio, della cappellania ospedaliera della Fondazione IRCCS – Istituto Nazionale dei Tumori di Milano. Ci illustra presupposti e risultati della ricerca che avete pubblicato su Tumori Journal? Che cosa vi ha mossi a indagare un campo così poco indagato e, diciamolo pure, anche un po' rischioso?
Lo studio ha preso spunto dall'esigenza di approfondire un'idea tanto importante come quello di speranza quando viene espressa dalle persone ammalate, quanto disertata dalle teorie psicologiche e nell'insegnamento medico. In tutto il codice deontologico troviamo accenno alla speranza soltanto una volta, a proposito della comunicazione delle diagnosi infausta e ed è possibile consultare un trattato di clinica medica e cliniche chirurgiche senza mai trovarvi un accenno.
Eppure sostenere la speranza è un fattore determinante che la medicina antica ha sempre conosciuto fino a quando, diventato scientifica, ha dovuto mettere da parte, in nome di una maggiore oggettività con lo sviluppo dei concetti della patologia cellulare e la trasformazione delle pratiche di cura fra la fine dell'Ottocento e gli inizi del Novecento.
Da alcuni decenni invece da quando l'evoluzione dei sistemi sanitari, l'aumento del contenzioso legale e le critiche alla medicina tecnologica gli aspetti soggettivi dei pazienti sono tornati elementi da considerare, integrando quanto più possibile le conoscenze delle scienze biologiche e delle scienze umane.
La ricerca mostra come la speranza tragga fondamento dalle buone relazioni e di questo aspetto bisognerà tener conto sempre più nell'organizzazione dei sistemi sanitari tanto più in un momento in cui la pressione di fattori economici rischia di far trascurare i fattori umani in nome di una presunta "razionalizzazione".
La vostra è stata una équipe multidisciplinare in senso forte. Crede sia importante non limitare il discorso della cura al solo discorso medico? Intendo dire: la vostra è una ricerca scientifica, ma ha molteplici tagli e dà luogo a molte possibilità di lettura: antropologica, psicologica, persino spirituale se mi passa il termine…
L'essere umano può essere visto e considerato che approcciato alla luce di angolazioni completamente diverse ma che non sono necessariamente antitetiche. La biologia non esclude la considerazione per aspetti immateriali quali il pensiero, le emozioni, la volontà, gli aspetti irrazionali. Anzi, per meglio gestire la malattia occorrono strumenti per comprendere l'uomo nelle sue diverse dimensioni e possibilità. Il gruppo di lavoro composto da oncologi, specialisti della salute mentale, filosofi e religiosi è costituito spontaneamente, comprendendo persone con diverse prospettive spirituale religiosa e laica accomunate dalla volontà di riflettere sulle esigenze dei pazienti che si trovano ad affrontare la sfida di una malattia grave in un moderno Cancer center.
Nella sua esperienza clinica, ha riscontrato e riscontra un – chiamiamolo così – "principio-speranza"? Come dovremmo intenderlo? Sono una forma delle cure palliative o, piuttosto, un elemento, troppo trascurato, di quel complesso di azioni, pratiche e relazioni che chiamiamo "cura"?
Il bisogno di speranza non riguarda soltanto la fine della vita. Nell'esperienza di specialista della salute mentale ho avuto occasione di verificare come il tema del significato dell'esistenza sia una questione che accomuna "sani" e "malati". Nel caso della malattia la domanda può diventare più urgente, a fronte della percezione di una vita temuta essere breve. Certo, però, che interrogativi legati al bisogno di speranza affiorano ogni volta che il dialogo medico non si limita unicamente a domande diagnostiche, ma è un incontro approfondito con la soggettività della persona. Per questo, il bisogno di speranza nel rapporto medico paziente, così come il supporto psicologico sociale spirituale non possono essere limitati soltanto nei contesti dedicati alla terminalità ma essere previsti in tutti gli ambiti dedicati alla cura delle malattie gravi. Spesso, però, nella pratica clinica il mondo della cura che ha come obiettivo la guarigione e i contesti di assistenza alla fase terminale sono vissuti come divisi da una netta separazione, mentre una buona cura dovrebbe sempre comprendere la possibilità di un esito infausto non come errore, deviazione o accidente ma come parte delle possibilità reali della vita e della malattia.
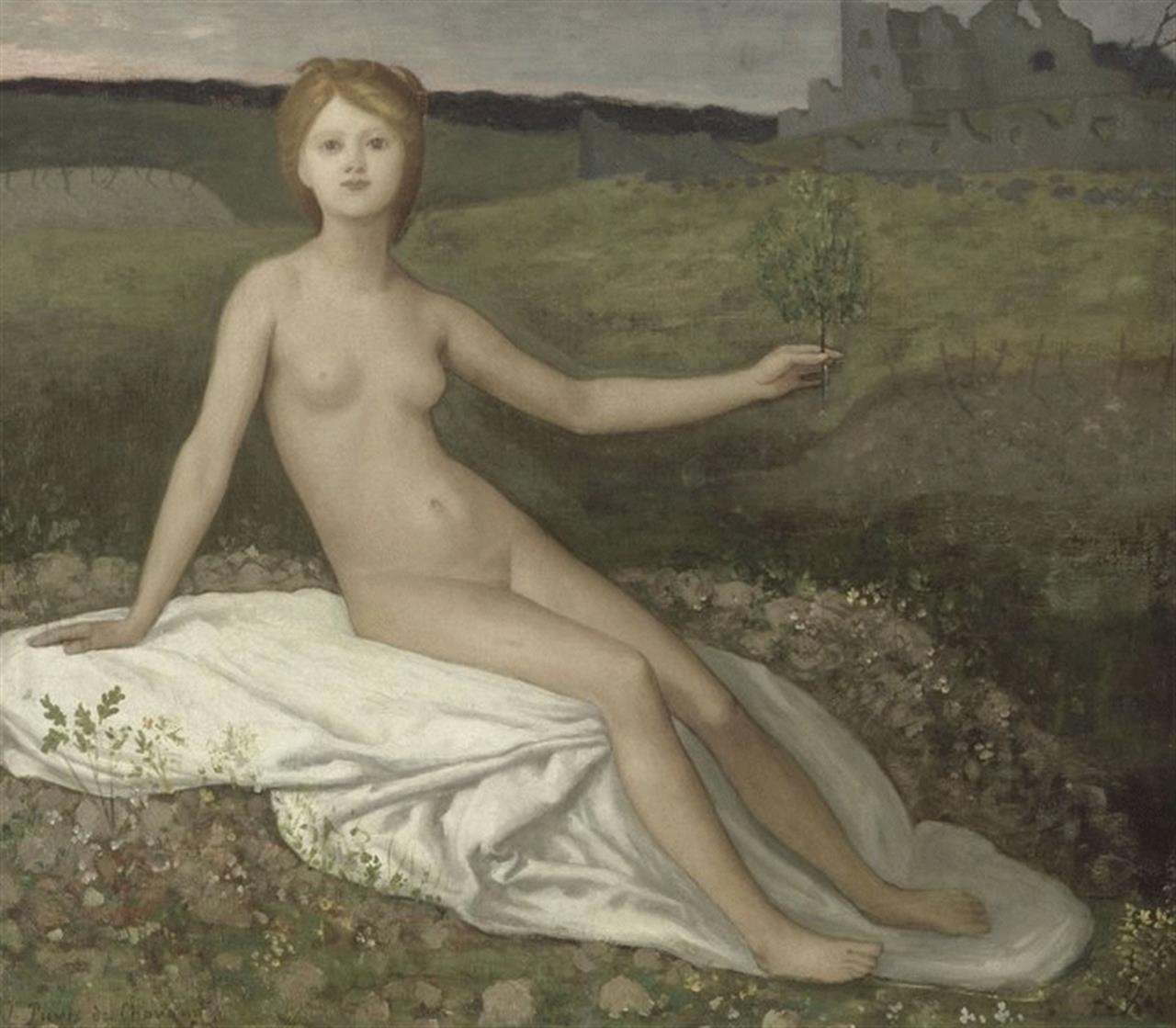
Dalla ricerca al convegno "Cura della speranza, la speranza nella cura" che si terrà venerdì prossimo presso l'Istituto Nazionale dei Tumori di Milano. Non vi fermare, dunque… Che cosa bolle in pentola?
Il convegno è un'occasione di dibattito pubblico su un tema di lavoro più ampio che riguarda la concezione di persona oggetto delle cure mediche in un sistema sanitario come quello italiano che si trova a dover bilanciare l'attenzione ai fattori economici e l'attenzione alla persona. Dove la multidisciplinarità è un obiettivo talvolta ideale ma di difficile realizzazione e dove occorrono prove di efficacia più adeguate a descrivere costi e risparmi derivanti di un'attenzione alla persona nelle diverse dimensioni non solo biologiche ma anche psicologiche e sociali.
Che senso danno malati e parenti dei malati alla parola "speranza" in un contesto oncologico? La mia impressione è che, al contrario di come spesso la decliniamo "fuori", dentro un ospedale o in uno spazio di cura la parola "speranza" abbia anche una concretezza…
Pensando la speranza in prospettiva teorica il rischio è di avere una concezione astratta mentre la prospettiva è estremamente pratica.
In questo senso personalmente ho ricevuto più aiuto nel rapporto con i pazienti e nelle possibilità di un loro supporto dalle prospettive offerte dall'antropologia cristiana che non da varie teorie psicologiche. Mi spiego meglio: le prospettive derivanti dalle osservazioni di padre Rulla descrivono come un paziente possa nutrire grandi speranze (ad esempio nella possibilità di una vita eterna), ma come queste siano raggiungibili attraverso un percorso fatto di piccole speranze (ad esempio il desiderio che oggi sia una giornata decente in cui il dolore i sintomi non si facciano troppo sentire). Questa prospettiva incoraggia fortemente il lavoro clinico assistenziale anche nei suoi aspetti più semplici; il supporto alle piccole speranze – che si sia credenti o non credenti, forse non importa – è anche un modo per aiutare la persona malata a credere nei propri valori.
Vuoi accedere all'archivio di VITA?
Con un abbonamento annuale potrai sfogliare più di 50 numeri del nostro magazine, da gennaio 2020 ad oggi: ogni numero una storia sempre attuale. Oltre a tutti i contenuti extra come le newsletter tematiche, i podcast, le infografiche e gli approfondimenti.
