Natura da salvare
Mezzo milione di foto scattate nelle foreste tropicali dice che il miglior amico degli animali non è l’uomo
Una ricerca internazionale cui partecipa l'Università di Firenze ha disseminato 2mila foto-trappole in 37 foreste di tre regioni geografiche: Neotropici, Afrotropici e Sud-Est Asiatico. Il risultato sono oltre 550mila immagini che hanno consentito di capire l'impatto antropico sui mammiferi. Ora l'obiettivo è diminuirlo attraverso l’educazione. Parla una ricercatrice

Uno studio condotto all’Università di Firenze ha rilevato come l’aumento della densità umana sia l’unico fattore associato a variazioni globali nella numerosità di specie: 500mila immagini scattate da foto-trappole per analizzare il numero delle specie e la loro distribuzione sul territorio.
Quarantatre scienziati
A coordinare lo studio dell’ateneo fiorentino è stato Francesco Rovero, professore associato di Ecologia. Si tratta del primo studio che, utilizzando la più consistente mole di dati da foto-trappolaggio mai raccolta, mostra come gli effetti di sovrappopolazione umana e perdita di habitat in aree tropicali impatti gravemente sulla fauna, causando estinzioni locali e diminuzione delle specie rimaste. La ricerca pubblicata su Plos Biology, ha coinvolto altri 43 scienziati da 51 enti di ricerca nel mondo, che hanno contribuito sia con i dati dalle rispettive aree di studio sia con il supporto alle analisi. In particolare, Lydia Beaudrot della Michigan State University ha collaborato strettamente con il gruppo di Firenze per l’interpretazione dei risultati e preparazione dell’articolo.

Il tema della ricerca
I ricercatori hanno esaminato i dati con un modello statistico elaborato per valutare potenziali variazioni globali di quantità e distribuzione delle specie in relazione all’incremento della popolazione umana, alla vicinanza agli insediamenti, alla perdita di habitat forestale e alla frammentazione delle foreste entro un raggio di 50 chilometri dalle aree di studio. L’aumento della densità umana risulta essere l’unico fattore associato a variazioni globali nella numerosità di specie: maggiore è il numero di persone, minore è la quantità di mammiferi nella zona. Per quanto riguarda le variazioni nella distribuzione nelle specie, queste sono risultate dipendenti da copertura e frammentazione delle foreste: è stata registrata una diminuzione della distribuzione delle popolazioni di mammiferi nelle aree maggiormente frammentate e caratterizzate da perdita di foresta.
Abbiamo incontrato Ilaria Greco, assegnista di ricerca, del Dipartimento di Biologia che, insieme al prof. Rovero, già dal 2020 con la sua tesi di dottorato, è una protagonista della ricerca. Nata a Lecce, classe 1991, dal Salento studia scienze ambientali e si laurea a Stoccolma alla magistrale in ecologia del paesaggio per poi arrivare a Firenze a fare il dottorato in biologia evoluzionistica ed ecologia, oggi è anche in attesa di un bimbo, emana rigore e determinazione scientifico, tanto quanto, passione orgoglio e gratitudine.
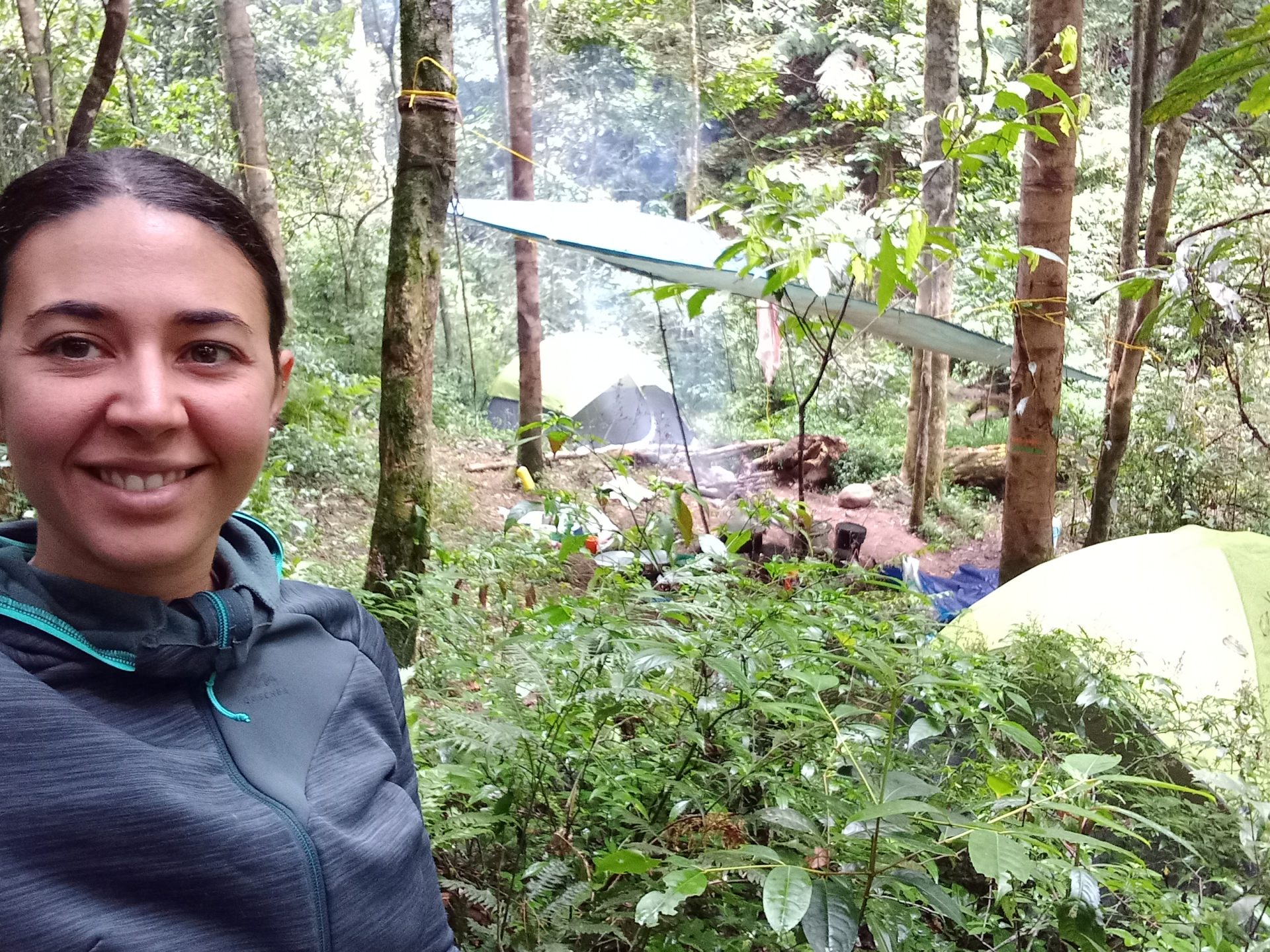
Come avere realizzato questa ricerca?
Abbiamo utilizzato oltre 550mila immagini di mammiferi da oltre 2.000 foto-trappole, piazzate in 37 foreste tropicali in tre regioni geografiche: Neotropici, Afrotropici e Sud-Est Asiatico. Sono state analizzate il numero di specie e la distribuzione delle comunità di mammiferi (239 specie in totale) in relazione al disturbo antropico che agisce a livello di landscape circostante le aree monitorate
Dove sono state posizionate le fototrappole?
I paesi coinvolti nella ricerca hanno operato in tutta la fascia equatoriale del pianeta sono molti: Indonesia, Panama, Uganda, Brazil, Perù, Suriname, Cameroon, Malysia, Thailand, Gabon, Cameroon, Indonesia, Colombia, Tanzania, India Lap, Congo, Myanmar, Madagascar, Costa Rica, Rwanda, in tutto, 37 le foreste monitorate.
E l’Università di Firenze?
Le due foreste in Tanzania monitorate dall’università di Firenze, con a capo il professor Rovero, tramite il supporto logistico del centro sono Uzungwa Scarp che è un Nature Forest Reserve e Mawnihana che è all’interno del Parco Nazionale dei monti Udzungwa. Io mi sono recata quando, ho contribuito alla raccolta dati, proprio a Mwanihana ed è stata una esperienza unica. I collaboratori della ricerca ci hanno passato i dati delle foto-trappole da tutte queste aree nel mondo: abbiamo contattato quelli che avevano un protocollo quanto più simile a quello che cercavamo e in particolare siamo partiti da un protocollo iniziato nella fascia tropicale dal 2012, scientificamente appurato per il monitoraggio dei mammiferi e quindi basandoci su questo tipo in particolare, abbiamo cercato progetti simili per andare a costruire questo data-set che attualmente è uno dei più standardizzati e completi per i mammiferi. Abbiamo poi analizzato i dati acquisiti.

Un lavoro dunque davvero comunitario
Si esatto un lavoro comunitario e standardizzato. Andare sul campo, in questi luoghi è stato affascinante, io in genere lavoro nelle foreste locali dell’Appennino ed è un mondo completamente diverso, e poi misurarsi con una mole di dati così grande e modelli statistici così complessi è stato un percorso di crescita e una sfida grande.
E come si lavora in una foresta?
Io sono stata proprio dentro la foresta anche se per poco tempo, era veramente incredibile quanto fosse rigogliosa rispetto alle nostre foreste temperate, noi siamo abituati a sentieri, strade; lì i sentieri quasi non esistevano e gli operatori di campo che ci hanno accompagnato, le persone locali, conoscevano ogni centimetro della foresta a memoria, quello per me era incredibile. Una esperienza sbalorditiva.
Il rapporto con la popolazione locale? Che tipo di relazione hanno con la foresta?
Una relazione simbiotica: lavorano e vivono a contatto con la foresta. Il centro di ricerca si trova per così dire, all’ingresso della foresta e molte persone che lavorano lì, sono o park-manager o ex cacciatori, ex bracconieri che ora sono diventati guide o operatori tecnici per il monitoraggio della biodiversità in foresta». E prosegue: «La presenza di questo centro di ricerca ha permesso di diminuire la pressione antropica sulla foresta, proprio perché molti bracconieri che cacciavano per sfamarsi e poter sopravvivere sono stati assunti e lavorano per il parco o per il centro di ricerca. Hanno messo a disposizione la loro conoscenza della foresta, cambiando vita. Tanti anni fa, lo stesso prof. Rovero, in queste uscite ha potuto scoprire un mammifero, il toporagno elefante gigante (Rhynchocyon udzungwensis), che sono riusciti a catturare solo grazie a uno di questi tecnici di campo che era un ex cacciatore che aveva le conoscenze e le tecniche per la trappola di questo animale.

Quindi uno studio sui mammiferi che genera un cambiamento antropologico?
Il centro di ricerca in Tanzania cerca di lavorare molto sulla rivalutazione culturale, di come viene gestito il paesaggio, la foresta, si cerca di creare fonti energetiche alternative sostenibili per ridurre l’estrazione di carbone dalla foresta… ci sono diversi progetti. Cercano di dare una svolta agli standard di vita delle popolazioni: non si protegge la foresta col solo monitoraggio ma anche con azioni concrete, tutte azioni documentabili e divulgabili.
Cosa le sta più a cuore nella sua ricerca?
Uno dei messaggi finali del nostro lavoro è cercare di far capire quanto siano importanti le aree protette ma è importante anche il come viene gestito il paesaggio circostante e si diminuisce l’impatto antropico andando, non a regolarizzare chi vive e dove, ma a migliorare gli standard di vita di chi vive lì, attraverso una educazione.
E ora?
«Si spera che i risultati possano impattare le decisioni su come si sceglie di proteggere le foreste tropicali, Noi stiamo portando avanti già un secondo studio e si spera di andare avanti… e che io possa procedere il mio cammino nella vita accademica»!
Auguri per l’arrivo del suo bimbo!
Le foto di questo articolo sono dell’Ufficio stampa dell’Università di Firenze e del gruppo di ricerca.
Nessuno ti regala niente, noi sì
Hai letto questo articolo liberamente, senza essere bloccato dopo le prime righe. Ti è piaciuto? L’hai trovato interessante e utile? Gli articoli online di VITA sono in larga parte accessibili gratuitamente. Ci teniamo sia così per sempre, perché l’informazione è un diritto di tutti. E possiamo farlo grazie al supporto di chi si abbona.
