Cultura
Lavoretti. Perché non possiamo vivere di lavori a basso reddito e che ci rubano il tempo
A partire dagli anni Ottanta il valore del lavoro ha cominciato a degradare rispetto al capitale e da allora la caduta non si è mai arrestata. Dalla delocalizzazione alla moltiplicazione dei contratti atipici. Dall'automazione che affida alle macchine ciò che prima facevano gli uomini. Altro che sharing economy!
di Pietro Piro

Lavoro-ombra
Nel 1981 Ivan Illich pubblicava il libro Shadow Work (Salem, New Hampshire and London: Marion Boyars, 1981). Con l'estrema lucidità e capacità profetica che ha caratterizzato tutta la sua produzione, così descriveva il lavoro ombra: "Il lavoro-ombra nelle società industriali comprende gran parte delle attività domestiche, l’impegno degli acquisti e il consumo forzato, lo studio come preparazione al lavoro, l’andirivieni tra casa e luogo di lavoro, la delega agli esperti della «cura» della propria esistenza e l’attesa ai semafori, “in una parola gran parte di ciò che viene etichettato come vita privata o vita in famiglia”, e che viene spesso definito con eufemismi quali «attività del tempo libero», «attività consumistiche», «volontariato», «shopping». Questo tipo di lavoro non retribuito è «economicamente costrittivo», nel senso che le ideologie economiche “sostengono che deve esser fatto, in quanto componente indispensabile della riproduzione della forza lavoro e dei rapporti di produzione”, per cui “mentre ci si deve dar da fare per ottenere un lavoro salariato, nel lavoro-ombra ci si è ficcati per forza”.[…] Per comprendere bene la natura del lavoro-ombra, bisogna che si tenga sempre ben presente che esso rappresenta una realtà completamente opposta rispetto alle attività di sussistenza, “il lavoro-ombra non assicura la sussistenza della famiglia, ma trasforma, senza retribuzione, merci preconfezionate in beni di consumo”. […] E oggi che il lavoro salariato diviene sempre più rapidamente superfluo, i microprocessori possono produrre merci sempre più scadenti per disoccupati che vengono costretti a un crescente lavoro-ombra in nome di un moderno self-help. L’autodisciplina non retribuita frutto del lavoro-ombra diviene sempre più importante del lavoro salariato ai fini della futura crescita economica. […] il lavoro ombra per ora innominati e inindagato, è diventato quel settore in cui oggi in ogni società industriale la maggioranza, soprattutto le donne, subiscono una dolorosa discriminazione" (Ivan Illich, Lavoro-ombra, Mondadori, Milano, 1985 p. 110-111).
Il lavoro-ombra, secondo Illich, costringeva dunque, un enorme esercito di lavoratori non retribuiti a prestare tempo ed energie per "far girare" la grande ruota panoramica del capitalismo. Recentemente, il sociologo Craig Lambert, ex direttore dell’Harvard Magazine, ha pubblicato un volume con quasi lo stesso titolo di Illich: Il lavoro ombra: tutti i lavori che fate (gratis) senza nemmeno saperlo (Baldini & Castoldi, Milano 2017). Lambert mette in evidenza come oggi, quasi del tutto inconsapevolmente, le persone si fanno carico di un enorme quantità di mansioni (prenotare un viaggio, fare il pieno di benzina da soli, scrivere recensioni, segnalare contenuti, montare mobili, stampare foto e biglietti di teatro e cinema) che prima erano svolte da migliaia di lavoratori addetti a questi compiti e che potevano garantire professionalità, competenza, specializzazione. Più il capitalismo avanza e più mostra le contraddizioni di un sistema di relazioni che tende a estrarre profitto da ogni aspetto della nostra vita: le emozioni, il gioco, le relazioni, il desiderio di viaggiare e di esplorare, la creatività. Il lavoro-ombra svuota di contenuto il lavoro vero e proprio e impoverisce sempre di più la classe media. Abbiamo certamente ignorato la lezione di Marx – perché incapaci di leggere il filosofo di Treviri senza l'accecamento delle ideologie – quando ci avvisava che un eccessiva parcellizzazione del processo lavorativo e una basso reddito rendono il lavoratore sempre più alienato e povero.
L’importante, è che il tempo che gli individui passano a “lavorare” al loro “pieno sviluppo” non è tempo di lavoro, per la semplice ragione che il “lavoro di sviluppo di sé” non è lavoro in senso economico: non è produttivo di “valore” nel senso economico, vale a dire non produce niente di vendibile, niente che sia destinato ad essere scambiato con altre cose. Il pieno sviluppo di sé e l’individuo pienamente sviluppato non sono delle merci
André Gorz
L'economia dei lavoretti
Alienazione e povertà che sembrano dominare un'altra forma di sfruttamento: l'economia dei lavoretti, fenomeno ben analizzato dal recente volume di Riccardo Staglianò, Lavoretti: così la sharing economy ci rende tutti più poveri (Einaudi, Torino 2018).
Il libro è: "una lunga denuncia di una pericolosa impostura linguistica, quella che sta provando a farci credere che «sharing economy» si traduca davvero con «economia della condivisione», con tutto il bene che ne deriverebbe. Un nuovo capitalismo […] che, a dispetto dei termini, piú che condividere […] concentri il grosso dei guadagni nelle mani di pochi, lasciando alle moltitudini di chi li svolge giusto le briciole" (pp. 5-6). Staglianò animato da una volontà ferrea di smontare "i luoghi comuni" che circolano nel discorso ottimistico e rassicurante dei nuovi guru della sharing economy ci dimostra, "dati alla mano" come ad esempio negli Stati Uniti: "nell’ultimo decennio il celebrato recupero dell’occupazione dagli sprofondi della Grande recessione è avvenuto solo grazie a lavori precari. I 9,4 milioni di nuovi assunti, detto altrimenti, sono tutti freelance, part time, a chiamata, interinali, insomma contingent workers. I lavoratori standard, quelli a tempo pieno, sicuri, si sono ridotti invece di 400000 unità. Insomma, e stavolta è lo US Government Accountability Office a fare i conti, l’esercito dei non standard nel 2010 ha toccato il record inedito del 40,4 per cento del totale (dal 30,6 di soli cinque anni prima)" (p. 10).
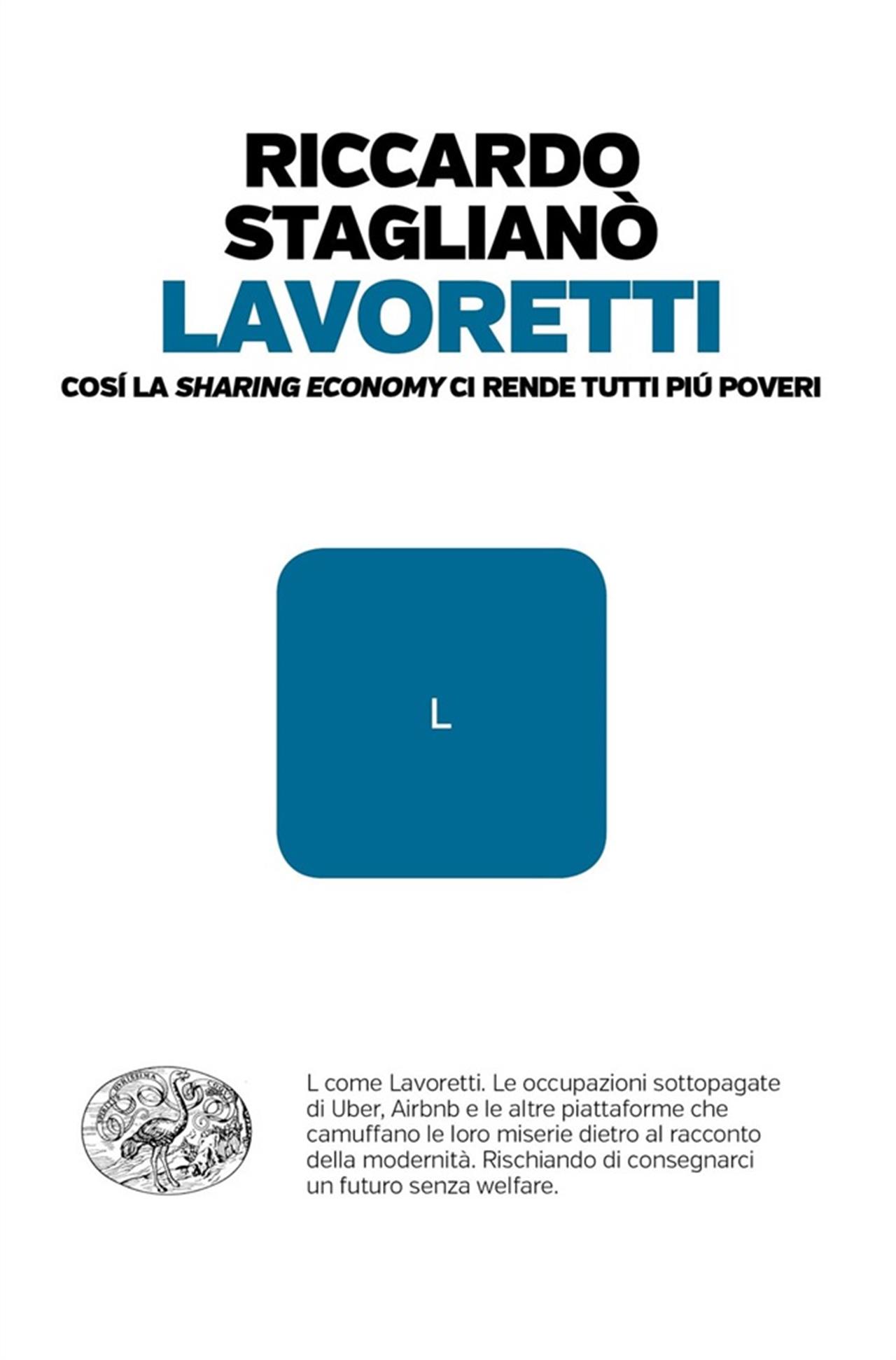
Il lavoro "nutriente" capace di sostenere e far progredire nella società diventa sempre più difficile da trovare e aumenta sempre di più la quantità di lavoro malpagato, precario, frammentato, anonimo. Scrive Staglianò: "Il capitalismo delle piattaforme interpella la dicotomia presente/futuro anche da un altro punto di vista. Con paghe misere e diritti all’osso impoverisce i lavoratori oggi, compromettendone la capacità di spesa e la solidità esistenziale. Ma mette a repentaglio anche il loro domani perché, in assenza di contributi versati e in presenza di un sistema per minimizzare le tasse che non ha precedenti, spinge lo stato sociale verso un punto di rottura. Chi pagherà per le cure di cui avranno bisogno da vecchi visto che i loro datori di lavoro, che mettono mano alla pistola se solo provi a chiamarli cosí, avranno versato un’inezia di tasse e perlopiú altrove? La gig economy presuppone una perma-giovinezza, l’energia inesausta di accettare una corsa dopo l’altra e non essere nemmeno sfiorati dal sospetto che un giorno quei ritmi presenteranno il conto. Significa affrontare ogni lavoro come se fosse l’ultimo. Come se non ci fosse un domani, che da metafora rischia di diventare cronaca" (p. 14). Questo progressivo impoverimento della qualità del lavoro è supportato da una retorica aggressiva e da una incapacità tutta politica di riuscire a governare i cambiamenti (p. 16). Il vuoto politico e sociale si trasforma in un vuoto legislativo e in questo vuoto, gli imprenditori più rapaci costruiscono imperi globali in cui "il cliente ha sempre ragione" e il lavoratore conta meno di nulla. Il libro di Staglianò è un lungo viaggio nelle condizioni di vita di migliaia di persone che, ogni giorno, nella più completa oscurità e mancanza di riconoscimento sociale, guidano auto a noleggio, correggono testi e censurano video raccapriccianti, scrivono recensioni per merci di ogni genere, descrivono la qualità di cibi, bevande, alberghi e ristoranti, affittano camere, correggono frammenti di algoritmi, controllano opinioni, inseriscono video pubblicitari, vendono desideri, trasformano sogni in ordinazioni.
Come è stato possibile?
Ma come è stato possibile accettare condizioni salariali e occupazionali così degradanti? Secondo Staglianò: "La gig economy, […], non sarebbe esistita senza la crisi del 2007-2008. La seconda è la premessa della prima. La sua giustificazione pratica: «Non arrivate piú alla fine del mese? Arrotondate con i lavoretti». Ciò che non è stato ancora detto, invece, è che praticamente ogni altro importante assalto al lavoro negli ultimi quarant’anni è stato preceduto da una crisi. In una dinamica che richiama la shock doctrine teorizzata da Naomi Klein, a quanto pare non c’è niente come un bel trauma per far digerire un intervento ancora piú traumatico. Per semplicità citerò solo due esempi di una casistica ben più articolata. Il primo riguarda la crisi degli anni Settanta, con gli shock petroliferi, il rallentamento della produzione e dei consumi e le successive feroci lotte antisindacali, la finanziarizzazione dell’economia e l’inizio dell’automazione informatica che segna l’inizio della guerra al lavoro cosí come l’avevamo conosciuto dal Dopoguerra. Il secondo coincide con la stagione della New Economy durante la quale ci si era illusi, complici le banche d’affari e i loro interessati analisti, che bastasse aggiungere il suffisso .com alla propria ragione sociale per diventare la prossima Amazon. Con il relativo sboom del 2000 che, pur spazzando via quella perniciosa mistificazione, non è riuscito a sradicare l’idea eversiva secondo la quale internet tante merci per cui si era sempre pagato sono diventate gratuite. E anzi rilanciandola con l’invenzione perversa del suo secondo tempo a costo zero: il web 2.0 in cui il lavoro, non retribuito, lo facevano gli stessi utenti mentre i profitti li incassavano Google, Facebook e gli altri padroni delle piattaforme" (pp. 46-47).
Non è forse il sogno più grande di un capitalismo di rapina quello di estrarre profitto tagliando completamente il costo del lavoro? E non è forse ancora più preoccupante il fatto che tutto questo avviene grazie all'illusione condivisa di stare facendo qualcosa che "aumenta il benessere e la libertà personale" e che, alla fine, ci fa pure risparmiare? Peccato che questo risparmio si trasformi in profitto per pochissimi e povertà diffusa per chi ha come unica alternativa quella di dedicarsi a un lavoretto. Infatti: "le minori tasse che la gig economy rastrella non si trasformano in asili pubblici, cliniche per gli anziani e tante altre cose preziose le cui alternative private sono molto piú care ed erodono ulteriormente il già limitato potere d’acquisto del ceto medio. Insomma: quello che risparmiamo oggi lo ripaghiamo con gli interessi domani in un saldo niente affatto positivo e ancora poco compreso tanto dagli elettori quanto, all’evidenza, dagli eletti" (p. 76). Leggendo il libro di Staglianò si ha l'impressione che la sharing economy non sia affatto una vera economia della condivisione ma un potente apparato retorico che funge da sedativo in grado di anestetizzarci dal dolore della perdita di lavori forti, duraturi, socialmente riconosciuti e riconoscibili e che costruivano la cittadinanza e l'appartenenza a una comunità. Scrive Staglianò: "l’automazione […] con i computer, i robot e l’intelligenza artificiale è diventata sempre piu sapiente nel fare a meno di noi. Infine la gig economy che non ci sostituisce ma ci paga un’inezia e non ci riconosce come controparti degne di diritti. Al grido di «pochi, maledetti e subito» ci apparecchia un futuro di stenti. A meno che non ci svegliamo e corriamo ai ripari" (p. 231).
Il nuovo che avanza
A mio modestissimo avviso, è sempre più evidente che il "nuovo che avanza" si porta dietro delle contraddizioni e delle "perversioni" che sanno di vecchio e che con un linguaggio che abbiamo troppo velocemente archiviato, un tempo chiamavamo con nomi precisi: alienazione, sfruttamento, esercito di riserva. Oggi ci piace giocare con termini nuovi che descrivono un mondo aperto, pieno di possibilità, di avventure, di occasioni. Peccato che siano sempre troppo pochi gli "eletti" che possono goderne pienamente. Si parla molto di "qualità del lavoro" opposto alla quantità. Ma sembra quasi un mantra consolatorio di fronte al progressivo degradarsi delle relazioni, dei rapporti tra persona e persona. La qualità del lavoro si costruisce solo se esistono dei "fini" oltre il mero sforzo dedicato al lavoro. Credo che questa sia stata la grande intuizione di Adriano Olivetti quando indicava nel lavoro la base solida su cui costruire una nuova idea di comunità. Il lavoro diventa sempre più povero perché a parte il mero accumulo di profitto e il "freddo pagamento in contanti", si stanno polverizzando le idealità che partendo dal lavoro possono rendere la vita più degna di essere vissuta. In questa dinamica perversa, il lavoro rischia di diventare unicamente "condanna e sofferenza" e non strumento di crescita umana e sociale. La regressione del lavoro a mero sfruttamento è un processo in atto che passa direttamente dall'attacco frontale a tutte le forme di rivendicazione sindacale, al diritto allo sciopero, all'autogestione, all'autonomia. Il crollo delle ideologie "socialiste" che ponevano al centro della società "il lavoratore" ha lasciato il campo libero a una progressiva ideologia di svalutazione della persona che lavora e ha esaltato il profitto come misura del successo e della realizzazione personale. Oggi ci troviamo di fronte a un bivio. O rimettiamo al centro la persona che lavora come fattore determinante della costruzione della società, oppure, necessariamente, dobbiamo inventare una nuova società in cui tutti i rapporti sono trasformati e rinnovati. Una società post-lavoro. Chi è pronto a "pensare l'esodo dalla società del lavoro e della merce"?
17 centesimi al giorno sono troppi?
Poco più di un euro a settimana, un caffè al bar o forse meno. 60 euro l’anno per tutti i contenuti di VITA, gli articoli online senza pubblicità, i magazine, le newsletter, i podcast, le infografiche e i libri digitali. Ma soprattutto per aiutarci a raccontare il sociale con sempre maggiore forza e incisività.
