Cultura
Jane Jacobs e la sindrome etica
È uscita, per Eleuthera, una raccolta di opere di Jane Jacobs, intitolata Città e libertà. Un libro importante che permette di confrontarci una raffinatissima interprete del «territorio urbano» che pensava che ogni città dovesse essere «pensata dal basso, a partire dai bisogni della gente»

«Fourier si rappresenta la psicologia collettiva come un meccanismo a orologeria. L’armonia fourierista è il prodotto necessario di questo gioco combinato», scrive Walter Benjamin nei "Passages” di Parigi.
Questa citazione di Benjamin mi concede di scrivere sulle relazioni tra la psiche e la dimensione urbana, si tratta della condivisione di uno stesso punto di vista, così come esistono grandi modelli autoritari nella clinica, esistono grandi modelli autoritari in urbanistica. Michel Foucault accomunerebbe queste due pratiche, disconnesse sul piano disciplinare, dentro una medesima epistemologia del potere nella dimensione della produzione discorsiva.
È uscita, per Eleuthera, una raccolta di opere di Jane Jacobs, intitolata Città e libertà, a cura di Michela Barzi. In italiano uscì Vita e morte delle grandi città, riedito oltre dieci anni fa da Einaudi. Non c’è da stupirsi, altri testi di grande importanza rimangono in lingua originale, l’autrice è controversa e l’editoria oggi non spicca per coraggio.
L’operazione di Eleuthera è, a maggior ragione, importante. Dunque, grazie a Michela Barzi per averci fornito, dopo anni, lo sguardo urbano di Jacobs, che certo non piace a molti uomini di potere. Tradurla in un’epoca in cui l’oscurantismo disciplinare sta diventando totalitario, è una scelta importante.
Difficile definire l’appartenenza disciplinare di Jacobs, che ha fatto corsi universitari, ma non si è laureata, come capita a volte alle persone geniali, che male si adattano alle rigidità accademiche.
Jane Jacobs è stata, in primo luogo, una contestatrice. Ha contestato la pretesa universalità delle discipline. La sua ricerca si dispiega intorno al territorio urbano. Urbanista? Ma aveva idee del tutto in contrasto con il mainstream accademico degli urbanisti e dei grandi architetti; sociologa urbana? Ma era lontana dalle categorie sociologiche classiche. Così come Benjamin osservava la caducità dei gradi progetti parigini di epoca imperiale – l’ideologia urbanistica del Barone Haussmann e di Fourier – anche lei, una trentina d’anni dopo, osservava la continuazione di questa ideologia monumentale attraverso l’opera di Robert Moses a New York, e di altri grandi centri urbani Nord-Americani.
Jacobs è studiata dagli antropologi, punto di riferimento per l’antropologia urbana, un sistema di studi che si occupa della progettazione dal basso, al servizio di chi già abita quel quartiere, che si occupa di territorio urbano attraverso l’osservazione partecipante delle abitudini e consuetudini della gente di quartiere, delle loro relazioni, dei luoghi di ritrovo e delle passeggiate comuni.
Posizione eterotopica, che si guarda dall’applicazione cieca di modelli urbani calati dall’alto, da teorie astratte, da idee urbanistiche e architettoniche autoritarie – potremmo aggiungere scientistiche – in cui le moltitudini, i minuti particolari, le singolarità vengono trascurate a vantaggio di modelli astratti e autoritari. L’architettura e l’urbanistica partono dall’alto di uno sguardo estetizzante, ma vuoto. Un’estetica della borsa valori, dalle grandi dimensioni, che ha un potere ipnotico, soprattutto, nei confronti degli intellettuali. Jacobs capovolge lo sguardo.
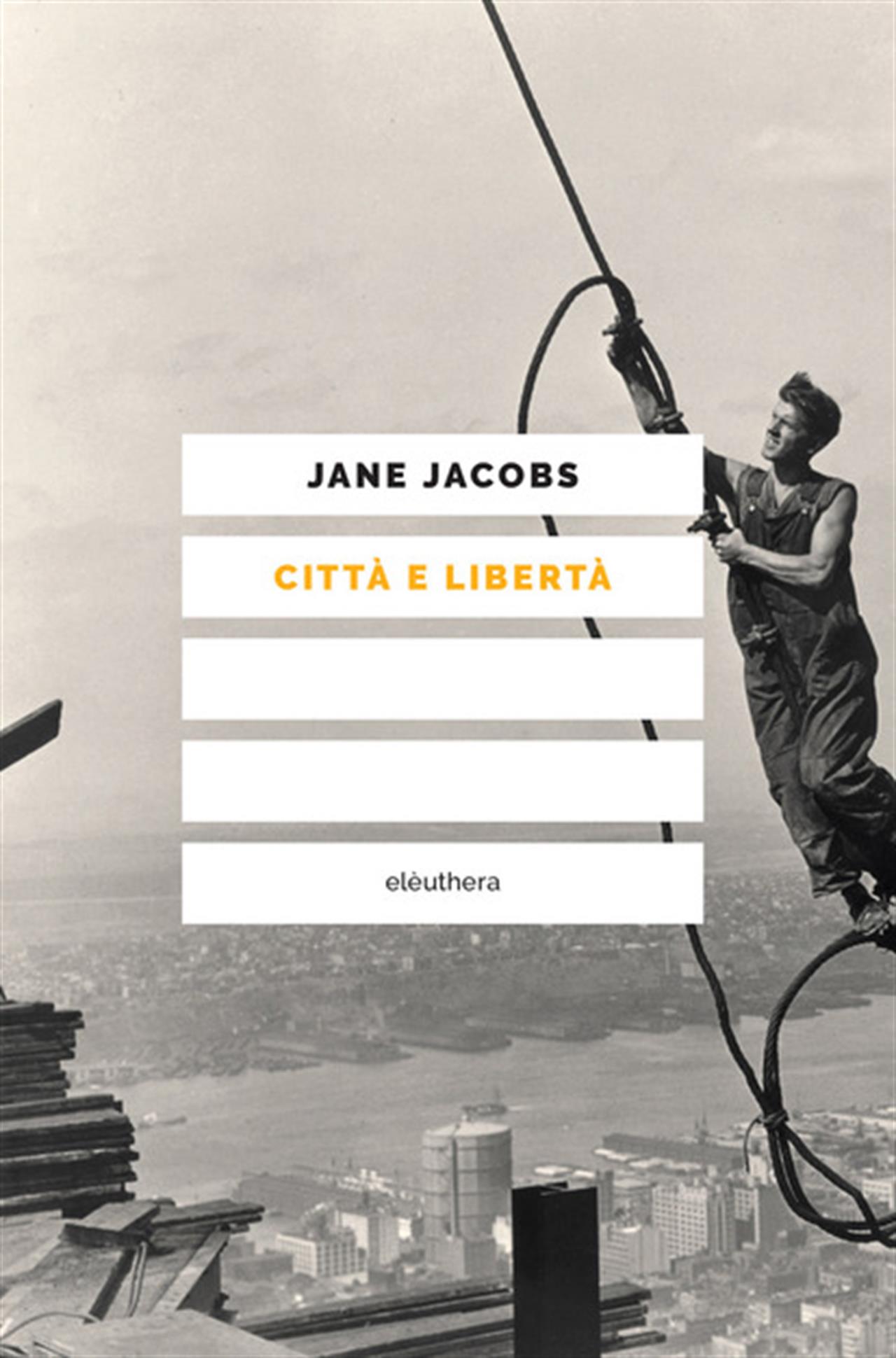
Fine osservatrice della vita quotidiana della grande città, dei bisogni e dei desideri delle moltitudini che la abitano, la sua lettura, oltre a Benjamin, evoca anche Alfred Schutz, allievo di Edmund Husserl, cacciato dall’Europa durante il fascismo. Schutz sviluppa un metodo di osservazione definito “tecnica dello straniero”. Di lui, Jacobs, giovane donna che arriva a New York da un angolo della Pennsylvania, assume per definizione lo sguardo estraniato, che non si lascia incantare dal dato-per-scontato, che rimette in discussione tutte le premesse e gli sguardi “esperti”.
Benjamin, Schutz; la terza forza ispiratrice è, per me, James Joyce. Sul piano letterario viene in mente lo stream of consciousness: le interrogazioni di Dedalus ai suoi allievi, Leopold Bloom che esce di casa per comprarsi un rognone di castrato per colazione, la carrozza che trasporta Bloom e colleghi al cimitero, ecc. La minuta descrizione di ciò che pensano, vedono le persone, dei sentimenti, della conversazioni occasionali.
L’idea di Jacobs è che una città deve essere pensata dal basso, a partire dai bisogni della gente che ci abita, che criteri estetici disincarnati e progettati dall’alto distruggono la città come luogo di scambio e di interazione tra chi ci vive. Che, per tornare a Joyce, i mattoni marroni, tipico mobilio delle case di Dublino, vanno lasciati stare, non abbattuti.
Ma Jane Jacobs, differentemente da Schutz, che aveva capovolto lo sguardo sociologico, e da Benjamin, inarrivabile osservatore della materialità delle cose, aveva anche combattuto, contestato, cercato di fermare gli scempi urbani. Se Jacobs è flaneur, e lo è, è flaneur ribelle, apertamente contestatrice. Viene infatti incarcerata nel 1968 per la protesta contro i piani di distruzione di Greenwich Village a Manhattan e, dopo il carcere, si trasferisce a Tronto, in Canada.
La lettura di Jane Jacobs, non solo di Città e Libertà, ma anche di altri testi della sua numerosa bibliografia, mi ha anche dato modo di cogliere gli aspetti di un approccio epistemologico che condivido: quello di non innamorarsi troppo di un’ideologia o di una estetica disincarnata, che spesso trasforma l’autore in autorità, che sostituisce il piano di immanenza – il colloquio e l’osservazione di ciò che accade – con teorie astratte, imponendo il proprio sguardo come “scientifico” in virtù di valutazioni create per validare l’ideologia.
Nel leggere Jane Jacobs, mi sono ricordato di alcune esperienze giovanili di partecipazione, negli anni Settanta, ai Comitati di quartiere delle aree centrali di Milano: Porta Romana, Porta Ticinese, Porta Garibaldi. I cittadini del quartiere, i comitati inquilini, le forze politiche locali si trovavano per avere un equo canone di affitto e per impedire alle grandi immobiliari e ai grandi proprietari di case di abbattere i quartieri, anziché ristrutturare le case, mantenendo dentro gli stessi inquilini. Fu una gioiosa utopia fallimentare, visto che oggi, in quelle zone, un appartamento può venire acquistato, o anche solo affittato, solo da famiglie con redditi elevatissimi.

La città diventa luogo delle classi alte, roccaforte di una cultura che non include più le generazioni operaie, le sacche di povertà e le dà in pasto alle peggiori demagogie sub-culturali, spesso aggiungendo il disprezzo, un tempo tipico della nobiltà, oggi presente nella borghesia intellettuale, che, a volte, si dichiara di sinistra.
Mi sono anche ricordato di Brasilia. L’invenzione urbanistica di Lucio Costa e Oscar Niemeyer, i cui edifici, in pieno deterioramento, mi capitò di visitare qualche anno fa. Brasilia, in nome del recupero delle povertà degli indios, realizzò l’emarginazione e l’inquinamento della foresta amazzonica. Grandi boulevard, centri religiosi e amministrativi monumentali, dimensioni architettoniche enormi, enormi viali, che, anche qui, ispirano ideologie narcisiste, emarginando le popolazioni povere.
L’idea di città satelliti, come la Brasilia di Oscar Niemeyer e Lúcio Costa, o di quartieri popolari orientati all’ideologia di Furier di phalanstère, unità integrate di migliaia di persone, in unità di abitazione standardizzate – come nelle opere di Le Corbusier a Berlino o a Marsiglia – sono esattamente l’opposto di quanto Jane Jacobs pensava, quando pensava le città.
Quel tipo di urbanistica è totalitarismo, come Karl-Marx-Alle a Berlino, o un pezzo di totalitarismo innestato dentro le democrazie, come il quartiere Zen di Palermo.
In uno dei suoi ultimi libri – ne ha scritti innumerevoli, modificando, come ogni persona di cultura, le sue posizioni – Systems of Survival, del 1992, Jacobs esplicita la sua posizione etica parlando di sue sindromi differenti. Benché la parola “sindrome” non sia considerata che una metafora ripresa dalla medicina, essa si compone, come in medicina, di “sintomi”, che, trasformati in segni, orientano la diagnosi clinica. Jacobs distingue la sindrome etica del guardiano dalla sindrome etica del commercio. Si riferisce al mantenimento della presenza del piccolo commerciante di quartiere, come il macellaio di Bloom, nell’Ulisse.
Oggi invece le due etiche sembrano avere trovato la loro sintesi nei centri urbani dove compri solo le grandi marche e ti rivolgi solo ai supermercati: i mall, gli outlet. L’idea potrebbe essere che, prima di mettere mano a una città, a un quartiere, a una casa, sarebbe d’uopo che l’architetto andasse a prendersi un rognone di castrato alle otto del mattino presso il macellaio d’angolo e rimanesse a vivere là per almeno un mese, così capirebbe che cosa va a distruggere nel mettere in atto un progetto che scaturisce dalla sua testa. È un’ottima occasione per vedere un interessante corto di Nanni Moretti: The Last Customer.
17 centesimi al giorno sono troppi?
Poco più di un euro a settimana, un caffè al bar o forse meno. 60 euro l’anno per tutti i contenuti di VITA, gli articoli online senza pubblicità, i magazine, le newsletter, i podcast, le infografiche e i libri digitali. Ma soprattutto per aiutarci a raccontare il sociale con sempre maggiore forza e incisività.
