Abbiamo chiesto a Emmanuele Curti, archeologo e manager culturale, animatore de Lo Stato dei Luoghi di leggere per noi l’ultimo libro di Vito Teti, La restanza. Da quel libro e dall’incontro con il grande antropologo calabrese è nato questo dialogo (la versione integrale su vita.it) che offre uno spaccato esemplare della potenza dello sguardo che i più floridi esponenti del pensiero meridiano riescono oggi a esprimere sul Sud.
Emmanuele Curti: La parola “restanza” era un parola che non mi convinceva, ma era elemento di continuo confronto e sollecitazione interiore: il tuo libro, è stupendamente e positivamente inquieto — così come dici tu stesso ricordando i richiami di tua madre quando eri piccolo, dove “restanza” appare quasi come una contraddizione. “Restanza” quindi come elemento di un continuo confrontarsi con se stessi, con la propria anima, il proprio senso di memoria e nostalgia. Come nasce questa parola?

Ora io penso che il restare in questo periodo non abbia nulla di salvifico, se parliamo di restare nei piccoli centri, perché lo spopolamento a cui assistiamo, che comporta la dissoluzione dei rapporti tradizionali, dei rapporti primari nei legami con la terra, rende molto faticosa la scelta di restare. In questo periodo vivo un senso di grande disagio e patimento (non so se è legato all’età) nell’assistere allo svuotamento del paese in cui io sono nato e che io però ho conosciuto pieno, complesso e vitale. Mentre adesso lo vedo spento, morto e inevitabilmente ne patisco a livello personale. Il paese si svuota e mancano le generazioni di ricambio: le case piene sono diventate case vuote, le strade vivaci popolate da bambini, animali, persone, non ci sono più, i bar chiudono, non ci sono più centri sociali, sezioni di partito, biblioteche. Sono luoghi che per abitarli li devi amare, ma li ami se cerchi di cambiarli. Non perché tornino non allo stato precedente: un restare che richiede sofferenza e non compiacimento, impegno e non apatia, voglia di creare una nuova comunità, un nuovo luogo abitabile, con nuovi rapporti, possibilmente con un legame con il mondo di prima. Questo può nascere solo dagli abitanti del luogo: se in un posto vuoto arrivassero mille stranieri, quel luogo avrebbe solo il carattere fisico, ma non avrebbe certamente l’anima o la memoria del suo essere. Da qui la mia discussione sulle case vendute ad un euro: la casa non è solo un fatto economico, nasce da un contesto urbano, era frutto di sacrifici, era luogo di prossimità alla chiesa, ai luoghi di lavoro. Era frutto di sedimentazioni produttive, culturali, spesso secolari: una casa ad un euro non significa nulla, rischia di diventare una versione aggiornata di un villaggio per vacanze.

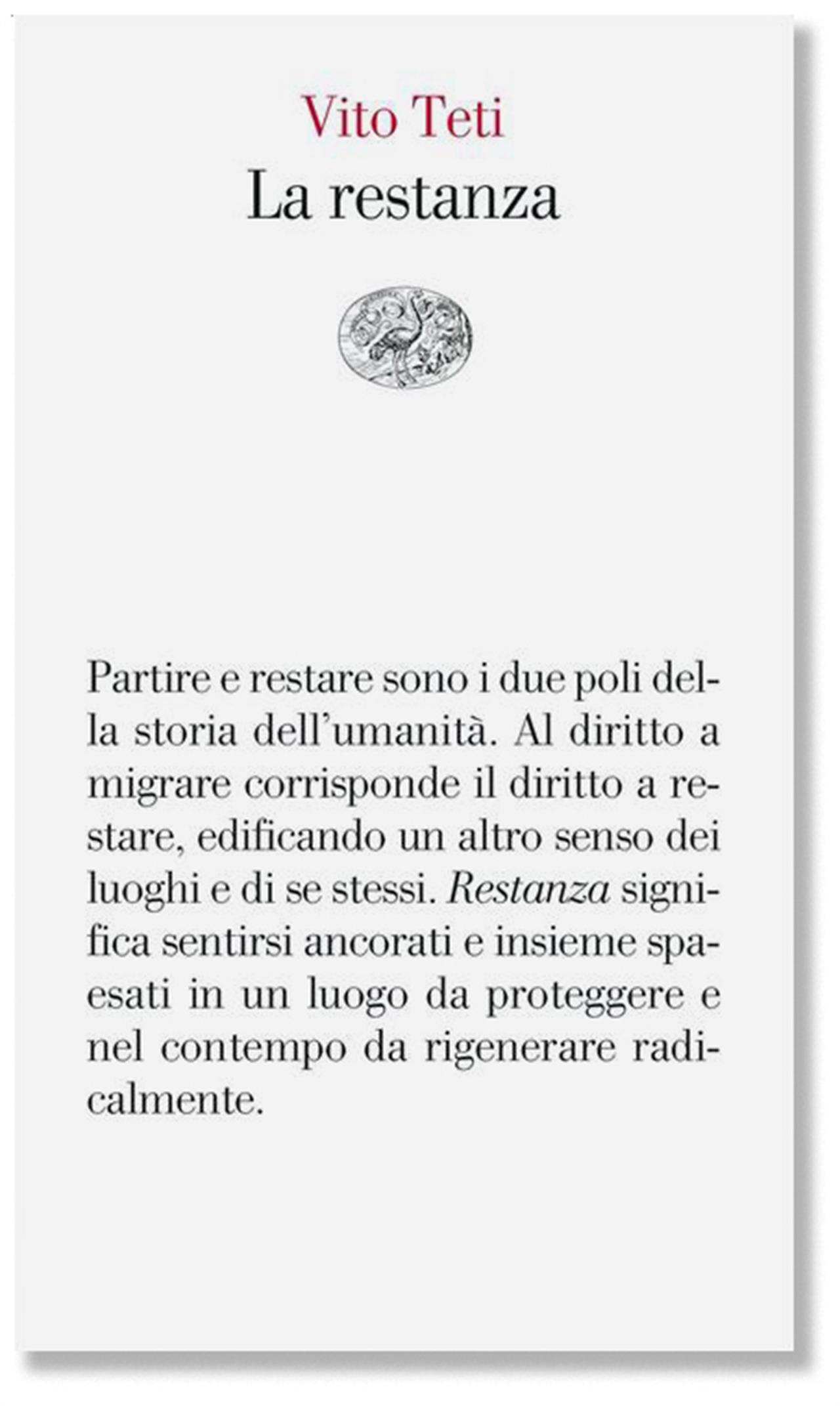
EC: La lettura di questo libro è un continuo viaggio, anche fra le diverse pagine: mi sono ritrovato spesso a tornare indietro, a restare su alcune tue frasi, a soffermarmi (nei tuoi discorsi in particolare sulle mappe, sulla memoria, sulla nostalgia) per poi ripartire. È un testo forte, pieno di stratigrafie, molto emozionali. Mi ha fatto tornare in mente una parola sanscrita studiata da un tuo collega antropologo francese, Charles Malamoud, a cui sono molto legato, “smara”’ che significa “memoria ed amore”. Ma a questo si contrappone un altro pseudo innamoramento, quello della retorica dei borghi (con il quale spesso si intreccia un’altra parola, “resilienza” che io non sopporto più). Siamo alla vigilia di una grande operazione con i fondi del Pnrr proprio sui borghi: come senti tu questo “tornare ai borghi”, in atteggiamento neoromantico della politica?
VT: Sta uscendo un nuovo libro per Donzelli che abbiamo intitolato Contro i borghi, proprio per far capire la diversa visione. Ecco, io sono nato in un paese (San Nicola da Crissa, in provincia di Vibo Valentia) che allora contava 5mila abitanti, ho assistito alla partenza di quasi tutti i miei compagni di scuola, poi abbiamo capito che quelli che erano partiti per tornare, non sarebbero più tornati. Ho visto quindi morire in un certo senso questo paese e ho capito che la soluzione non può essere quella di chi guarda al borgo: per favore, non chiamate borgo il mio paese, perché è qualcosa di diverso da questa visione, come dici tu, neoromantica, sdolcinata, per cui questi luoghi sarebbero i luoghi della lentezza, dello star bene, perché questa rappresenta una costruzione metastorica. La prima operazione da fare è decostruire questa impostazione quasi volontaristica: basta tornare in un borgo come se si animasse da sé solo perché tu sei tornato (o arrivato).
La cosa è più complessa, non vedo soluzioni se passa la logica di intervenire sugli abitati e sulle infrastrutture: intendiamoci, i paesi hanno bisogno di strutture che li rendano abitabili e questo potrebbe innescare nuovi meccanismi economici. Ma il recupero del palazzo vuoto in un quartiere vuoto sarebbe solo l’ennesimo spreco di denaro. Si dovrebbe partire da politiche per l’incremento demografico, i cui risultati si percepirebbero solo fra 20 anni: ci dovrebbe essere politiche per le famiglie, per finanziare le piccole imprese, in particolare coloro che tornano al lavoro della terra e al recupero di vecchi prodotti. L’altra scelta è quella di impedire, non in maniera forzata, le nuove partenza: da recenti indagini, i giovani, rispetto al passato, non vorrebbero più partire. L’ho visto all’università: mentre prima al 90% i miei studenti voleva andarsene, ora per loro il mito delle grandi città si è attenuato, e quindi, se ci fossero le condizioni, preferirebbero stare qui. Bisogna creare le condizioni per il lavoro, creare centri di socialità, occuparsi della comunità, delle relazioni, della memoria.
Trattiamo questi giovani come custodi dei luoghi, del territorio: penso a una forma di reddito/sostegno, perché “guardi” il paese, perché lo curi, perché individui cosa produrre, perché in forma attiva e creativa lo renda abitabile. Un compenso non mortificante, che dia soddisfazione, che costruisca fiducia: il problema di questi paesi non è solo il vuoto di per sé, ma proprio il vuoto di fiducia. Tutto questo potrebbe innescare dei meccanismi virtuosi e indicare una visione per il futuro.

È un testo forte, pieno di stratigrafie, molto emozionali. Mi ha fatto tornare in mente una parola sanscrita studiata dall' antropologo francese, Charles Malamoud, a cui sono molto legato, “smara”’ che significa “memoria ed amore”
Emmanuele Curti
EC: Usi poco la parola “cura” nelle pagine del libro, per poi farla esplodere nell’ultimo capitolo, quasi come summa della tua “restanza”…
VT: Tu mi dai la possibilità di rimarcare un aspetto: io non penso al restare solo nei piccoli paesi. Questo abitare riguarda il piccolo paese, ma anche le città, da nord a sud: un diverso rapporto con i luoghi unifica l’Italia. Ma è chiaro comunque che questa mia visione incroci principalmente temi e problemi della questione meridionale. Varrebbe in questo senso la pena adoperare “cura” accostato al termine “riguardo” come diceva Franco Cassano nella pagine più belle de ‘Il pensiero meridiano’. Adoperare un nuovo sguardo, e, come diceva nel 1905 Olindo Malagodi, guardare le montagne non dalle marine, parlando di Calabria, ma la montagna dalla montagna. Guardare in modo diverso i luoghi, quindi, ma allo stesso tempo avere “riguardo” dei luoghi, attenzione, premura, prima che inizino a morire, non dopo. Cura per prevenire: ascoltare il corpo/paese, e se una declinazione meridionale può esserci, io partirei da un sentimento di pietas per chi non sta bene e va curato, per non decretare la morte prima che accada.
Foto di apertura: Il borgo di Taurianova in provincia di Reggio Calabria. Il comune ormai conta meno di 15mila abitanti – Ag. Sintesi
Nessuno ti regala niente, noi sì
Hai letto questo articolo liberamente, senza essere bloccato dopo le prime righe. Ti è piaciuto? L’hai trovato interessante e utile? Gli articoli online di VITA sono in larga parte accessibili gratuitamente. Ci teniamo sia così per sempre, perché l’informazione è un diritto di tutti. E possiamo farlo grazie al supporto di chi si abbona.

