Cultura
Innovare o distruggere? Il dilemma etico dell’innovazione
«Distruggi o sarai distrutto» afferma il venture capitalist Josh Linkner. Una convinzione che sembra guidare gran parte di quella teoria del cambiamento che, dal 1995, va sotto il nome di "disruptive innovation". Un libro di Fabio Menghini colma un vuoto tutto italiano sull'argomento e apre il campo al dibattito: è vera innovazione?
di Marco Dotti

Innovare o distruggere? Fino a pochi anni fa, era questo il dilemma. Poi le cose sono cambiate, nell'economia e nel mondo, e comiciò a farsi spazio un'idea di crescita legata all'"innovazione distruttiva". Tra i 50 uomini più influenti al mondo secondo Forbes, Clayton M. Christensen è professore di business administration a Harvard, imprenditore ma anche missionario e pastore. Sulle pagine della "Harvard Business Review", Christensen firmò a quattro mani con Joseph Bower un articolo titolato Disruptive Technologies: Catching the Wave che ha una copertura teorica a questo processo.
L'uso intensivo del web aziendale e commerciale nel 1995 si stava ancora sviluppando, le tecnologie digitali erano in una fase di rapida evoluzione: forse proprio per questo, da allora, disruptive innovation, internet e new economy sono diventati fenomeni fortemente interconnessi.
Né Christensen – che nel '97 amplierà le proprie tesi nel libro The Innovator's Dilemma – né altri si aspettavano però che un’intera generazione avventurieri della rete – da Steve Jobs con gli iPad e gli iPhone a Jeff Bezos con Amazon o Larry Page con Google e Zuckerberg con Facebook– avrebbero fatto della disruption la propria parola d’ordine e di azione. Un nuovo credo («distruggi o sarai distrutto») si era radicato nel mondo. Un credo alimentato da un ottimismo che pareva senza freni. A partire da quello di Christensen.
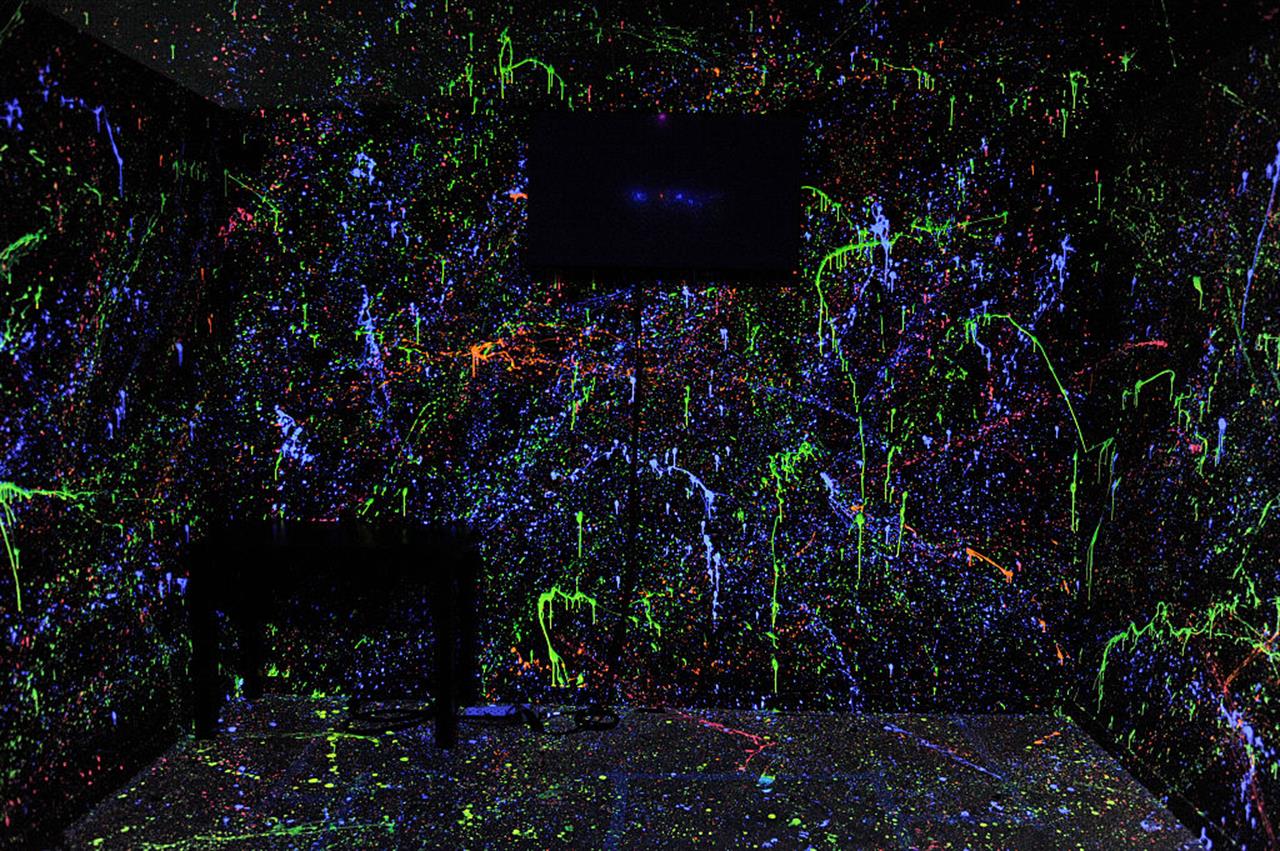
Ma che cos'è un ottimista? Osservava più di un secolo fa Karl Kraus che un ottimista è solo una persona poco informata dei fatti. Così deve averla pensata Jill Lepore, storica di professione e collega a Harvard di Christensen che nel giugno di due anni fa, sul"Newyorker", con l'articolo The Disruption machine ha non solo contestato i dati dello studio di Christensen, ma per la prima volta impresso al termine "disruption" – traducibile come "disturbo", "intralcio", ma anche come "frattura", in riferimento allo scisma della Chiesa scozzese – un'accezione negativa. Tanto è bastato affinché si diradassero le nubi e anche gli "ottimisti" cominciassero a ragionare.
«Disruptive innovation is a competitive strategy for an age sized by terror», osserva Jill Lepore, spiegando come dietro la parola "disruption" si cela una visione del mondo fatta di panico e terrere infusi a colpi di cambiamento. Si poteva essere d'accordo o meno con la Lepore, ma il dado era tratto. Il dibattito sulle nuove tecnologie e sul loro effetto dirompente (disruptive) è, oggi, con un ritardo di 20 anni, al centro dell'attenzione di molti. Troppo tardi? Chissà.

Così, per orientarsi e capire e non darsi per vinti, è davvero utile la lettura di un volume di Fabio Menghini Disruptive innovation: economia e cultura nell’era delle start-up (sottotitolo: Come la Internet generation – Jobs, Jeff, Zuckerberg – è diventata disruptive) da edito da GoWare. Menghini, economista della scuola di Giorgio Fuà, colma un vuoto tutto italiano sull'argomento e invita a gettare uno sguardo sistemico sull'economia. il sociale e sugli effetti di questa leva: che cosa accadeva mentre i capitani della rete si avventuravano tra le acque della net-economy? Tutto? Niente? Cosa cambiava in basso, non solo dal settimo piano in su.
Anni di stagnazione, interi settori commerciali e industriali ridotti al grado zero o scomparsi. Crisi senza fine. Grandi speranze, grandi capitali, ma pochissimi posti di lavoro creati. C'è un filo che lega certe oasi della Silicon Valley al deserto del mondo. E se fosse proprio la disruptive technology?
Distruggi o sarai distrutto
Josh Linkner (venture capitalist)
Giustamente, come scrive Menghini, «la fama guadagnata in breve tempo dalla teoria della disruptive
innovation e il credito conquistato dall’autore presso i CEO dei più grandi gruppi americani l’hanno prematuramente trasformata in una specie di dogma. Come tale, impossibile da mettere in discussione. Forse per questo alla fine, anche nel mondo accademico, pochi si sono presi la briga di lavorare sui presupposti di tale concezione dell’innovazione».
La disruptive innovation non è stata sottoposta a un esame sufficientemente attento, un po’ perché va a tutta velocità, al contrario dell’indagine critica, un po’ perché i suoi sostenitori ridicolizzano gli scettici accusandoli di essere retrogradi, come se criticare una teoria del cambiamento significasse condannare il cambiamento stesso, e un po’ perché oggi l’innovazione è legata all’idea che il progresso sia come un pupazzo a molla schiacciato in una scatola
Jill Lepore
In questa continua proposta di mezzi senza fini, Jill Lepore – il cui saggio è raccolto nel volume – parlava non a caso di un «vangelo dell’innovazione» distruttiva e di «una teoria senza critica» dai devastanti effetti socio-economici. Ogni idea, grande o piccola che sia, nella storia del pensiero umano ha sempre avuto critiche. Grandi o piccole a loro volta. La disruption, no. Si tratta, in qualche modo, della prima teoria di un mutamento che non ha raccolto critiche. Una sorta di ideologia del progresso spogliato dalle componenti e dalle aspirazioni progressiste.

La disruptive innovation, osserva Lepore, che porta a riguardo decide di case studies paradigmatici e interessanti, in quanto spiegazione del cambiamento «non è stata sottoposta a un esame sufficientemente attento, un po’ perché va a tutta velocità, al contrario dell’indagine critica, un po’ perché i suoi sostenitori ridicolizzano gli scettici accusandoli di essere retrogradi, come se criticare una teoria del cambiamento significasse condannare il cambiamento stesso, e un po’ perché oggi l’innovazione è legata all’idea che il progresso sia come un pupazzo a molla schiacciato in una scatola a prova di critica».
Il sospetto è che dietro la disruptive innovation si celi un'aspirazione gerarchiaca, una sorta di neufeudalesimo espiatorio la cui vittima principale, una volta chiuso il cerchio, sarebbero, manco a dirlo cooperazione e collaborazione. Il sociale verrebbe allora "sussunto" in un algoritmo. E sparirebbe. Fosse così, sarebbe davvero un guaio per tutti.
In copertina: 50 robot alla Shandong Cultural Industries Fair (SDCIF), Jinan International Convention & Exhibition Center 25 agosto 2016 (VCG/Getty Images)
Vuoi accedere all'archivio di VITA?
Con un abbonamento annuale potrai sfogliare più di 50 numeri del nostro magazine, da gennaio 2020 ad oggi: ogni numero una storia sempre attuale. Oltre a tutti i contenuti extra come le newsletter tematiche, i podcast, le infografiche e gli approfondimenti.
