Psichiatria
In Europa, la salute mentale resta sulla carta
Un sondaggio dello scorso anno condotto da Eurobarometro evidenzia come quasi la metà dei cittadini comunitari abbia sperimentato problemi psicologici ed emotivi, mentre i ricoverati nelle istituzioni psichiatriche e sociali sono ancora 1,5 milioni. L'impegno a livello di linee di indirizzo ci sarebbe ma, secondo Roberto Mezzina, vicepresidente della World federation for mental health for Europe, sarebbe carente l'applicazione pratica

L’Europa è considerata in tutto il mondo un baluardo dei diritti umani. Eppure, c’è un ambito in cui anche il vecchio continente fatica a prestare ai suoi cittadini l’attenzione necessaria. È quello della salute mentale, un elemento chiave del benessere della popolazione, se è vero che «Non c’è salute senza salute mentale». Ancora prima della pandemia, infatti, erano 84 milioni – una su sei – le persone che avevano qualche disturbo mentale. E la situazione, in seguito al Covid-19 e alle crisi globali, non ha fatto altro che peggiorare: un sondaggio dell’Eurobarometro condotto a giugno 2023 ha evidenziato che il 46% dei cittadini europei aveva sperimentato nell’ultimo anno problemi psicologici ed emozionali, come ansia e depressione. Un dato allarmante, che dovrebbe portare le istituzioni comunitarie a muoversi per porvi rimedio. Effettivamente sono stati prodotti dei documenti, come il rapporto sulla salute mentale in Europa uscito a metà del 2023, che ha portato a una risoluzione del Parlamento europeo a dicembre, che detta delle direzioni molto chiare e comprensive per affrontare le sfide legate a questo ambito. Ma le intenzioni si tradurranno effettivamente in buone pratiche? Roberto Mezzina, già direttore del Dipartimento di salute mentale di Trieste e ora vicepresidente della World federation for mental health for Europe, è scettico in proposito; ma ritiene che ci sia ancora spazio per una pratica critica.
Cosa ne pensa della situazione della salute mentale in Europa?
Penso che ci sia una terribile contraddizione tra la completezza e l’accuratezza delle politiche dichiarate – e della direzione in cui dovrebbero andare – e la povertà estrema, addirittura mortificante, di quello che si fa in Europa nell’ambito della salute mentale. Poi ci sono Paesi che hanno più soldi e che storicamente investono maggiormente sulla prevenzione e la promozione della salute, a partire dalle scuole e dai luoghi di lavoro, che sono quelli del Nord, non del Sud. Si tratta di Stati che, in proporzione, spendono quattro o cinque volte più dell’Italia sulla salute mentale e hanno delle buone politiche attive in questo campo.
Ma ci sono delle buone pratiche europee?
Si, c’è un elenco di best practice, c’è per esempio un programma che si chiama Health promoting schools, che riguarda le scuole, si fanno delle attività di formazione dei ragazzi nelle abilità comunicative e nelle famose life skill, le capacità di gestione della propria vita. Sono però piccole cose a fronte dell’enormità del tema della nocività di stili di vita, di comunicazione, di relazione specie nell’era post-covid e della digitalizzazione. Per la promozione della salute mentale nei luoghi di lavoro, poi, c’è poco. In Italia, da quello che so, non c’è quasi nulla, nonostante il fatto che il nostro Paese sia il primo che l’ha teorizzata. C’è stato Olivetti e il lavoro di Rozzi negli anni ‘70 sulla salute mentale in fabbrica (cfr. ‘Psicologi e operai’). Ma ciò che è più rilevante è che si dimentica molto facilmente il tema centrale, quello delle istituzioni e del loro superamento.
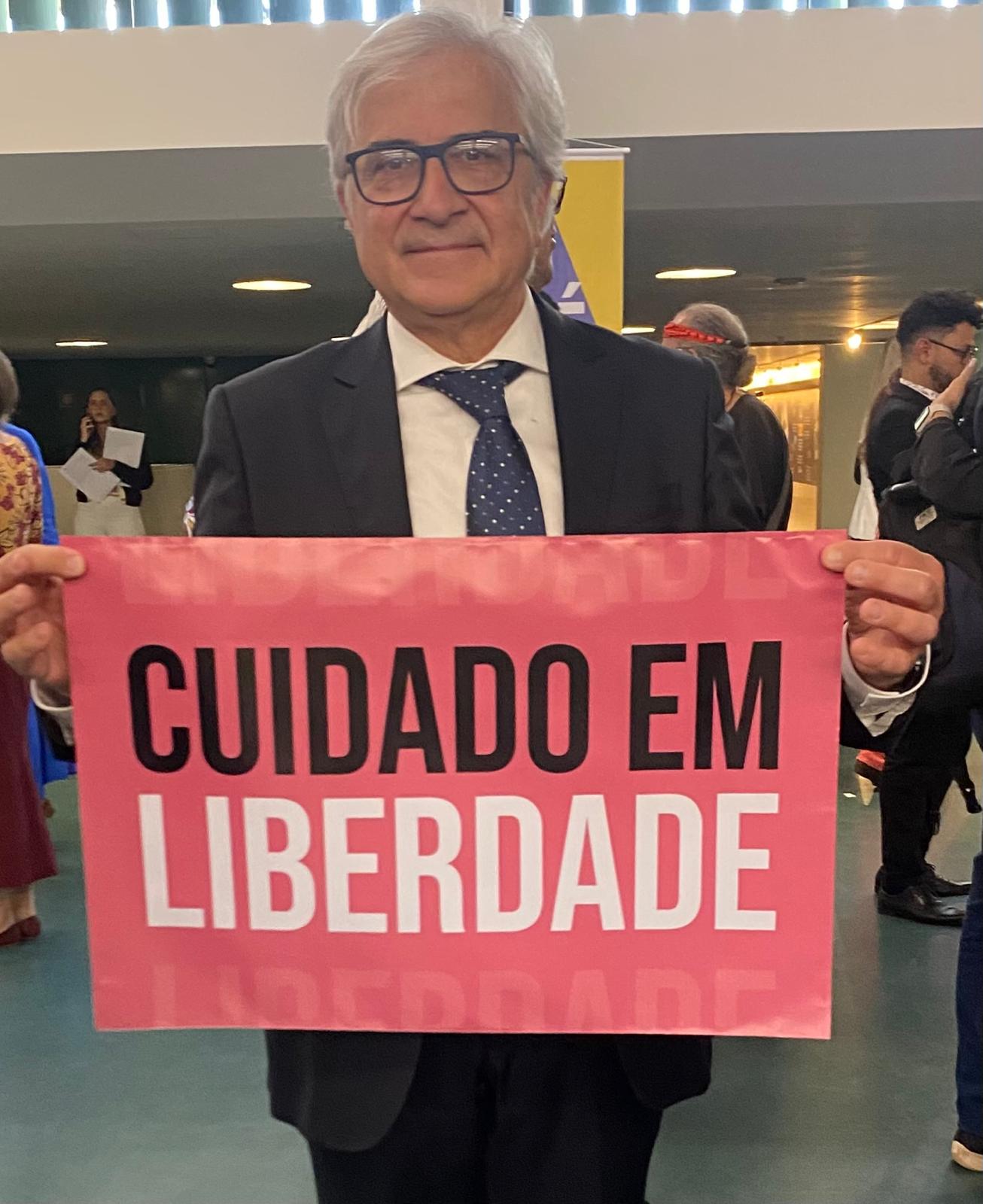
In che senso?
Le istituzioni sono luoghi orrendi, ma assorbono buona parte del budget sulla salute mentale dei vari Paesi, fino addirittura al 70/80%. Ai servizi e alla promozione d/ella salute rimangono gli spiccioli. In Europa ci sono ancora 1,5 milioni di internati che sono ricoverati in istituzioni psichiatriche o istituzioni sociali – come nell’Est Europa –, ma sempre con delle patologie psichiatriche. Si tratta di strutture gestite dai ministeri del Lavoro o del Welfare, non della salute, che invece tratta di più gli ospedali psichiatrici in senso stretto, in cui sta chi ha un problema acuto e situazioni patologiche più evidenti. L’Unione promuove, con dei finanziamenti strutturali, assegnati attraverso bandi, progetti di deistituzionalizzazione per i quali ha emanato linee guida molto chiare. Io stesso ho partecipato a due progetti di questo tipo su due istituzioni sociali della Slovenia, per la ricollocazione delle persone in gruppi appartamento e reti di servizi comunitari. Tuttavia, non esiste una vera politica europea che sia unitaria. La stessa riforma che ha attuato il Belgio e che ha ispirato una Joint Action dell’Ue che è in corso, punta più di altri paesi sulla salute mentale di comunità, ma confrontata con la grande riforma italiana è davvero un’inezia. Costruisce dei team comunitari di intervento, sostenuti da reti di coordinamento di servizi e politiche locali, ma i manicomi non sono toccati: si sviluppa una serie di servizi di comunità, ma senza neppure menzionare la riduzione degli ospedali psichiatrici. E questo è abbastanza singolare, visto che la maggior parte dei soldi, in Europa e nei paesi ricchi più che in altri luoghi, vengono spesi nelle istituzioni.
E come mai i manicomi non vengono toccati? Si tratta di mancanza di coraggio?
La psichiatria è da un lato molto tradizionalista, si occupa della malattia in un’ottica biomedica, ma dietro c’è un coacervo di interessi sulle grandi istituzioni; inoltre sopravvivono timori sulla coesione sociale, se le persone con disturbo mentale vengono dimesse sul territorio, ove giocano tutti i pregiudizi e lo stigma ad essi collegato. Infine, c’è l’incapacità di trovare modelli efficaci, mentre persiste una percezione ormai sbiadita del lavoro fatto in Italia, che nomina un po’ a casaccio Franco Basaglia e la Legge 180 senza comprenderne la portata. Hans Kluge, direttore dell’Organizzazione Mondiale della sanità per l’Europa, ha dichiarato che bisognerebbe fare della salute mentale una bandiera, soprattutto dopo la pandemia. Io stesso ho partecipato a una task force sulle politiche di salute mentale dopo il Covid-19, ma il prodotto è stato una sorta di coalizione e di alleanza tra l’Oms e varie organizzazioni che purtroppo poco sta raggiungendo in termini pratici. Anche perché organizzazioni come la stessa Oms, e la Commissione Europea, possono solo tracciare delle linee guida, poi sono i singoli Paesi che fanno le politiche. Non c’è accordo sulle politiche sanitarie in questo campo tra le Regioni italiane, figuriamoci cosa accade a livello europeo.
Sono impegni che, tendenzialmente, restano sulla carta, quindi?
Esattamente.
Che fine farà la risoluzione di dicembre dopo le elezioni europee?
Queste risoluzioni ci sono sempre state, sempre molto corrette, ma restano vaghe. Interessante notare che, in qualche modo, possono essere bipartisan. La Polonia, per esempio, che è un Paese che è stato gestito da governi di destra, ha fatto dei passi avanti, in cui siamo stati coinvolti anche noi a Trieste, e ha sperimentato centri di salute mentale in zone pilota. La Repubblica Ceca, con cui pure abbiamo collaborato, ha fatto forse l’unica riforma seria in Europa; pur non toccando direttamente i manicomi ha sviluppato un’infrastruttura di centri di salute mentale integrati socio-sanitari che sta continuando a crescere e che fa contrarre i ricoveri ospedalieri. Però si tratta, sempre, di iniziative dei singoli Stati. Le politiche europee da Helsinki (dove è stata fatta una Conferenza ministeriale europea sulla salute mentale nel 2005, ndr) ad adesso non sono cambiate di tanto. Certo, allora si era più coraggiosi, perché si diceva che gli ospedali psichiatrici dovessero essere the last resort, l’ultima spiaggia, e che in sostanza bisognava chiuderli.
In definitiva c’è sempre più accordo a livello delle politiche e delle raccomandazioni che dovrebbero guidarle, ma poco accade a livello di implementazione di politiche nazionali e transnazionali, comunitarie. Nonostante il fatto che, pur nell’estrema eterogeneità delle situazioni e dei livelli di spesa dei vari paesi in salute mentale, i modelli della psichiatria restano straordinariamente immutati, vincolati alla gestione della malattia, incapaci di offrire vere prospettive e opportunità per la ‘recovery/guarigione’, che aprano speranze di una vita possibile. Per questo occorre cercare alternative radicali alla vecchia psichiatria istituzionale. E qui torniamo a Basaglia, sempre.
Foto in apertura da Pixabay
Cosa fa VITA?
Da 30 anni VITA è la testata di riferimento dell’innovazione sociale, dell’attivismo civico e del Terzo settore. Siamo un’impresa sociale senza scopo di lucro: raccontiamo storie, promuoviamo campagne, interpelliamo le imprese, la politica e le istituzioni per promuovere i valori dell’interesse generale e del bene comune. Se riusciamo a farlo è grazie a chi decide di sostenerci.
