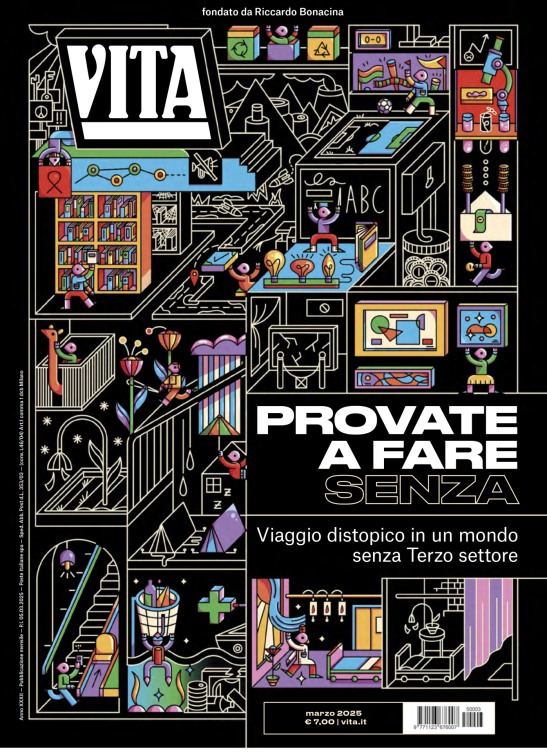Idee Cooperazione internazionale
Se la valutazione di impatto diventa un fine e non il mezzo
La valutazione ha un grande potenziale trasformativo che non è pienamente esperito. Non si tratta di fare un compito, ma di essere consapevoli di quel che si fa, di dove si sta andando e dove si vuole arrivare per essere parte attiva di una catena vitale che stringe mani che lavorano e, lavorando, trasformano il mondo

La valutazione impegna da oltre un decennio studiosi e operatori del Terzo settore e della Cooperazione internazionale allo sviluppo. Non che prima non esistessero analisi, ma non erano sistematiche e raramente erano volte a misurare l’impatto delle iniziative. Ed è proprio intorno a questo concetto che, negli ultimi anni, si è concentrata l’enfasi di diversi donatori e istituzioni con uno scivolamento delle pratiche e dei significati che, a volte, ha trasformato il mezzo (la valutazione) in un fine (a sé stesso). Se n’è discusso in un bel seminario organizzato dalla Facoltà di Scienze politiche e sociali con il Cds in Politiche per la cooperazione internazionale allo sviluppo, il dipartimento di Sociologia e il supporto del Centro di Ateneo per la Solidarietà Internazionale (CeSI) dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, dal titolo “Opportunità e sfide della valutazione nella cooperazione internazionale allo sviluppo” a cui hanno partecipato sia studiosi che operatori del settore.
In primis, Christian Elevati di Mapping Change ha chiarito che «per una buona valutazione il processo deve essere partecipato fin dall’inizio, già dalla fase di progettazione e programmazione di un intervento» e che, inoltre, è importante utilizzare la valutazione in modo congruo: «Attenzione all’eccesso di stress valutativo e a sottoporre continui questionari che soffocano le persone», ha specificato Elevati. Deve esserci, poi, un processo di apprendimento reciproco perché i risultati siano patrimonio di tutti e tutto deve essere visto nell’intero ciclo dell’impatto (Impact Cycle Management).
Per Valeria Saggiomo dell’Università di Napoli L’Orientale è particolarmente importante «valutare non il progetto in sé, ma il processo di cambiamento che esso può attivare. La valutazione, poi, deve essere sostenibile (i benefici devono perdurare nel tempo), deve essere utilizzata e utilizzabile, deve dare valore ed essere etica (deve tener conto dei rapporti di potere presenti all’interno dei progetti), ma soprattutto deve contemplare l’empatia, ovvero una dimensione “sentimentale” che si concentra sulla spinta motivazionale in base a cui agiscono gli attori. In virtù della motivazione gli attori si comportano in modo diverso e possono potenzialmente contribuire al cambiamento sociale».
Secondo Mario Mancini di Progettomondo, invece, il compito più importante per chi lavora nel settore «è riconoscere la rilevanza della valutazione come percorso di empowerment di tutti gli stakeholder che partecipano al progetto di cambiamento».
Tuttavia, non mancano le sfide, secondo Laura Cicinelli dell’istituto per la cooperazione universitaria – Icu, «raramente (nella mia esperienza) ho visto delle valutazioni utili e rilevanti; le valutazioni si scontrano con la resistenza al cambiamento (anche delle ong), la scarsità di risorse per rendere utile la programmazione e la gestione, inoltre, i donatori spesso sono poco flessibili (non si può mettere in discussione il santo donatore) e il donatore non accetta di cambiare o di ammettere che sta sbagliando. A volte, poi, non c’è una competenza da parte di chi richiede la valutazione. Infine, c’è l’ostacolo della gestione della conoscenza (knowledge management) che resta un patrimonio individuale, non diventa ricchezza condivisa (la trasmissione culturale è spesso assente)». Diversi strumenti della valutazione sarebbero molto citati (es. il ciclo di progetto o il quadro logico), ma poco utilizzati.
Spesso, specifica Elevati, «con i donatori ci si scontra sull’esigenza di fare il compitino (le regole vengono prima del senso per cui sono fatte) e a volte gli indicatori sono così rigidi che svuotano la natura del progetto. Poi dal lato ong ci sono organizzazioni che praticano la mission drift, non hanno un orientamento, ma “sbandano” in base a come si muovono i bandi; tuttavia se c’è una vera leadership interna capace di definire gli obiettivi di cambiamento nel medio lungo termine la ong resta capace di seguire i propri obiettivi (e non quelli dei donatori)».
Un’altra sfida secondo Dania Tondini di Fondazione Avsi «sono i donatori che impongono metodologie (es. il controfattuale) e poi c’è l’enfasi sulla percezione (sul gradimento) dei target, ma è più importante aiutare le persone a riflettere sull’esperienza rispetto a somministrare un questionario (le cui risposte sono in genere accondiscendenti perché ha ricevuto qualcosa)».
In sintesi, la valutazione ha un grande potenziale trasformativo che non è pienamente esperito. Non si tratta di fare un compito, ma di essere consapevoli di quel che si fa, di dove si sta andando e dove si vuole arrivare per essere parte attiva di una catena vitale che stringe mani che lavorano e, lavorando, trasformano il mondo.
Credi foto Unsplash
17 centesimi al giorno sono troppi?
Poco più di un euro a settimana, un caffè al bar o forse meno. 60 euro l’anno per tutti i contenuti di VITA, gli articoli online senza pubblicità, i magazine, le newsletter, i podcast, le infografiche e i libri digitali. Ma soprattutto per aiutarci a raccontare il sociale con sempre maggiore forza e incisività.