Idee Welfare
Pubblico e Terzo settore: per un’alleanza senza retorica
Quella tra pubblico e privato oggi è un’alleanza necessaria. Verissimo, a patto però di chiarire di quale Pubblica amministrazione e di quale Terzo settore stiamo parlando. Necessaria è l'alleanza della parte migliore del pubblico con la parte migliore del Terzo settore: il resto è solo "rete"
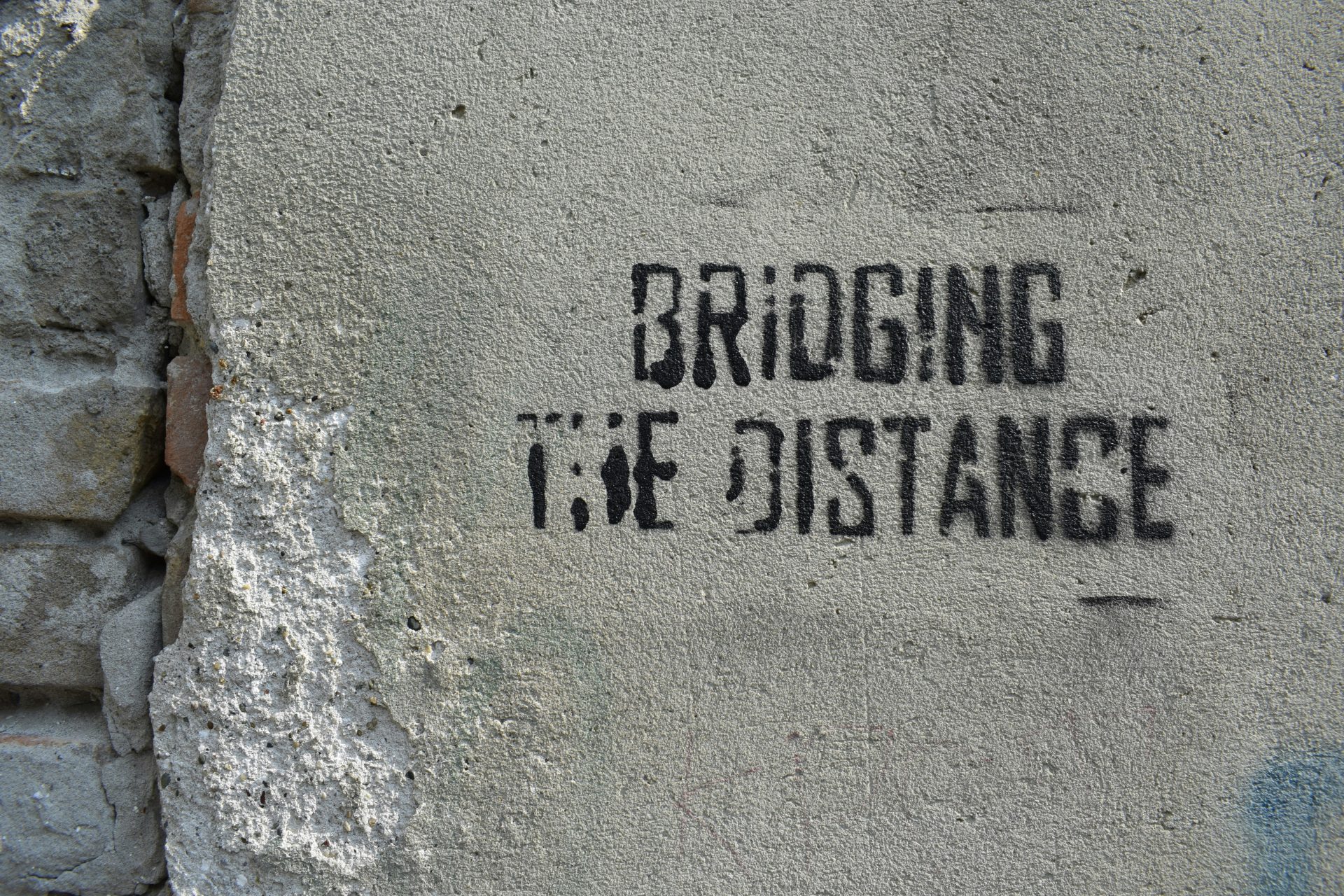
“Pubblico, privato: un’alleanza necessaria”: questo il titolo di un panel di lavoro in cui sono intervenuto all’interno della tre giorni appena conclusasi a Roma, per iniziativa dell’impresa sociale “Con i bambini”, sui temi dell’adolescenza e delle politiche educative. Ritengo il tema del fare insieme – e delle forme e dei metodi del fare insieme – uno degli ambiti centrali del lavoro educativo e sociale e per questo ci torno qui.
Dalla rete all’alleanza
In primis penso che l’uso della parola “alleanza” ci faccia fare un salto in avanti rispetto all’uso della parola “rete” perché quest’ultima ci schiaccia un ambito più freddo, più tecnico: un ambito professionale, certo, ma dove si sta insieme non perché si condividano un’analisi o una finalità comune, ma meramente per obbligo o per interesse, magari solo per partecipare a un bando che ci costringe a non essere soli. Insomma mi pare che la “rete”, anche quando ricca di competenze e professionalità, sia un luogo dove si investa poco sulla dimensione culturale e emotiva e perciò dove il condividere un senso e una prospettiva non sia considerato un elemento costitutivo. Si potrebbe dire che nella rete si “sta insieme senza volersi bene”: più adatta a chi è “abituato e non innamorato” del proprio lavoro.
La parola alleanza ci fa fare un salto in avanti rispetto alla rete. Nella rete si “sta insieme senza volersi bene”: è più adatta a chi è “abituato e non innamorato” del proprio lavoro
In seconda istanza credo che affermare come titolo e premessa che l’alleanza è necessaria sia un elemento importante, che ci aiuta a recuperare l’inspiegabile ritardo che abbiamo accumulato nel percepire che di fronte alla sempre più densa complessità con cui abbiamo a che fare, nel campo educativo come nelle politiche sociali o di contrasto delle povertà, nessuno di noi da solo è sufficiente.
Basti guardare al tema della povertà educativa, dove tutte le ricerche e le evidenze di settore ci dicono che tale fenomeno è determinato dal peso di un insieme di fattori economici, sociali e culturali e dall’incidere sulle storie personali e familiari di disuguaglianze di genere, di territorio e di classe, finendo per caratterizzare la scuola come luogo dove le carriere scolastiche vengono predeterminate in entrata e non in uscita. Le stesse evidenze ci dicono, con buona pace della retorica del merito del ministro Valditara, che in questo Paese se sei donna, meridionale e povera non hai le stesse opportunità di un tuo coetaneo maschio, benestante, del Centro Nord.
Dove servono le alleanze
In questi anni è stato evidente come le uniche esperienze che hanno in qualche modo risposto a tale complessità sono stati i patti educativi di comunità, che altro non sono che un’alleanza tra attori differenti (scuole, enti locali, attori del civismo attivo, cooperazione, privato profit e non profit) che hanno condiviso non solo azioni ma la messa in moto di processi tesi a fare della comunità una comunità educante, dove la cura dei processi di studio e formazione e più in generale di crescita sana e responsabile di bambine e bambini e bambine, di ragazzi e ragazze fosse assunta come responsabilità pubblica e collettiva di tutta la comunità.
Schematizzando, senza alleanze si rischia:
- di non rispondere in modo adeguato alla complessità;
- di non attivare sistemi di intervento capaci di essere prossimi e vicini e per questo capaci di raggiungere anche chi da solo non arriva (perché non vuole e o non può). Di non arrivare anche negli anfratti più duri delle nostre marginalità che se non raggiunti e rammendati diventano serbatoi di rancore, violenza e, come la chiama Marco Rossi-Doria, di “disperanza”. Luoghi cioè dove non si spera neanche più di poter avere un futuro migliore o di veder realizzati i propri desideri;
- di non riuscire mai a superare la precarietà che troppo spesso caratterizza il nostro fare. Anche quando facciamo cose straordinarie esse sono fragili proprio perché non sono mai assunte come politiche di sistema;
- di non riuscire nei luoghi a fare argine e re-indirizzare politiche e finanziamenti nazionali calati dall’alto, senza alcun dialogo sociale o attenzione alle specificità territoriali e che oltre a essere sempre più ridotte propongono sempre più spesso modelli contenitivi e istituzionalizzanti, dove le persone diventano oggetti e non attori di lavoro, in un impianto paternalistico, identitario e corporativo del welfare e delle sue politiche;
- di non riuscire a fare del lavoro educativo e sociale un luogo fatto di processi e interventi mirati al cambiamento delle persone e dei luoghi, di costruzione di legami (in un tempo dove tutto si lacera), di innovazione (ora che tutto sembra arretrare), di apertura (dentro a un contesto orientato alla chiusura).
Le alleanze non necessarie
Le alleanze non sono tutte necessarie. Sono necessarie quelle consapevoli di essere incastonate in una dimensione politica e culturale, tesa allo sviluppo giusto, con le persone al centro, capaci di attivare una funzione pubblica agita da più attori, formali e informali. Come è del tutto evidente, la costruzione di alleanze di questo tipo comporta una profonda rivisitazione dei due attori principali: il pubblico e il civismo attivo.
Le alleanze non sono tutte necessarie. Sono necessarie quelle consapevoli di essere incastonate in una dimensione politica e culturale, tesa allo sviluppo giusto, con le persone al centro, capaci di attivare una funzione pubblica agita da più attori, formali e informali
Consapevole che il mio è uno sguardo parziale, vorrei provare a dire in modo schematico quale “pubblico” e quale “Terzo settore” servono per costruire alleanze come quelle che ho provato fin qui a descrivere, ponendo sul secondo soggetto un’attenzione particolare alla cooperazione sociale.
Quale pubblico
Per quello che riguarda il pubblico i primi due punti sono generali. Ci vuole un pubblico che torni a considerare come una delle sue principali responsabilità quella di garantire l’esigibilità dei diritti, piuttosto che dismettere tale prospettiva accettando un ruolo marginale o meramente assistenzialistico (gestore di stanze dove contenere gli “scarti”) o piegandosi alle esigenze del mercato.
E per questo, un pubblico che consideri le politiche di welfare, quelle educative e le azioni di contrasto alla povertà e alle disuguaglianze come presupposto e non come esito dello sviluppo.
Servirebbe un pubblico capace di uscire dai due poli opposti in cui sembra essersi, almeno nella maggioranza delle situazioni, rannicchiato: da una parte la delega quasi completa della sua responsabilità (occupati tu della questione), dall’altra un atteggiamento “autoritario”, io decido e tu esegui, con interventi pre-confezionati e calati dall’alto, che interpretano e usano il Terzo settore non come soggetto ma come oggetto, relegandolo a un ruolo ancillare, di mero gestore di politiche altrui o peggio, come serbatoio di manodopera a basso costo.
Serve un pubblico così competente, coraggioso e lungimirante da rivendicare a sé un ruolo di governo e coordinamento dei servizi ma allo stesso tempo – anzi proprio per questo – disponibile a condividere pezzi di potere sugli indirizzi e sulle risorse
Quello che serve è un pubblico così competente, coraggioso e lungimirante da rivendicare a sé un ruolo di governo e coordinamento dei servizi ma allo stesso tempo – e anzi proprio per questo – forte nel proporre l’integrazione come ambito di reciproco e paritario riconoscimento, dove la funzione pubblica è garantita da soggetti differenti che si riconoscono in tale funzione e dove il pubblico, pur nella chiarezza di ruoli e funzioni non si limita all’ascolto ma si rende disponibile a condividere pezzi di potere sugli indirizzi e sulle risorse.
Quale Terzo settore
Ma per chiedere al pubblico di far questo sforzo serve un civismo attivo e in esso una cooperazione sociale disposta a guardarsi a mettersi in discussione. A verificare se e come il proprio fare mantiene un legame e una coerenza con l’impianto culturale in cui essa è nata e si è sviluppata. Mi pare che in tal senso si possano individuare quattro possibili “indicatori” su cui provare a rileggere il nostro lavoro.
Il primo è capire se riusciamo a tenere le nostre imprese in equilibrio tra mercato e solidarietà. Tra mission ed esigenza di impresa. Non è cosa facile, soprattutto in un contesto di riduzione delle risorse pubbliche che schiacciano le cooperative in una logica di competizione al ribasso: ma è un fattore fondamentale, che per altro rappresenta la nostra prima originalità e che poi è essenziale anche per stare sul mercato. Scimmiottare il profit è perdente e ci porta inevitabilmente a colludere con politiche contenitive o con le spinte di privatizzazione del welfare pubblico.
In secondo luogo dobbiamo verificare se il nostro lavoro è in grado di curare insieme le persone e le comunità in cui quelle persone vivono. Non possiamo pensare di garantire diritti e emancipazione delle persone più fragili o che fanno più fatica se lavoriamo in comunità ostili e diffidenti, che tutto sommato ci considerano come nemici perché ci percepiscono come troppo amiche di quelli che loro considerano nemici. Come direbbe Aldo Bonomi, non possiamo regalare la “comunità operosa” al rancore ma dobbiamo lavorare per riportarla verso la comunità della cura.
Le alleanze necessarie oggi sono quelle tra i pezzi migliori di pubblico e i pezzi migliori del Terzo settore
In terzo luogo dobbiamo stare attenti a mantenere una coerenza tra i modelli di democrazia che proponiamo alle nostre comunità e quelli che pratichiamo all’interno delle nostre organizzazioni. Dobbiamo investire di più per fare delle nostre organizzazioni dei luoghi democratici, a forte circolarità delle informazioni, garantendo il massimo coinvolgimento nei luoghi decisionali (ad esempio cooperative in cui i soci sono dieci e i lavoratori sono cento non sono cooperative). A partire da una forte attenzione alle questioni di genere e generazionali. Sapendo che il capitale più prezioso delle nostre imprese sono i soci e le socie, le lavoratrici e i lavoratori.
Quarto punto, dobbiamo verificare che con il nostro lavoro si riesca a restituire e non a trattenere la voce, il protagonismo e il potere delle persone con cui lavoriamo.
Da impresa a intrapresa
Quattro indicatori pesanti, non facili da raggiungere. Ma che oggi più che mai ci servono per ritrovare senso e prospettiva. Per passare da essere impresa a essere intrapresa. Per chiedere al pubblico e alla politica di riconoscerci come attori della funzione pubblica e non come oggetti di lavoro. In conclusione, le alleanze necessarie oggi sono quelle tra i pezzi migliori di pubblico e i pezzi migliori del Terzo settore. Tra chi, nel pubblico come nel privato mantiene una coerenza e si sente parte dell’articolato costituzionale, a partire dalla funzione che la Costituzione nell’art. 3 assegna come compito della Repubblica e cioè di “rimuovere gli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della persona umana”. Queste alleanze ci servono per tornare a convincere, perché – come diceva Franco Basaglia – convincere significa mettere in moto un processo che difficilmente poi potrà essere arrestato.
Foto di Marija Zaric su Unsplash
17 centesimi al giorno sono troppi?
Poco più di un euro a settimana, un caffè al bar o forse meno. 60 euro l’anno per tutti i contenuti di VITA, gli articoli online senza pubblicità, i magazine, le newsletter, i podcast, le infografiche e i libri digitali. Ma soprattutto per aiutarci a raccontare il sociale con sempre maggiore forza e incisività.


