Idee Libri
Leggere per diventare
Due saggi scardinano i nostri stereotipi su adolescenza e lettura. Meglio capire i "divenenti", come un'inchiesta-documentario ha più efficacemente ribattezzato i giovani, abbandonando le etichette pigre
di Chiara Faggiolani e Catterina Seia

Due libri usciti da poco – Ma quale Gen Z? di Francesco Morace e Linda Gobbi (Egea) e Adolescenti interrotti di Stefano Vicari (Feltrinelli) – ci offrono un’occasione preziosa: smontare alcune delle semplificazioni che troppo spesso adottiamo quando parliamo di nuove generazioni. In generale e in particolare rispetto alla lettura.
Per farlo, dobbiamo abbandonare le lenti interpretative usuali, a partire da quella che divide il mondo in “generazioni” nette e omogenee. Viviamo in un tempo fluido, in cui i bambini (la cosiddetta Generazione Alpha) adottano modelli di consumo tipici dell’adolescenza; gli adolescenti della Gen Z rivendicano gradi di libertà che una volta spettavano ai giovani; i giovani della Generazione Y dipendono sempre più a lungo dalle famiglie; i baby boomers, ormai anziani solo all’anagrafe, vivono una vecchiaia che potremmo definire “progettuale”, ben lontana dall’essere una fase di declino.
La concezione adultocentrica della vita
Tra bambini e adolescenti di oggi c’è molto più di una lieve differenza d’età: ci sono trasformazioni profonde nei modi di essere, di abitare il mondo, di immaginare il futuro o di non immaginarlo. L’approccio tradizionale per segmentazione socio-demografica è ormai del tutto insufficiente, soprattutto se è attraverso questo approccio che intendiamo comprendere la partecipazione culturale e i comportamenti di lettura. La concezione adultocentrica della vita, che domina nel nostro retropensiero – e che possiamo descrivere come un’immaginaria curva a campana in cui la piena realizzazione coincide con l’età adulta, preceduta da un’adolescenza come “preparazione” e seguita da una vecchiaia come “declino” – ci impedisce di guardare al processo di umanizzazione intesa come crescita personale e collettiva come dovrebbe essere: un processo continuo, non lineare, che attraversa tutta l’esistenza.
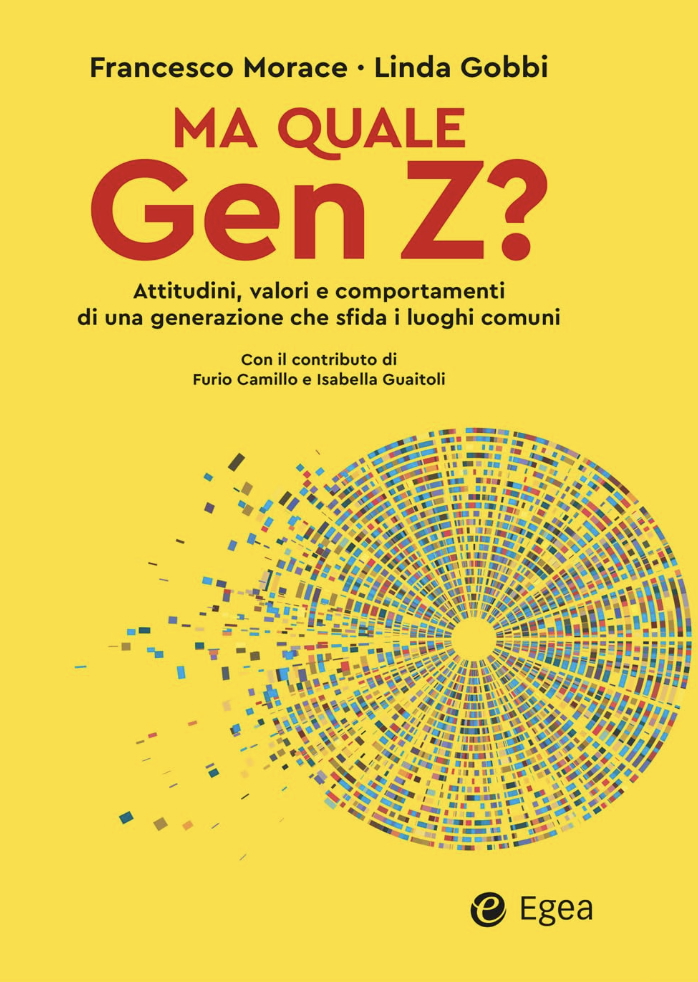
Giovani impegnati con l’arduo compito di diventare
Ecco perché amiamo l’espressione “divenenti”, usata nell’inchiesta-documentario Futura di Pietro Marcello, Francesco Munzi e Alice Rohrwacher. “Divenenti” esprime meglio di “giovani” l’idea di movimento, transizione, trasformazione. I divenenti non sono semplicemente “giovani”: sono impegnati nell’arduo compito del diventare, del costruirsi nel mondo. È in questo scenario che le pratiche di lettura vanno collocate.
Questa consapevolezza circa la trasformatività generazionale ci impone di ripensare radicalmente il modo in cui ci avviciniamo ai “divenenti” ed è a mio avviso ciò che anima il libro Ma quale Gen Z? Qui gli autori decostruiscono la visione monolitica di una generazione Z compresa, secondo la vulgata, tra i nati dal 1996 al 2012. Una forchetta talmente ampia effettivamente da risultare assurda.
Già nel 2016 nel libro Consumautori. I nuovi nuclei generazionali, Morace aveva indicato 16 nuclei generazioni attraverso i quali guardare ai comportamenti dei più giovani in modo diverso. Ora in questo nuovo libro Morace e Gobbi si concentrano proprio sui “divenenti” e sulla base di una ricerca originale condotta tra giugno e ottobre 2024 su 4mila ragazzi e ragazze, suddividono la cosiddetta Gen Z in quattro “nuclei”: gli ExpoTeens (13-15 anni), gli ExperTeens (16-19 anni), i CreActives (20-24 anni) e i ProActives (25-29 anni).
Non è solo una classificazione anagrafica: emergono differenze profonde nei valori, nei comportamenti, nelle aspettative. Dall’ansia crescente degli adolescenti più giovani, fino al pragmatismo digitale dei ventenni alle prese con il mercato del lavoro.
Abbandonare le etichette “pigre”
Un quadro che interroga tutti noi che spesso ci sentiamo spaesati di fronte a una generazione così complessa, ma anche nel caso specifico che ci riguarda, il sistema della cultura e quello della lettura in particolare chiamato ad abbandonare le etichette “pigre” usate fino ad ora per costruire proposte capaci di parlare in modo diverso a pubblici molto diversi.
È sulla base di questa nuova griglia interpretativa che risulta particolarmente importante a nostro avviso la lettura di Adolescenti interrotti di Stefano Vicari, professore di Neuropsichiatria Infantile all’Università Cattolica del Sacro Cuore e direttore dell’Unità Operativa Complessa di Neuropsichiatria Infantile dell’Irccs Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma.
Un grido d’allarme in un libro
Questo è un libro che suona come un grido d’allarme e che racconta come negli ultimi anni sia cresciuta la sofferenza psicologica in particolare dei ragazzi e delle ragazze ExpoTeens (13-15 anni) ed ExperTeens (16-19 anni). Ansia, depressione, disturbi del comportamento alimentare non sono più fenomeni marginali sono quasi tratti distintivi di questi nuclei generazionali.
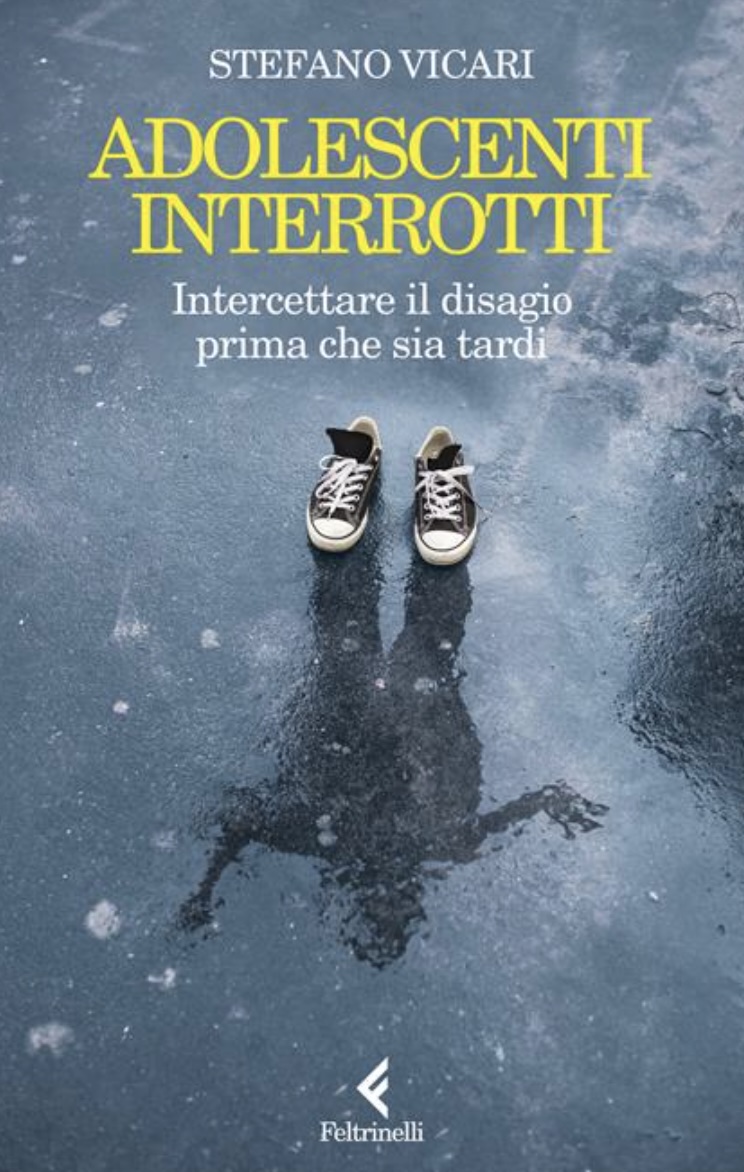
L’adolescenza contemporanea è spesso un territorio accidentato, attraversato da paure e insicurezze, ma anche da nuove forme di resilienza, l’importante è saperle riconoscere e sostenerle senza pretendere di addomesticarle.
A questo proposito Vicari nel libro dice una cosa importantissima
Non credo di esagerare nel dire che nessuna generazione ha conosciuto tante insidie e, allo stesso tempo, così poche opportunità come quella degli attuali adolescenti. Anche in passato, certamente, i ragazzi hanno faticato a trovare il giusto spazio per affermare la loro identità nel mondo poco accogliente degli adulti. Ma la mancanza di prospettiva è quella che più di ogni altra cosa taglia le gambe. Durante l’adolescenza non si soffre tanto per ciò che è accaduto nel passato quanto, piuttosto, per ciò che si percepisce non potrà accadere nel futuro. La difficoltà, se non l’impossibilità, di coniugare l’imperativo al quale li stiamo educando (avere denaro e successo, essere popolari a tutti i costi) con le misere opportunità disponibili crea facilmente la frustrazione e la rabbia di non vedere vie di uscita. Negli anni sessanta e settanta, questa rabbia trovava sfogo nella ribellione, che esplodeva nelle piazze, e nel conflitto agito contro il mondo degli adulti. Oggi gli adolescenti si chiudono nella loro stanza e rivolgono questa violenza contro se stessi, contro il proprio corpo.
È in questo contesto che va ripensato il ruolo della lettura, andando oltre le statistiche che si limitano a misurare quanti giovani leggono o quanti smettono di leggere e quanto leggono non leggono, per cominciare a interrogarsi molto più intensamente sul cosa si legge e su come questo possa incidere nella loro vita.
Rispetto all’assenza di futuro, la lettura, infatti, può essere una risorsa decisiva nella costruzione degli immaginari: un laboratorio interiore per esplorare possibilità, per trovare parole nuove che descrivono e aiutano a comprendere emozioni perfino sconosciute, per intravedere sentieri dove la realtà sembra opaca. Pascal Chabot, in un altro bellissimo libro sul tempo che stiamo vivendo (Avere tempo. Saggio di cronosofia, Roma, Treccani, 2023), l’ha chiamata Afuturalgia.
Come aiutare i “divenenti” con la lettura
Diventa allora cruciale chiedersi: quali storie possono funzionare come ponti, capaci di aiutare i “divenenti” ad attraversare momenti di difficoltà importanti? Quali sono gli immaginari che possono riaccendere il desiderio, ridare forma alla speranza, riconciliare con l’idea stessa di un avvenire possibile, anche se diverso da quello che ci era stato promesso?

È fondamentale farlo a partire dalla consapevolezza, lucidamente denunciata da Vicari, che la salute mentale delle ragazze e dei ragazzi rappresenta oggi una vera e propria emergenza.
La lettura, allora, non è semplicemente un’abitudine da incentivare o un dato da misurare e in questo senso, il compito di chi si occupa di educare e promuovere la lettura – che sia a scuola, in biblioteca, in libreria, nei media – si amplia inevitabilmente fino a intrecciare le dinamiche della “cura”: creare spazi sicuri in cui i divenenti possano incontrare storie che li aiutino a dare forma al loro sentire, a immaginare alternative, a riconoscersi e a trasformarsi. Promuovere ed educare alla lettura è allora un atto profondamente politico e umano, un’offerta di senso in un tempo che spesso sembra svuotato di prospettive.
Chiara Faggiolani è presidente del Forum del Libro
Catterina Seia è presidente Ccw-Centro culturale assistenziale
La foto di apertura è di Claudio Furlan/LaPresse.
17 centesimi al giorno sono troppi?
Poco più di un euro a settimana, un caffè al bar o forse meno. 60 euro l’anno per tutti i contenuti di VITA, gli articoli online senza pubblicità, i magazine, le newsletter, i podcast, le infografiche e i libri digitali. Ma soprattutto per aiutarci a raccontare il sociale con sempre maggiore forza e incisività.


