Idee Territori
Il Piano per l’economia sociale di Bologna? Un piano “direzionale” che cambia il modello di sviluppo locale
L'intervento dell'amministratrice delegata di Social Seed che ha lavorato al Piano: «Se avessimo identificato l’economia sociale con una parte del sistema di produzione e di consumo attuale non avremmo potuto ambire a ripensare i sistemi socio-economici che non reggono più alla prova dei fatti»

Il lavoro fatto sul piano dell’economia sociale della Città metropolitana di Bologna e coordinato da Daniela Freddi, delegata del Sindaco Metropolitano Matteo Lepore, parte dalla convinzione che l’economia sociale possa intercettare i cambiamenti nelle strutture economiche e nelle politiche che fermentano nelle diverse sedi urbane, regionali o nazionali, e diventare una direttrice per essere qualcosa di più di un indirizzo di settore. In sostanza, ci siamo chiesti come passare da un’economia sociale come ambito guidato da alcuni attori ad un’economia sociale come prospettiva per rivedere i sistemi socio-economici di sviluppo.
Se avessimo identificato l’economia sociale con una parte del sistema di produzione e di consumo attuale non avremmo potuto ambire a ripensare i sistemi socio-economici che non reggono più alla prova dei fatti, e avremmo relegato l’attività degli attori dell’ES ad essere un fixing delle esternalità negative dei sistemi economici basati sulla logica del profitto. Occorre in altri termini allontanarsi da una possibile logica additiva (un’economia che si aggiunge alle altre, in settori a fallimento di mercato) e riparatoria (un dispositivo per rammendare le ferite del capitalismo estrattivo e le perverse inefficienze dello Stato sociale del secolo scorso).
In un contesto invece di forti tensioni geopolitiche che generano forti sconvolgimenti nei mercati globali e nelle nostre società, è più che mai necessario ripensare i nostri modelli di competitività e di benessere, che sono strettamente correlati per cui serve trasformare e non solo aggiustare e per farlo dobbiamo lavorare su direzioni ampie, su nuove compagnini di partenariati, e spingere la pubblica amministrazione ad andare oltre una programmazione per silos e settori e gli attori della cooperazione ad uscire dalla logica delle azioni per compartimenti stagni.
Questo è un compito oggi istituzionale, ed è questo stesso compito istituzionale che può ridare anche senso ai processi democratici. La città metropolitana di Bologna si è fatta per questo promotrice di una piano molto ambizioso che interroga rispetto al modello di sviluppo economico e che sostiene che competitività e benessere vanno tenute insieme se si vuole lavorare su un’economia sociale che sia anche sviluppo locale nel raccordo tra città e area metropolitana.
Perchè un piano per missioni
Per lavorare su modifica delle condizioni sul lungo termine, per spostare le finalità del sistema e non solo correggere gli effetti abbiamo impostato il piano per missioni di cambiamento. Le missioni implicano il coordinamento di intenti risorse e azioni, sono quello strumento che ci permette di raccordare i progetti già esistenti tra città e area metropolitana e di raccordare anche le risorse pubbliche e private per creare effetti sistemici di cambiamento.
Le missioni sono direzionali perché non lavorano per obiettivi da raggiungere ma per tenere insieme strategie di più attori che devono trovare soluzioni complesse e coordinate a problemi complessi.
La missione “abitare”
Se pensiamo al tema della casa indirizzare gli interventi all’economia sociale vuol dire essere capace di offrire alternative concrete alle logiche estrattive innescate dal libero mercato e creare le condizioni di sviluppo di programmi complessi e multilivello, che intervengano sul fronte della programmazione, della gestione e della realizzazione di interventi abitativi in stretta collaborazione con operatori diretti, quali costruttori, sviluppatori, cooperative di abitanti, cooperative sociali capaci di sperimentare nuove forme di abitare collaborativo.
La missione parte dall’esperienza del Piano Strategico Metropolitano della Città metropolitana di Bologna e del più recente Piano per l’abitare del Comune di Bologna e ha lo scopo di mappare i bisogni dell’area metropolitana, capire risorse e asset, mettere in rete le esperienze, le programmazioni e gli interventi che si stanno conducendo su questo ambito nel territorio metropolitano. L’azione principale è di dare vita ad una piattaforma d’area vasta con più attori capaci di riconnettere politiche territoriali, forme di investimento e sostegno ai soggetti economici che partecipano all’abitare (cooperazione abitanti, cooperazione sociale, cooperazione di comunità, etc.), avvalendosi anche del contributo dell’Osservatorio metropolitano sul sistema abitativo (Omsa) e in sinergia con l’Osservatorio regionale del sistema abitativo (Orsa) della Regione EmiliaRomagna.
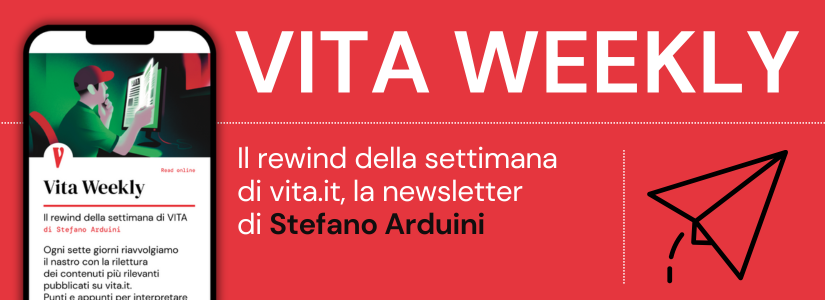
La sfida dell’abitare prende inoltre le mosse dalla consapevolezza di come essa non possa essere ridotta al tema della casa, ma implichi un ripensamento più ampio rispetto all’abitabilità di interi territori con riferimento a: servizi, trasporti, sostenibilità ambientale, etc. Oggi è evidente come intorno all’abitare si giochi una delle sfide più grandi inerenti il contrasto alle disuguaglianze. La sfida ambiziosa per il territorio sarà coniugare l’accesso e il diritto all’abitare delle categorie più fragili e vulnerabili tramite modelli di abitare collaborativo e sociale (come ad esempio senior housing, e housing first) con l’attrattività per i lavoratori della conoscenza e dell’innovazione tencologica.
È vero che il piano è molto ambizioso ma è anche vero che una volta decise alcune priorità nel breve termine e cercando di raccordare fondi già esistenti potrà essere un laboratorio di apprendimento per un nuovo modo di costruire politiche pubbliche multi attoriali che indirizzano l’economia e la società ad essere più coesa ed equa per tutte e tutti.
17 centesimi al giorno sono troppi?
Poco più di un euro a settimana, un caffè al bar o forse meno. 60 euro l’anno per tutti i contenuti di VITA, gli articoli online senza pubblicità, i magazine, le newsletter, i podcast, le infografiche e i libri digitali. Ma soprattutto per aiutarci a raccontare il sociale con sempre maggiore forza e incisività.


