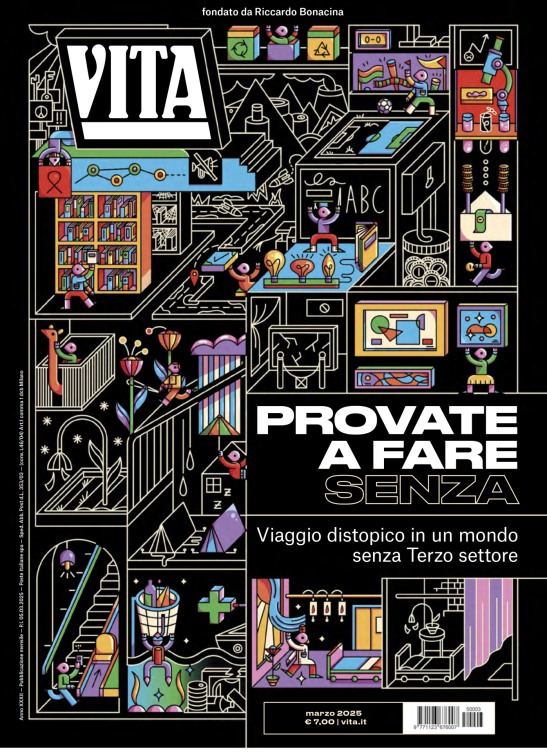Adolescenti
I ragazzi possono guarire dal disagio psichico, ecco come
Nel suo nuovo libro, il neuropsichiatra Stefano Vicari fa un'analisi dei fattori che possono influenzare la salute mentale dei più giovani. «Conoscerli ci aiuta a modificarli, per aiutare i bambini e i teenager a stare meglio. Perché anche i ragazzi interrotti possono ripartire»

Circa il 10% dei bambini tra i cinque e i nove anni in Unione Europea presenta disturbi mentali, secondo i dati diffusi da Unicef. Con l’aumentare dell’età, questa percentuale sale. Dopo i 10 anni si arriva al 19%, quasi uno su cinque. Sono numeri impressionanti, che ci obbligano a riflettere su cosa possiamo fare per aumentare il benessere delle nuove generazioni. Stefano Vicari, primario di neuropsichiatria al Bambin Gesù di Roma, nel suo nuovo libro Adolescenti interrotti. Intercettare il disagio prima che sia tardi (Feltrinelli) aiuta a riconoscere i disturbi mentali e i fattori che a essi possono predisporre, per intervenire tempestivamente e permettere ai ragazzi di riprendere il proprio cammino in serenità.
Professore, nel suo libro riporta un aumento importante dei disturbi mentali tra gli adolescenti…
La premessa che mi sento di fare è che questo libro non vuole raccontare il disagio degli adolescenti, ma vorrebbe favorire la formazione di una salute mentale negli adolescenti: si parte dalla constatazione che le richieste d’aiuto in pronto soccorso sono aumentate in maniera vertiginosa dal 2010 a oggi. Se c’è una base genetica e biologica, quella c’è sempre stata: se vediamo un aumento dei casi di psichiatria vuol dire che si stanno modificando i fattori ambientali. E noi dobbiamo conoscerli questi fattori, per evitarli e aiutare bambini e ragazzi a stare meglio. Anche nel titolo del libro ho voluto dare un messaggio di speranza: se gli adolescenti sono interrotti, vuol dire che si possono riprendere. Dai disturbi si guarisce e si riprende il proprio cammino.
La sua disamina dei fattori di rischio inizia prestissimo, dalla gravidanza della madre.
Un adolescente è il risultato del bambino che è stato; per determinare i disturbi psichiatrici è importantissima la genetica. Come dicevo, però, ci sono fattori ambientali – anche prenatali – che modulano il rischio genetico, che non è deterministico. Facendo un paragone con la salute fisica, è ovvio che una persona che ha la madre o il padre che ha avuto un infarto ha più probabilità di avere problemi cardiovascolari; ma questi aumentano se fa una vita sedentaria, fuma e ha un lavoro stressante. Così accade per la salute mentale. Oggi, per esempio, ci sono molte più donne che fumano in gravidanza o che addirittura assumono sostanze, nel 5% delle gestazioni, secondo il centro antiveleni di Pavia. Questo può accrescere la probabilità che un figlio sviluppi disturbi mentali. Bisognerebbe informare e tutelare le future madri. Nascere pretermine o di basso peso è un ulteriore fattore di rischio.
Quali sono gli altri?
La povertà. Essere poco stimolati da piccolini o soffrire la fame, con carenze alimentari importanti, può avere conseguenze negative sullo sviluppo cognitivo. Essere poco stimolati non aiuta a raggiungere il massimo del proprio quoziente intellettivo e questo predispone ai disturbi mentali. Oggi ci sono sempre più seconde unioni e figli concepiti in età più avanzata hanno rischio maggiore; ma anche chi ha un rendimento scolastico scarso. In adolescenza, poi, arriviamo alle dipendenze e all’uso di sostanze. I cannabinoidi sono usati sempre prima, addirittura a 11 anni. C’è poi la dipendenza da internet, che è forse il fattore più drammatico.
Prescindere da internet oggi è molto difficile. Come difendere i più piccoli?
È imprescindibile per noi adulti che lo utilizziamo per lavoro, ma per un bambino di otto anni, francamente no.
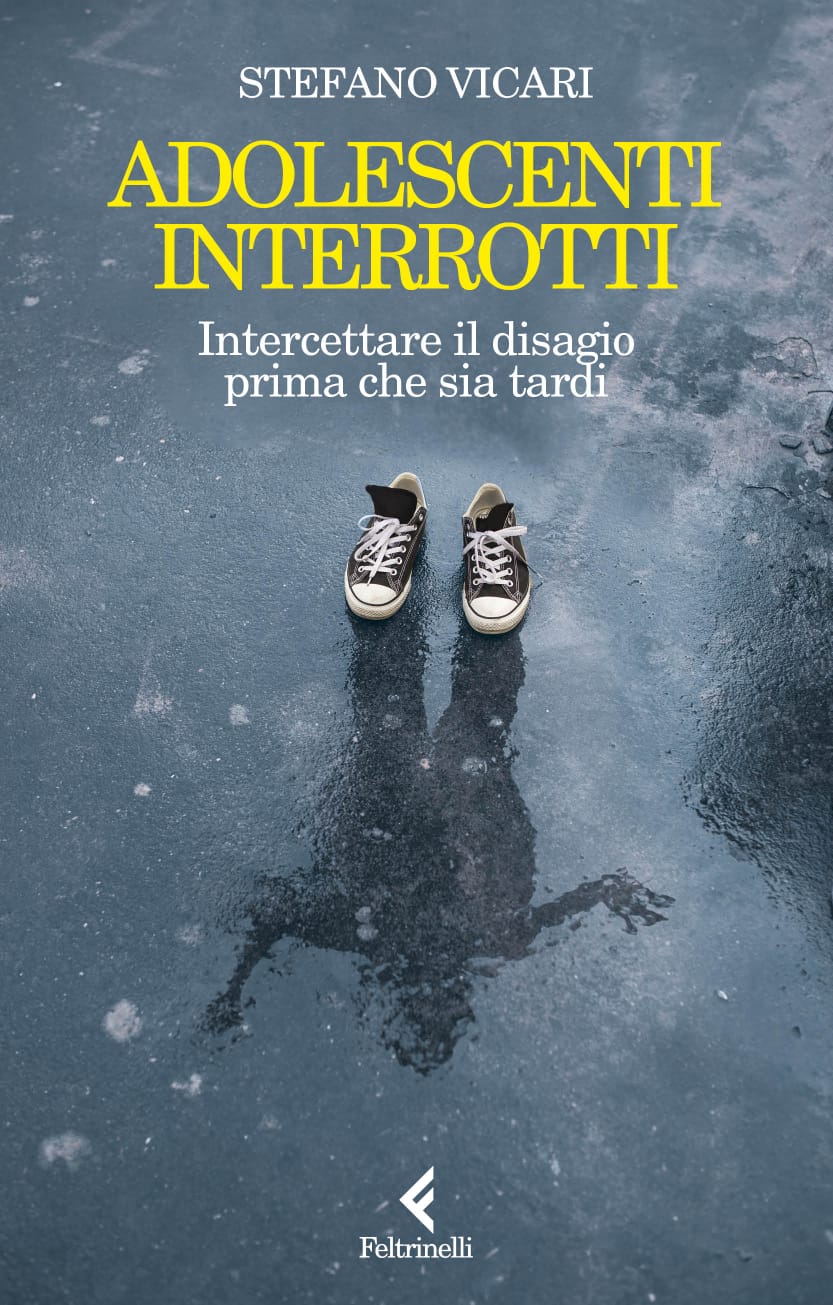
Ha qualche suggerimento per regolare il rapporto con il digitale dei ragazzi?
Bisogna educare a un utilizzo responsabile. Nei primi 12 anni bisogna fare un uso condiviso dei dispositivi: si può fare la videochiamata coi nonni, o un gioco stimolante assieme. Non bisognerebbe utilizzare le chat e Whatsapp; vedo bambini di otto e nove anni che chattano regolarmente. Poi man mano che i ragazzi diventano più grandi, si può lasciare che facciano un uso responsabile dei dispositivi, per un tempo limitato. Per esempio, la regola che suggerisco costantemente a tutti i genitori è di mettere via tutti i cellulari di casa – compresi quelli di mamma e papà – verso le 19 o le 20 per riprenderli la mattina dopo, a meno che gli adulti non facciano un lavoro per cui devono essere reperibili. Questo consente un maggiore spazio per la relazione, dà ai bambini la possibilità di raccontarsi, di ascoltare storie e letture.
Nel libro scrive che le linee guida pediatriche vorrebbero che si facesse zero uso dello schermo fino almeno ai 18 mesi.
Io sono ancora più estremo. Suggerisco ai genitori che fino a cinque anni della televisione si può fare a meno. Invece si può ascoltare musica. Ci sono molti studi che documentano come, facendo ascoltare Mozart nelle terapie intensive neonatali, lo sviluppo migliori.
Lei afferma anche che l’esempio dei genitori è importantissimo.
Certo. I figli non fanno quello che gli diciamo di fare, ma quello che ci vedono fare. Se un ragazzo vede un genitore costantemente a scrollare sullo smartphone lo imiterà. Se una persona chiede al proprio figlio di essere educato, ma poi questo lo vede in macchina a insultare tutti, quale messaggio passa?
I figli non fanno quello che gli diciamo di fare, ma quello che ci vedono fare
Cosa dovremmo fare noi adulti quindi per essere dei buoni modelli per i nostri figli e per creare un ambiente favorevole alla loro salute mentale?
Essere presenti, essere attenti. Guardarli e accorgerci quando stanno male. Non è necessario parlare molto, ma il messaggio che deve passare è «io ci sono, a tua disposizione, sono qui per te». Poi bisognerebbe stimolare i figli, consentirgli di leggere, suonare uno strumento, fare uno sport, coltivare relazioni positive. È stato fatto uno studio sui ragazzi per capire chi sono quelli che, nonostante lo stress che ha rappresentato l’epidemia di Covid-19, non hanno avuto sofferenze psicologiche. Chi ce l’ha fatta vive in appartamenti grandi – e questo è scontato, va da sé che era meglio stare in più spazio – viveva in famiglie con fratelli, in cui le relazioni sono coltivabili, faceva attività sportiva e ha letto almeno due ore al giorno. Aspetto interessante, questi ragazzi giocano e parlano in famiglia: c’è lo stare assieme, che non vuol dire trovarsi nello stesso posto, ma condividere, confrontarsi, raccontarsi, abbracciarsi e toccarsi. Un rischio, invece, è stato l’utilizzo contunuativo dei dispositivi elettronici.
Che ruolo può avere la scuola nella prevenzione dei disturbi mentali?
A 14 anni nessuno vuole relazionarsi con il proprio genitore come interlocutore fondamentale, ma va dal compagno di banco, dall’amico con cui condivide lo sport. La scuola potrebbe svolgere l’importante ruolo di favore le relazioni positive tra i ragazzi. Non dovrebbe concentrarsi esclusivamente sulla realizzazione del programma didattico, sacrificando l’aspetto educativo e pedagogico. I ragazzi spesso non hanno la possibilità di coltivare il rapporto tra loro se non virtualmente, ma le relazioni virtuali non sono come quelle in presenza.
Cosa deve fare un genitore se si rende conto che il proprio figlio ha i prodromi di un disturbo mentale?
Chiedere aiuto a un esperto. Vale sia per le famiglie che per gli insegnanti, non bisogna avere paura a segnalare situazioni in cui ci sia anche solo il sospetto di un disturbo mentale. Lo scorso anno è venuta da me una ragazza insieme alla sua mamma; dopo un po’ che parlavamo, quando si è stabilita una buona relazione le ho detto di togliersi la felpa. La madre è impallidita immediatamente perché la ragazza aveva le braccia completamente coperta di cicatrici, si tagliava da chissà quanto tempo. La cosa più terribile è quello che ha detto, guardando sua mamma: «Vedi, serviva lui perché tu ti accorgessi cosa mi sto facendo». Credo che i genitori dovrebbero essere molto attenti, guardare quello che succede e rivolgersi a un professionista – meglio un neuropsichiatra infantile perché è un medico e può indagare anche le situazioni più critiche e trattarle. La buona notizia è che da questi disturbi, se li si affronta, si guarisce.
Foto in apertura da Unsplash
Nessuno ti regala niente, noi sì
Hai letto questo articolo liberamente, senza essere bloccato dopo le prime righe. Ti è piaciuto? L’hai trovato interessante e utile? Gli articoli online di VITA sono in larga parte accessibili gratuitamente. Ci teniamo sia così per sempre, perché l’informazione è un diritto di tutti. E possiamo farlo grazie al supporto di chi si abbona.