Welfare
I gesuiti: «La giustizia riparativa per mettersi dalla parte delle vittime»
Un saggio e un articolo in uscita domani su La Civiltà Cattolica a cura di Francesco Occhetta riaprono il dibattito del rapporto fra vittime e carnefici e sul valore della carcerazione

“Le vittime dei reati e il loro dolore”. Si intitola così il contributo firmato da Francesco Occhetta in uscita domani sul nuovo numero de La Civilità Cattolica, che anticipato alcuni contenuti, che lo stesso giornalista e studioso gesuita ha messo al centro del libro “La giutizia capovolta” che sarà presentato al Salone del libro di Torino venerdì 13 maggio alle 12,30. Di seguito dal numero 3981 della rivista diretta da Antonio Spadaro una sintesi del contributo di Occhetta.

L’universo «carcere» non si limita ai suoi detenuti, ma è un mondo complesso di relazioni che coinvolge l’amministrazione carceraria, la polizia, gli operatori, gli avvocati, i volontari, come pure la società nelle sue più varie articolazioni. Certo, la situazione intesa in senso stretto nelle carceri italiane rimane complessa: nei 195 istituti penitenziari italiani, al 31 gennaio 2016, erano presenti 52.475 detenuti, a fronte di una capienza regolamentare di 49.480. I detenuti in eccedenza rispetto ai posti previsti erano 3.048 (+7,5%). Il tasso di recidiva all’inizio del 2015 era pari al 69%. Questo significa che, dei circa 1.000 detenuti che entrano ed escono dalle carceri ogni giorno, circa 690 ritorneranno a delinquere.
Senza voler criticare gli operatori penitenziari, che lavorano spesso in situazioni eroiche, va sottolineato che lo Stato spende solamente 95 centesimi al giorno per l’educazione dei detenuti, rispetto al costo giornaliero previsto pro capite di 200 euro. Per il mondo della giustizia, rimane valida una domanda antica: come è possibile garantire la certezza della pena insieme alla certezza della rieducazione?
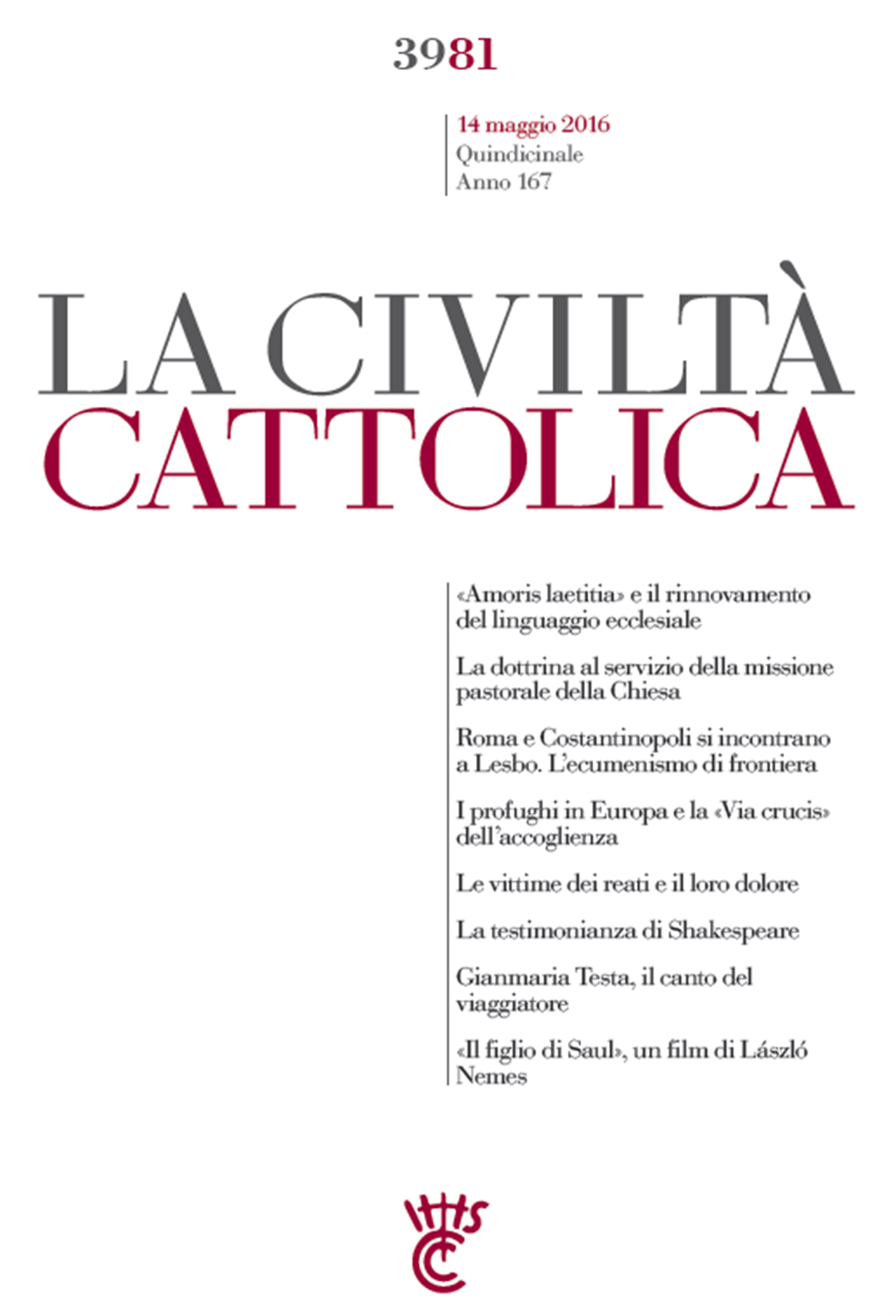
La popolazione carceraria è di sua natura poco rappresentativa della società: il 5% dei detenuti è costituito da analfabeti, il 45% è straniero, il 38% è senza fissa dimora, solamente l’1% dei detenuti è costituito da laureati; il tasso di suicidi nelle carceri è 18 volte superiore a quello dei suicidi che avvengono fuori. La giustizia penitenziaria è così chiamata a occuparsi di una parte dimenticata di società, fatta di incontri e di scontri, di interessi e di paradossi, che ha però un grande assente, definito dal diritto penale «il soggetto passivo del reato»: le vittime, con il loro dolore.
Lo Stato è in genere attento a risarcire le famiglie colpite, ma il dolore della vittima è come un fiume carsico nell’inconscio della memoria della società. Soprattutto, esso non cessa dopo essere stato risarcito. Rimane fino a quando non lo si scopre. Neppure la pena stessa inflitta al reo restituisce dignità alla vittima. L’orizzonte della giustizia, non alternativo al sistema ma integrativo e che non ripaga con altro male il male commesso, è quello della riabilitazione, basato su progetti di bene e sull’incontro tra vittime e colpevoli .
È questa una delle tesi centrali ribadite da Papa Francesco nei suoi interventi sulla giustizia: «Si tratta di rendere giustizia alla vittima, non di giustiziare l’aggressore […]; sarebbe un errore identificare la riparazione solo con il castigo, confondere la giustizia con la vendetta, il che contribuirebbe solo ad accrescere la violenza, pur se istituzionalizzata» .
Gesti e scelti che cambiano la storia
Esistono gesti compiuti dalle vittime dei reati o dalle loro famiglie così disarmanti a livello esistenziale da fecondare una nuova idea di giustizia. La madre del giudice Livatino, quando le chiesero se avesse perdonato gli assassini di suo figlio, rispose: «Anche se dentro di me ero spinta a non farlo, ho perdonato, perché ho pensato a mio figlio e al Vangelo che teneva sopra la scrivania: Rosario avrebbe perdonato».
La radicale «impotenza», generata dal dolore, può portare alla forza della parola «perdono». Questa parola è stata pronunciata anche a Foggia nel marzo del 1995 da Daniela Marcone ai funerali di suo padre Francesco, direttore dell’Ufficio del Registro (…).
Anna Laura Braghetti, che freddò con 11 colpi Vittorio Bachelet, ricorda così l’incontro con il fratello di Vittorio, il gesuita Adolfo Bachelet: «Entrai nel parlatorio del carcere di Rebibbia, mi venne incontro e mi abbracciò, un abbraccio lungo, e intanto mi accarezzava, mi consolava» . Ricorda anche l’incontro con il figlio di Vittorio Bachelet in occasione di un Convegno in Campidoglio: «Ci siamo riconosciuti. Mi ha parlato e mi ha detto che bisogna saper riaccogliere chi ha sbagliato. Lui e i suoi familiari sono stati capaci di farlo addirittura con me. Li ho danneggiati in modo irreparabile e ne ho avuto in cambio solo del bene» .
Ristabilire la giustizia, prima ancora che sia solo lo Stato a farlo, è possibile. Occorre però una profonda conversione culturale, che inizia dalla formazione nelle scuole. A una condizione, però: il primo passo di ogni riforma è sempre interiore. È un appello che nasce nella coscienza morale personale e comunitaria di un popolo. È l’esperienza del «sentire con» chi ha fatto e provocato il male (…)
Il cammino doloroso della verità
Esistono dunque, anche se a volte vengono fatte rimanere in penombra, esperienze fra vittime e rei, mediatori e testimoni — come quella coordinata dal gesuita Guido Bertagna, Adolfo Ceretti e Claudia Mazzucato —, che tracciano un cammino per incontrarsi come persone riconciliate dal dolore. Incontrare le vittime attraverso gli sguardi — ha dichiarato un ex militante dei gruppi armati — cancella ogni residuo di «velleità giustificatoria» rispetto alle scelte del passato.
Anche le persone assassinate, ridotte a simboli, riacquistano la loro umanità e dignità mediante il contatto degli assassini con i familiari delle vittime. E tutto questo attraverso la sofferenza. «Sinceramente vi ho odiato con tutto me stesso — racconta Giovanni Ricci, figlio dell’autista di Aldo Moro, ammazzato in via Fani —, poi sono cresciuto… convinto più che mai che dovevo confrontarmi con quel mostro. Ho scelto di doverlo combattere. Di doverlo affrontare. Di dover vivere di nuovo» .
Anche Manlio Milani, (nella foto di copertina) che vide morire la giovane moglie nella strage di piazza della Loggia a Brescia (1974), testimonia che la dura strada da percorrere è quella di incontrare i responsabili del male «per comprendere quelle atrocità e non restare chiusi nella logica del rancore e della rivalsa».

Lina Evangelista, moglie di un poliziotto assassinato dai neofascisti dei Nar nel 1980, ci dà questo insegnamento: «Perdonare non significa dimenticare il passato: si ricorda tutto, ma in modo diverso». E dopo aver incontrato gli assassini del marito, confida: «I mostri si sono rivelati tutt’altro». Tessere come in un telaio i fili della giustizia riparativa, di cui la nostra rivista in passato si è occupata , significa anche notare un ordito nascosto che illumina la storia e aiuta lo Stato a rendersi più trasparente e attento al dolore di coloro che soffrono.
Le vie della giustizia riparativa
«La difficoltà più grande nel percorso di elaborazione del lutto, per un familiare di una vittima delle mafie, è la socializzazione del proprio dolore privato, mettere a disposizione degli altri la propria storia perché diventi una leva del cambiamento, per trasformare la realtà che ci circonda. Una volta superata questa difficoltà, ti rendi conto che non sconfiggerai mai le mafie se non ti occupi delle periferie delle nostre città, se non pratichi quei luoghi dove le mafie sono più forti, anche per la colpevole disattenzione di chi ruba ai nostri ragazzi il futuro e non dà altra possibilità se non quella di aderire a un modello criminale» . È questa la testimonianza di Dario Montana, fratello di Beppe, il commissario della Squadra mobile di Palermo ucciso da Cosa Nostra il 28 luglio 1985.
Dario vive a Catania con i volontari del coordinamento e segue la strada tracciata da Deborah Cartisano in Calabria e da tanti familiari che in Campania hanno attraversato il portone di un carcere per far conoscere le storie dei propri familiari e parlare di lotta alle mafie.
Riconciliarsi è dunque possibile. Per «rifondare» la giustizia occorre una conversione culturale che contrapponga alla visione retributiva quella riparativa, che si fonda su una domanda: cosa può essere fatto per riparare il danno? . La riparazione non è solamente riconoscimento, ma include un percorso di riconciliazione che è impostato su quattro passaggi fondamentali: la consapevolezza, da parte del reo, della propria responsabilità; la comprensione, da parte del reo, dell’esperienza di vittimizzazione subita dalla vittima e del danno compiuto nei confronti della comunità intera; l’elaborazione, da parte della vittima, della propria esperienza di vittimizzazione; la presa di coscienza, da parte della comunità, dei livelli di rischio.
Il modello della giustizia riparativa, chiamata anche restorative justice, è molto diffuso soprattutto negli Stati Uniti e in Canada. Lo studio del modello nel Minnesota ha prodotto dati sorprendenti. In particolare, le vittime di un reato hanno dimostrato un alto livello di gradimento per gli esiti del modello riparativo: circa il 79% di esse ha partecipato alla mediazione, e di queste il 95% ha dichiarato la sua soddisfazione, mentre l’87% degli autori di reato si è dichiarato soddisfatto del modello. Degne di nota sono anche le esperienze di alcuni Paesi europei come Austria, Belgio, Francia, Germania, Lussemburgo, Portogallo, Spagna. Anche l’Unione Europea è molto attenta a questo modello .
Nei Paesi anglosassoni è avvenuto un vero cambiamento promosso dalle comunità, dalle persone, dal basso. Si è partiti con un’idea di restorative community e si è fatto un importante investimento sulla promozione del paradigma riparativo nella formazione dei bambini, i quali, oltre a essere i cittadini di domani, rappresentano la possibilità di cambiare prospettiva nella risoluzione dei conflitti interpersonali.
Se il modello della giustizia riparativa sta dando buoni risultati e sta entrando timidamente anche nel nostro Ordinamento, per quale motivo la pena deve rimanere (solo) detentiva? Lo ribadiamo: l’idea di corrispettività della bilancia della giustizia, in cui al negativo bisogna rispondere con il negativo, ha dimostrato il suo fallimento.
Certo, non è semplice. Lo conferma anche l’autorevole esperienza di don Ciotti: «Non parliamo, beninteso, di un cammino facile, perché la giustizia riparativa è, prima di un sistema giuridico, un prodotto culturale, capace di promuovere percorsi di riconciliazione senza dimenticare le esigenze della giustizia “retributiva”, incentrata sul rapporto tra il reato e la pena, e della giustizia “riabilitativa”, più attenta al “recupero” del detenuto […]. Percorsi delicati, quasi mai lineari, […] perché il ricostruire le relazioni umane e il tessuto sociale non può andare a discapito dell’equità, della certezza e della funzione riabilitativa della pena» .
Lo ribadiscono anche voci autorevoli del diritto, come, ad esempio, Francesco Cananzi, membro togato del Csm, il quale ha affermato: «Partendo dalla verità e dal suo accertamento […] l’incontro fra la vittima e il reo può dare senso sia all’una che all’altro, senza semplificazioni e banalizzazioni. Istituti come la mediazione penale devono affacciarsi con più convinzione nel sistema penale degli adulti» .
Gian Maria Flick, già presidente della Corte Costituzionale, sostiene che «va al di là del dovere di giustizia e di solidarietà ricordare la vittima; rispettarla e considerarla; ascoltarla e aiutarla essendole vicini; consentirle una rappresentanza adeguata. […] Non bastano le leggi di riforma. Occorrono prima di tutto società e cultura; occorre quella legalità sostanziale di cui oggi si tratta anche quando si parla di prevenzione della corruzione; occorre che finalmente recepiamo la cultura della reputazione e la cultura della vergogna. Vale per la corruzione, per l’evasione fiscale; ma vale anche e soprattutto per il carcere». Poi mette in guardia dalla «pubblicizzazione» impropria del dolore delle vittime: «Il cambiamento si costruisce non solo con le grandi riforme (quelle “epocali”), ma anche e prima ancora passo per passo: con la territorializzazione; con il decentramento; con la rimozione degli automatismi» .
Vuoi accedere all'archivio di VITA?
Con un abbonamento annuale potrai sfogliare più di 50 numeri del nostro magazine, da gennaio 2020 ad oggi: ogni numero una storia sempre attuale. Oltre a tutti i contenuti extra come le newsletter tematiche, i podcast, le infografiche e gli approfondimenti.
