Il caso di Luca
I bambini li stiamo mettendo al centro o in mezzo?
La Lega porta in Parlamento, con un'interrogazione parlamentare al ministro Nordio, la vicenda del piccolo Luca. Prende sempre più voce, al di là della vicenda specifica, la richiesta di riconoscere una "priorità" degli affidatari nel momento dell'adozione. Che però è un altro piano. Un dialogo con Barbara Rosina (Cnoas) e Laura Dutto (Uncm)
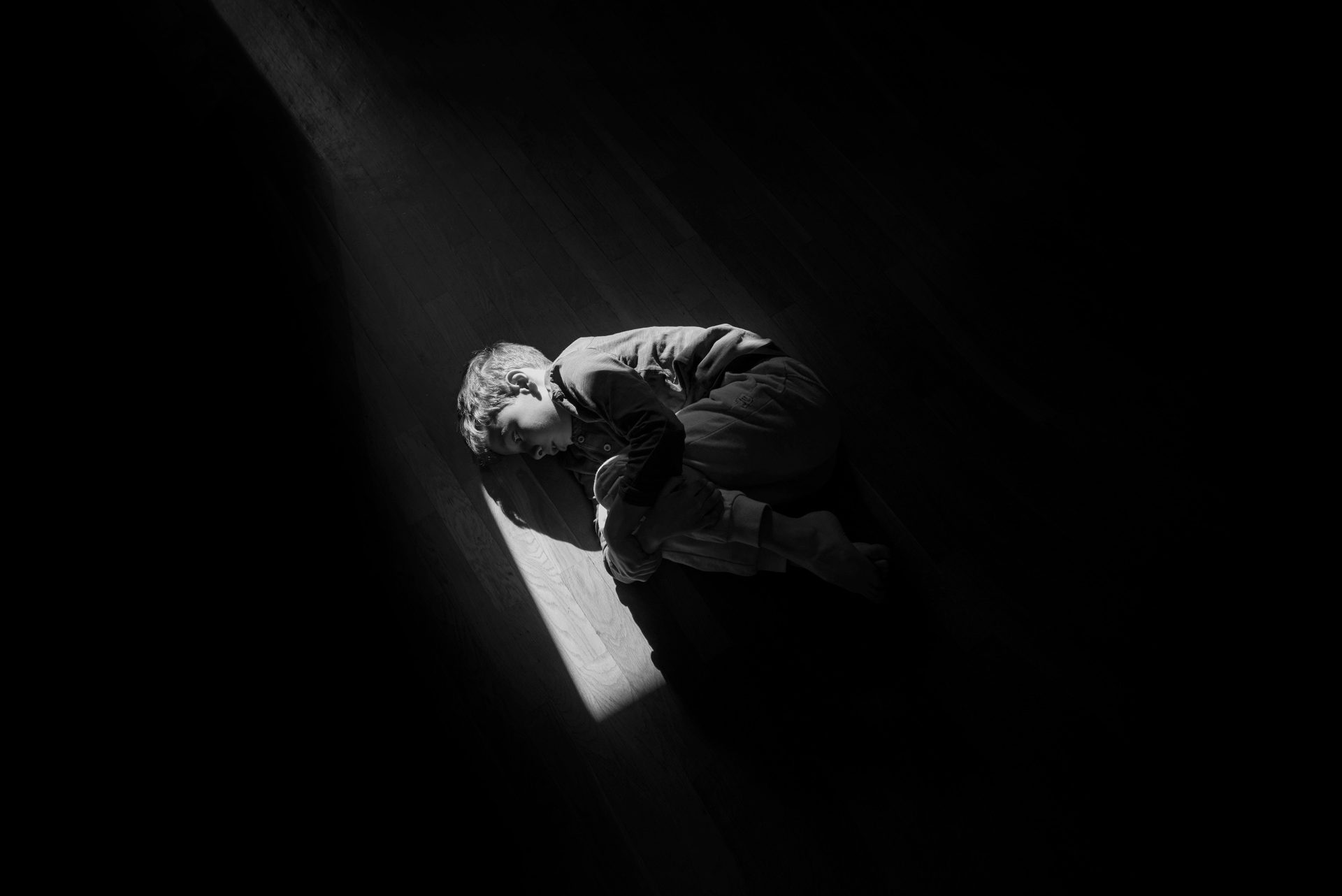
La pancia da sola non basta. Che non significa né difendere a priori “il sistema”, pensando che non possa sbagliare né misconoscere il peso e l’importanza della dimensione affettiva. In queste settimane, parlando con chi vive l’esperienza dell’affido e dell’adozione – che siano famiglie o operatori – un riferimento alla vicenda di “Luca” prima o poi salta fuori: c’è sempre un grande rispetto per la sofferenza che tutti stanno vivendo, ma anche grande sconcerto per un approccio così schierato che, ancora una volta, getta ombre sull’intero sistema e non rende giustizia alla complessità e alla delicatezza di queste situazioni.
Non ho mai sentito nessuno speso parole critiche nei confronti della famiglia affidataria e di come ha scelto di vivere questo momento, ma in tutti c’è amarezza per il modo in cui vicende così delicate, magari con legittimi elementi di dubbio sulle scelte fatte, vengano immediatamente strumentalizzate per accusare tutto un sistema o per chiedere, partendo da un singolo caso, rilevanti cambiamenti legislativi.
Ma un conto è, eventualmente, dire che qualcosa non ha funzionato nel caso specifico e un altro dire che tutti i bimbi in affido che vengono dichiarati adottabili dovrebbero restare in automatico nella famiglia affidataria, se questa è disponibile.
Sui social spunta il “diritto di prelazione”
La storia di Luca – così è stato chiamato nelle petizioni, sui social e sui giornali – è nota ormai a livello nazionale. È un bimbo che è stato accolto in affido quando era solo un neonato e la cui adottabilità è stata decisa dal Tribunale di Milano dopo quattro lunghissimi anni. A quel punto la famiglia affidataria si è resa disponibile ad adottare Luca, ma il Tribunale ha fatto una valutazione diversa, scegliendo per lui un’altra famiglia. La famiglia affidataria ha promosso una petizione, sollecitando la revisione della decisione del Tribunale. L’avvocata della famiglia è intervenuta più volte sui media. La Presidente del Tribunale per i minorenni di Milano, Carla Gatto, ha rilasciato una (inusuale) intervista dove, pur senza entrare troppo nello specifico, ha lasciato intravedere alcune ragioni per la scelta fatta. La situazione, di fatto, ha visto Luca entrare nella famiglia adottiva senza il supporto e l’accompagnamento della famiglia affidataria: quel diritto alla continuità degli affetti, che secondo la legge 173 non è necessariamente il restare nella stessa famiglia affidataria, di certo – non sta a noi dire per quali ragioni – Luca non lo ha avuto. Da pochi giorni il Tribunale per i minorenni di Milano ha respinto il ricorso per far rientrare Luca nella famiglia affidataria in cui era cresciuto. La vicenda ha mosso emotivamente migliaia di persone, come i tantissimi commenti sui social mostrano.
La stragrande maggioranza delle persone commenta schierandosi. Non viene mai il dubbio che se un Tribunale in forma collegiale si è espresso in quel modo, lo possa aver fatto davvero nell’interesse del minore: il tono prevalente invece sottolinea l’incompetenza del sistema di protezione dei minori, il fallimento della giustizia minorile, i suoi errori. Nei commenti si legge addirittura che in virtù della legge 173/2015 la famiglia affidataria – in caso di adottabilità del bambino – ha «diritto di prelazione» sullo stesso. Altri usano parole meno forti, ma il concetto è molto diffuso.
L’interrogazione parlamentare della Lega
A sostegno della famiglia affidataria nella denuncia della violazione del diritto alla continuità degli affetti di Luca e della sua richiesta di revisione delle decisioni del Tribunale per i minorenni si è schierato già da qualche tempo Alberto Pellai, medico, psicoterapeuta. In questi ultimi giorni si è aggiunta Simonetta Matone, magistrata, oggi deputata della Lega. Proprio ieri Simona Loizzo (sempre Lega) ha presentato un’interrogazione al ministro Nordio per sapere «quali urgenti e necessari interventi di verifica e revisione della pur sempre valida normativa di riferimento intenda adottare al fine di prevenire e contrastare episodi analoghi per tutelare il superiore interesse dei minori e prevedere, nella considerazione dell’esperienza pregressa, una procedura più snella dell’idoneità all’adozione per gli affidatari». Il ministro ha risposto dando incredibilmente nome cognome e età degli affidatari (l’età era un punto critico citato dalla presidente Gatto nella sua intervista): la donna sfora di due anni e l’uomo di cinque anni la differenza di età massima con il minore adottato, che per legge deve essere di 45 anni. Per l’adozione però. Perché la legge sull’affido non dà alcuna indicazione dell’età.
Cambiando paese e solo per fare un esempio, La Vanguardia ha da poco dedicato un ampio servizio ad Anna Casals e al suo compagno Xavier Rusiñol, che vivono a Berga (Barcellona), hanno 73 anni e hanno in affidamento una bambina che ora ha sei mesi. «Abbiamo bisogno di famiglie affidatarie di tutti i tipi, ma questo profilo, quello delle famiglie anziane, è particolarmente adatto alla modalità di affidamento di emergenza», ha detto la ministra dei Diritti Sociali e dell’Inclusione della Generalitat della Catalogna, Mònica Martínez Bravo. Tra le famiglie affidatarie in Catalogna, il 7% ha più di 60 anni.
La risposta del ministro Nordio
Il ministro Nordio invece annuncia degli accertamenti per verificare questo punto dell’età e se «vi siano altri casi di bambini affidati consapevolmente a coppie che sono prive dei requisiti di adottabilità o che sono in procinto di perdere questi requisiti». Ma gli affidi non partono già con la prospettiva dell’adozione, anzi dovrebbe essere proprio il contrario. Anche se è vero non solo che le rilevazioni ministeriali dicono che circa due minorenni su tre sono in affidamento familiare da oltre 2 anni, ma anche che gli affidi sine die sono ormai tantissimi.
Colpisce che il ministro si riferisca al passaggio dalla famiglia affidataria a quella adottiva usando l’espressione «quando è stato sottratto». L’onorevole Matano, nella replica, afferma che quando «il tribunale per i minorenni sostiene è errato, è falso, è menzognero», che «l’errore lo hanno fatto loro» perché hanno affidato il bambino loro un bambino minore di 4 anni «ad una coppia che sforava l’età di due anni lei e di cinque anni lui». Dice di avere «prova dei ricatti a cui questa coppia è stata sottoposta». E conclude dicendo che «un Paese in cui accade questo è un Paese che deve mettere mano alla legislazione, deve dare voce alle famiglie affidatarie, che si devono costituire in giudizio, potersi costituire in giudizio».
Avvocati e assistenti sociali: due voci per riflettere sul sistema
Senza conoscere le carte e i dettagli della vicenda è chiaro che è impossibile schierarsi o anche solo entrare nella logica della ragione e del torto. Si può però ragionare su cosa funziona e cosa non funziona a livello di sistema. Perché è chiaro che quattro anni per decidere dell’adottabilità di un neonato sono un tempo davvero troppo lungo. Sappiamo pure che tanti affidatari vorrebbero essere più ascoltati dai Tribunali e dai servizi.
In questo ragionamento abbiamo chiesto aiuto a Barbara Rosina, assistente sociale, presidente del Consiglio Nazionale degli Assistenti Sociali e Laura Dutto, avvocata, consigliera nazionale dell’Unione Nazionale Camere Minorili: due mondi professionali che ogni giorno sono sul campo a tutela del diritto dei bambini a crescere in una famiglia.
Che commento sensato si può fare a margine di una vicenda che ha commosso e coinvolto emotivamente tante persone?
Barbara Rosina: Se una vicenda muove in modo così importante l’opinione pubblica, è perché tocca aspetti fondamentali delle nostre vite personali. Al di là di tutto vorrei dire che comprendo il dolore della famiglia affidataria, a cui il sistema deve un ringraziamento: sappiamo quanto sia grande la disponibilità di chi si mette a disposizione di un bambino e lo inserisce nel proprio contesto familiare con un inserimento provvisorio ma con una relazione che resta. Rifuggo però la logica del dire chi è nel giusto e chi ha sbagliato: non possiamo dimenticare che i Tribunali e i servizi devono prendere decisioni complesse, sulla base della legge. Nel nostro lavoro sai che le decisioni che prendi possono avere effetti dolorosi, ma devono esser prese a tutela del minore. Ed è chiaro che una sofferenza colpisce anche “Luca”, nonostante la decisione sia stata presa nel suo interesse. Quindi nessun giudizio, non conoscendo nello specifico gli atti della vicenda, ma una riflessione per costruire insieme percorsi più chiari, anche nelle tempistiche, e più rispettosi dei tempi dei bambini e delle famiglie.
Laura Dutto: Sono curatore speciale da trent’anni, situazioni di questo genere sono sempre strazianti. La prima cosa da sottolineare è il valore e l’importanza dell’affido, che letteralmente salva e fa rifiorire i bambini. Credo si dovrebbe partire dal fatto che a ciascuno degli attori della vita del bambino fuori famiglia debba essere data voce più e meglio di quanto si fa ora. A ciascuno va rispetto, a ciascuno va riconosciuto un ruolo. La legge 173 è nata fondamentalmente per introdurre nell’ordinamento il concetto della continuità affettiva come necessità di evitare cesure troppo nette ai bambini che attraversano collocazioni plurime: quindi la possibilità per la famiglia affidataria di adottare il minore dichiarato adottabile, ma anche la possibilità di mantenere i contatti con la famiglia affidataria o con gli educatori della comunità quando rientra nella famiglia di origine o quando va nella famiglia adottiva. Quando sento parlare di violazione dei diritti penso che sia corretto – per tutti – ricordarci che le sentenze si sforzano sempre di rappresentare l’interesse del minore.
A dieci anni dalla legge 173/2015 sulla continuità degli affetti del minore in affido, dal campo, quanto e come quella legge è stata attuata? C’è discrezionalità, ci sono ancora resistenze o al contrario si rischia di leggerla come se la legge sancisse il diritto degli adulti alla continuità degli affetti con il minore, cosa che nella legge non c’è?
Barbara Rosina: A livello generale la legge ha prodotto cambiamenti reali nelle prassi, nel modo in cui si affrontano i passaggi. Sono stati fatti protocolli in tanti territori, mentre in altri territori non si è fatto nulla e anzi direi che proprio non si è capita la legge. Riconoscere per legge il diritto alla continuità degli affetti del bambino significa dire che i legami sono parte di una identità. La legge – su questo dobbiamo essere chiari – che non attribuisce un diritto all’affidatario né una “priorità affettiva”. L’interesse del minore deve essere il faro. La legge serve per protegge il bambino dalla discontinuità tutte le volte in cui questa non è necessaria: perché a volte invece lo è. In tanti territori è stato fatto un lavoro importante tra servizi, famiglie affidatarie, famiglie di origine con protocolli, formazione, condivisione di linguaggi professionali.
Laura Dutto: Io non credo ci sia questo rischio. Nella mia esperienza di avvocato – anche prima che ci fosse questa legge – ho sempre visto i giudici minorili mettere in campo normalmente una grande elasticità di pensiero, perché valutano davvero l’interesse del minore e adattano sempre la decisione al caso concreto. Ho visto un irrigidimento quando dall’altra parte ci si avvicina con irrigidimento. L’art 22 della legge adozioni prevede che nel decidere l’abbinamento per bambino adottabile si scelga fra le coppie che hanno presentato domanda quella maggiormente in grado di corrispondere alle esigenze del minore. Evidentemente nella valutazione ha ritenuto che ci fosse una coppia in grado di rispondere maggiormente. Detto questo, è vero che l’audizione degli affidatari in questa fase è rilevantene e doverosa. A volte però oggi viene fatto più come adempimenti burocratico che non come un vero ascolto, con uno scambio concerto. Io credo che – a maggior ragione in un momento in cui parliamo di continuità degli affetti e di adozioni aperte – si debba dare il giusto spazio a tutti i soggetti presenti nella vita dei bambini che attraversano collocazioni plurime. Se tutti avessero uno spazio, una voce, se tutti sentissero visti e valorizzati… sarebbe si eviterebbero tante conflittualità. partiamo da opinioni diverse? D’accordo, ma ragioniamo insieme sul diritto del bambino, ascoltiamoci l’un l’altro non in maniera contrapposta: solitamente accade che piano piano ci avviciniamo. Ovviamente senza dimenticare che a un certo punto il giudice deve pur decidere, ma questo serve a tutti, in primis ai bambini.
Cosa serve per attuare questo ascolto?
Laura Dutto: Spazio e tempo. Ma serve anche trovare operatori disponibili a farlo. Il fatto è che oggi in questo ambito si ha tutti davvero molto, troppo da fare.

Com’è possibile che l’affido ponte di un neonato sia durato quattro anni? Non è questo il “nodo” della vicenda? Quali elementi in generale allungano i tempi delle decisioni dei servizi rispetto all’adottabilità?
Laura Dutto: È vero che quattro anni per decidere l’adottabilità per un neonato sono tanti. Poniamoci però in un’altra ottica: se quel tempo è servito ad approfondire la situazione del suo nucleo familiare di origine, per verificare tutti i sostegni e per fare tutti gli accertamenti, in maniera tale da avere la certezza che non ci saranno ricorsi o ripensamenti… quel tempo non è trascorso invano. L’altro punto che in generale mi sentirei di sottolineare è che, anche con la legge 173, la famiglia affidataria non ha un diritto sul bambino adottabile: esprime una disponibilità, che i giudici valutano. Ma quando si valuta una famiglia per l’adozione si valuta la famiglia più adatta ad accogliere per sempre quel bambino specifico. Magari una famiglia era adatta ad accoglierlo per l’affido, che è temporaneo, ma non per sempre. La famiglia affidataria ha fatto sicuramente un lavoro ottimo con il bambino, nessuno lo ha mai messo in discussione: la valutazione è stata sull’essere la famiglia più adatta per il bambino per sempre.
Barbara Rosina: Non dovrebbe accadere che un affido duri tanto a lungo, soprattutto se si tratta di un affido ponte, ma accade e accade anche in numeri non irrilevanti. Qui si tratta di cercare di capire gli elementi che allungano i tempi della valutazione: le situazioni complesse, i percorsi di recupero della capacità genitoriale di famiglie segnate da fragilità o da malattie, da cambiamenti sociali e relazionali. Mentre i servizi cercano di capire se ci sono i margini per recuperare la capacità genitoriale è possibile che passi troppo tempo perché c’è un sovraccarico dei servizi: il Lep che vuole 1 assistente sociale ogni 5mila residenti non c’è ovunque! Lo stesso i Tribunali per i minorenni: hanno un carico altissimo, anche per effetto della riforma Cartabia. È vero però che se rimaniamo fermi troppo a lungo, in attesa che tutto sia chiaro, il bambino cresce. Serve più tempestività e interazione tra servizi e magistratura, che tutti si ricordino che i bambini non hanno un tempo infinito per essere bambini. Sull’affido ponte, nello specifico, ci sono grandi differenze regionali: è preziosissimo per garantire ai neonati un contesto familiare, ma non è diffuso in maniera uniforme, né viene attuato in modo uniforme. Per esempio Piemonte, Emilia Romagna e Toscana hanno protocolli che definiscono i tempi e prevedono équipe che fanno supervisione. Un tema certamente è che le buone pratiche non siano isolate ma diventino patrimonio condiviso, magari attraverso delle linee di indirizzo nazionali che creino una cultura condivisa.
Il tema della conflittualità e di come gestirla è emerso in altri casi arrivati alle cronache. È sempre più centrale ed è una sfida per i servizi come per i Tribunali o per le associazioni… Cosa può aiutare in questo momento?
Barbara Rosina: Saper comporre la conflittualità è una sfida complessa perché l’esposizione mediatica – che non è solo quella dei media ma anche quella dei social – porta a semplificare con una polarizzazione tra chi è nel giusto e chi ha sbagliato, tra persone e professionisti dei servizi, tra famiglie e interventi… non aiuta nessuno. Non aiuta le persone che dei servizi dovrebbero fidarsi. Da un lato la gestione del conflitto non è un tema così affrontato nei corsi di laurea per tali professioni: serve una formazione per i servizi, per i giudici, per il Terzo settore, per le famiglie. Servono spazi di confronto tra le professioni e le istituzioni. Serve garantire supervisione agli operatori. E poi c’è il tema della politica, che tende a spettacolarizzare le situazioni. Quando questo accade, noi non stiamo mettendo i bambini al centro: li stiamo mettendo in mezzo.
Foto di Mali Desha su Unsplash
17 centesimi al giorno sono troppi?
Poco più di un euro a settimana, un caffè al bar o forse meno. 60 euro l’anno per tutti i contenuti di VITA, gli articoli online senza pubblicità, i magazine, le newsletter, i podcast, le infografiche e i libri digitali. Ma soprattutto per aiutarci a raccontare il sociale con sempre maggiore forza e incisività.
