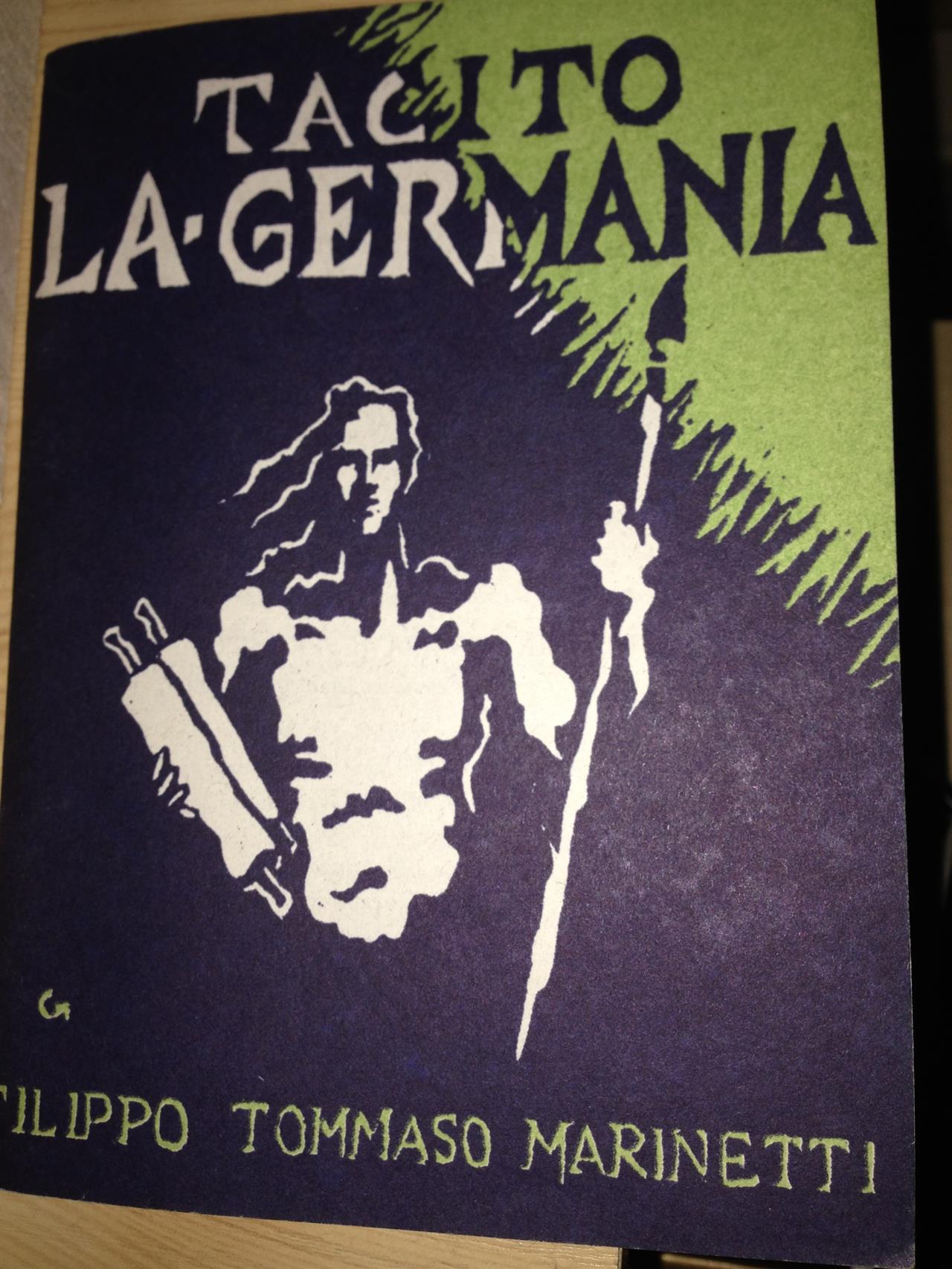Che cosa diventa il “gioco” se tutto è gioco? Quando arrivava il mattino, gli indiani Seneca dell’Ontario spezzavano gli strumenti di gioco perché il lusus non deformasse la vita quotidiana e non ne venisse a sua volta contaminato.
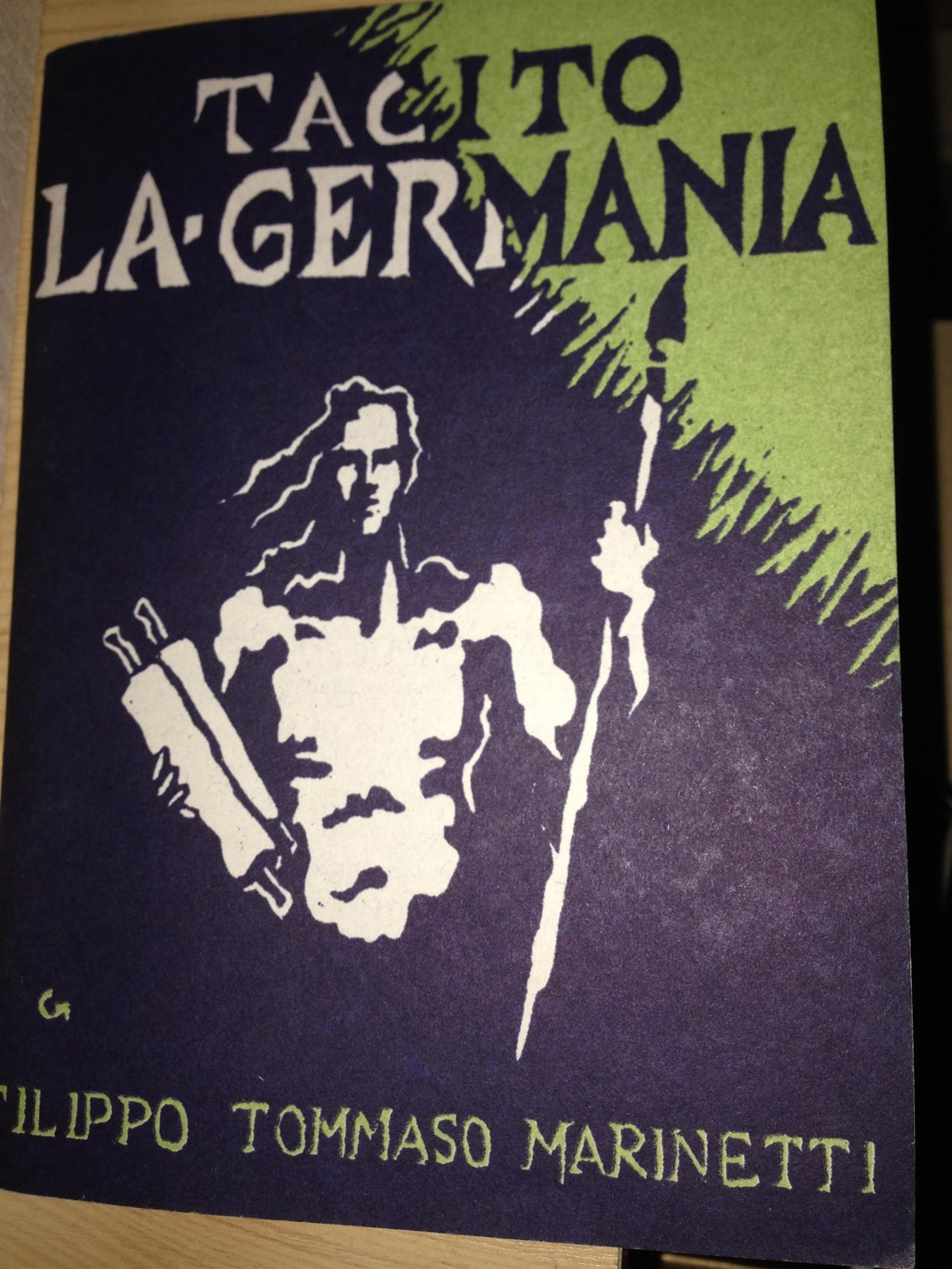
Tacito, da parte sua, riferisce di aver visto giocare i Germani. «È stupefacente – scrive – vedere con quale serietà giochino ai dadi e mai in condizioni di ubriachezza». La sobrietà con cui vi si dedicavano ci direbbe ancora molto del rapporto – delicato, tangente il sacro – fra vita e gioco se davvero ci sapessimo interrogare. Potremmo partire dauna di quelle parole che questo rapporto lo implica, anche se in negativo: “gamification”.
HOMO LUDICUS
Per quanto orribile, “gamification” è una parola destinata a durare. Usata occasionalmente negli anni ’50, nell’ambito delle ricerche di Elton Mayo sulla sociologia degli ambienti di lavoro e sul cosiddetto “effetto Hawthorne”, la parola ha conosciuto un uso intensivo ed estensivo nel primo decennio del XXI secolo, in conseguenza della trasformazione del mercato dei videogiochi dovuta alla crescente possibilità di farli “girare” su piattaforme “social” e dispositivi digitali portatili.
“Gamification”: il significato di questa parola è semplice e si potrebbe altrettanto semplicemente tradurre con “ludizzazione”.
“Gamification” significa infatti «rendere qualcosa simile a un gioco» introducendo in contesti che non sono tipici del gioco elementi invece tipici del gioco stesso, quali punti, premi, salti di livello. E soldi, quando di mezzo ci sono (prodotti) e soldi.
Per raggiungere un pensiero convergente e finalizzato a uno scopo – ad esempio: aumentare la “produttività” di un gruppo di lavoro – si ritiene necessario affidarsi a un pensiero divergente e controfattuale, attivabile da dinamiche di gioco.
Da termine nasce termine ed è così che “gamification” ha dato origine a un verbo di nuovo conio, “to gamify”. “To gamify everithing” ovvero ludicizzare tutto. Perché tutto – dal lavoro alla scuola, dalla disoccupazione al consumo alla critica della disoccupazione, del lavoro, della scuola e del consumo – è stato effettivamente “ludicizzato” e reso simile a un gioco.
Nel marketing come nell’economia, nel lavoro come nella scuola tutto ciò che non è gioco deve oramai passare dal “gioco” per essere considerato “partecipato”, “condiviso”, “social”. Libri-gioco, giochi per consumare merendine, per accendere mutui, per regalare case e persino per “vincere” posti di lavoro. Nulla sfugge a questa logica. Nei dibattiti ha così fatto la sua comparsa questa parola, “gamification”, che parla proprio di questo strano aspetto dell’esistenza contemporanea: incapace di gioco, proprio mentre il gioco sembra dominare la scena.
OLTRE LA LINEA
Eppure, il termine termine “gamification” definisce più un contesto che un oggetto specifico, oggetto che infatti continua a sfuggirci.
Che cosa succede quando tutto è gioco? Semplicemente – come mostrato da Collodi nel suo (o nostro?) Paese dei Balocchi – il gioco finisce di essere tale. Il salto è qualitativo, non quantitativo: non basta dire “moderiamo”, “limitiamo”, “rendiamo responsabili”. Una volta superata la linea, mutazione appare irreversibile.
Per questo, pur fotografando un contesto, anche col termine “gamification” ci sentiamo a disagio. Ci manca infatti la capacità di definire quel “negativo” del gioco che è l’oggetto che sfugge al concetto. Quel negativo che forse è lo specifico cui “gamification” allude. Modellandola sulla nozione di pseudo-festa avanzata dal teologo Josef Pieper, potremmo servirci operativamente e in attesa di meglio di pseudo-gioco.
Che cosa si fa quando si opera una “gamification”? Si rende semplicemente simile a un gioco, si avvicinano gioco e ciò che gioco non è a una zona crigia, crepuscolare e indeterminata, una twilight zone segnata dalla nozione di pseudo-gioco.
Ma che significa “rendere qualcosa simile a un gioco” (trasformandola in uno pseudo-gioco)? Soprattutto: “che cosa” andrebbe reso simile a un gioco? Nel marketing, gli specialisti parlano di “processi di gamification” e di “gamification marketing” : processi strutturati al fine di promuovere «desired behaviors among customers and employees». Insomma, un modo – ma non un modo come un altro – per condizionare i nostri comportamenti.
Sappiamo fin dagli anni ’30, dagli studi di B. F. Skinner,che tra i modi per condizionare il comportamento il più efficace è quello del “condizionamento operante”, su cui fanno d’altronde leva tutti i giochi traminte “macchinette” che provocano dipendenza. Detto in poche parole: nessuno vi costringe a nulla, almeno in apparenza. Ma attraverso un sistema di gratificazioni e premi, vi troverete indotti a apprendere un comportamento [cfr. Tom Chapfield, “Gamification”, in ID., Netimologia, Etas, Milano 2013].
DOPPIO LIVELLO
La strategia opera all’esterno (⇒verso i consumatori), ma anche all’interno (⇒verso di dipendenti, ad esempio con l’elezione del “dipendente del mese” o la messa in competizione su scala globale, cosa avviene in certe fabbriche di automobili come nel W0rld Class Manufacturing). Non servono tecniche lineari se il fine è quello di sviluppare molteplici e sempre più integrati livelli di fedeltà al prodotto, all’azienda, a un immaginario e infine alle forme di vita che ne derivano. Ma il gioco non è una tecnica, casomai è il modo di dar senso (o privar di senso) una tecnica. Per questo, lo psicologo sociale H. G. Mead poteva affermare che il gioco è l’adattamento a un ambiente che non c’è.
Nel nostro ambiente sempre in divenire e, quindi, sempre potenziale, non è più la figura del lavoratore a dominare la scena, ma quella del giocatore (di volta in volta giocatore-consumatore, giocatore-lavoratore, giocatore-cittadino, giocatore-disoccupato, giocatore-investitore, giocatore-imprenditore etc.). Il fenomeno è tutt’altro che nuovo, ma nuove sono l’intensità e l’efficacia che dal fenomeno hanno origine.
La diffusione oramai capillare di smartphone e nuovi media ha reso ancora più integrati i processi di “gamification” aumentando i livelli potenziali di crescita – come si può vedere dal grafico pubblicato nel 2013 da Business Insider.
Uscendo dai modelli predittivi e dalla retorica manageriale, resta da chiedersi che cosa vi sia al cuore del processo di “gamification”.
Solo un – legittimo o meno che sia – tentativo di espandere il campo dei propri profitti, migliorando la resa interna e la fedeltà al consumo? I nuovi processi di ludizzazione, si reggono sulla messa a profitto dell’esperienza non più sulla seduzione del consumatore o sulla fedeltà del lavoratore. Seguono dinamiche skinneriane, non pavloviane.
Lo stesso si può dire – come aveva predetto fin dal suo primo romanzo, Solar Lottery, P. K. Dick – per la cittadinanza, messa in gioco con consultazioni non istituzionalizzate: primarie, consultazioni informali, simulazione di consenso tramite sondaggi.
Il livello base – lo scopo, se vogliamo chiamarlo così – dei processi di “gamification” o ludizzazione è aumentare il convolgimento o l’adesione volontaria da parte di un soggetto a situazioni altrimenti percepite come sfavorevoli o persino ostili.
IL “GIOCO” DELLE TASSE
Un esempio tipico sono le tasse. Le lotterie – la prima venne istitutita a Firenze nel 1530 – storicamente si configurano come strumenti per mascherare e far accettare forme di tassazione basata su una «imposta straordinaria basata sul gioco forzato» (così si esprime il Vocabolario Treccani alla voce “Lotto”). Chi pagherabbe volentieri un’imposta o una tassa, soprattutto se percepita come inutile? Nessuno, nemmeno il cittadino più ligio ai doveri. Ma chi non “giocherebbe” quei soldi se la tassa si mascherasse, appunto, da gioco?
Passeggiando nel parco di Sans-Souci, a Postdam, Giacomo Casanova ebbe modo di esporre a Federico II di Prussia il proprio programma per risanare le finanze del Paese. Poche parole, ma con l’indubbio pregio della chiarezza. Ci sono, disse, tre specie di imposte, considerandole in rapporto ai loro effetti sugli equilibri tra governati e governanti. La prima specie è «rovinosa», l’altra «necessaria», mentre l’ultima imposta è «sempre eccellente» e comporta un grande vantaggio: si possono tartassare gli uni, senza in alcun modo smettere di far la morale agli altri.
È facile intuire, leggendo il terzo tomo dell’Histoire de ma vie, di quali singole imposte il buon Casanova predicasse gli altrettanto singoli attributi, comprendendo già a pieno vizi e virtù della “gamification”, pur senza ricorrere a quell’orribile neologismo.
Il «minuto popolo», suggeriva Casanova, non ama affatto l’imposizione diretta, tollera appena quella indiretta, ma trova «toujours excellente», specie nei periodi di crisi, la tassazione “volontaria”. A patto che la si sappia camuffare tra le pieghe dei suoi vizi, imbellettandoli da pubbliche virtù.
Cosa puntualmente avvenuta col tabacco o l’acquavite, cosa che puntualmente dal XIII secolo avviene con le forme storicamente assunte dal gioco d’azzardo – dalle “baratterie”, le prime bische pubbliche in Firenze e Siena, alle lotterie nazionali, ieri; oggi, con videolottery, slot e newslot, lotto24, scommesse e via discorrendo – quando pubblicamente regolato…
@oilforbook
Nessuno ti regala niente, noi sì
Hai letto questo articolo liberamente, senza essere bloccato dopo le prime righe. Ti è piaciuto? L’hai trovato interessante e utile? Gli articoli online di VITA sono in larga parte accessibili gratuitamente. Ci teniamo sia così per sempre, perché l’informazione è un diritto di tutti. E possiamo farlo grazie al supporto di chi si abbona.