Dopo il caso Palenzona
Fondazione di origine bancaria: la rappresentanza lasci spazio alla responsabilità
L'intervento del presidente di a|cube membro del cda di Avanzi: «C’è mai stata, in Italia, una valutazione seria su quanto le fondazioni hanno fatto? O, ancor più puntualmente, su quanto abbiano fatto le singole consigliature? Ce ne sarebbe un gran bisogno»
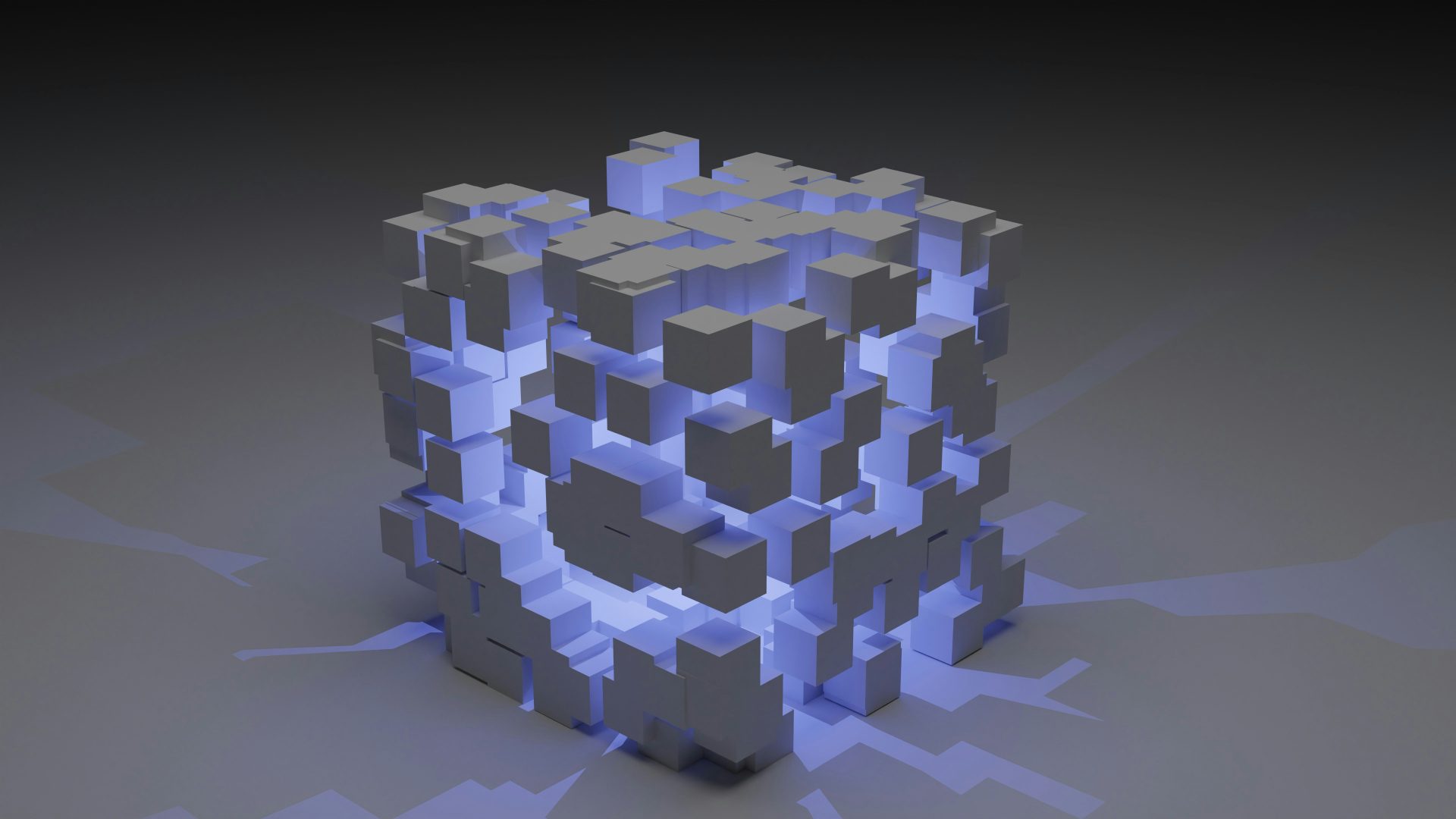
Qualche settimana fa, su queste pagine, Federico Mento prendeva a pretesto il “caso Palenzona” per sostenere la necessità di ripensare al modello di governance delle fondazioni di origine bancaria, che sono soggetti di fondamentale importanza nel sostegno al Terzo settore. In base alla legge che le ha istituite, ciascuna di esse stabilisce nel proprio statuto le modalità di nomina degli organi di amministrazione, ma, nella maggioranza dei casi, è previsto un meccanismo di coinvolgimento di istituzioni ed enti locali (la regione, il comune, l’università, la camera di commercio, la curia …), ciascuno dei quali indica dei candidati che li rappresentino.
Basta migliorare i meccanismi della rappresentanza?
Il punto di Mento è che la scelta sugli organi di governo delle fondazioni non si basa sul confronto tra un’agenda e un’altra (quali sono i bisogni, quali le risposte, quali gli strumenti di intervento e quindi quali le persone in grado di attuarli) e si riduce ad un confronto tra gruppi di potere. Sono molto d’accordo, ma penso che, in realtà, l’ambito della riflessione vada esteso ulteriormente. A mio avviso, la questione non è solo quella di migliorare i processi di ascolto in una società complessa (problema che esiste, ovviamente), ma di capire se il tema della governance possa essere affrontato e risolto solo migliorando i meccanismi della rappresentanza.
Sulla crisi della rappresentanza si è detto e scritto moltissimo. Da tempo ci diciamo che i sindacati non rappresentano più i lavoratori, le associazioni dei consumatori non rappresentano più i consumatori, che le associazioni di categoria non rappresentano più le imprese, che i partiti non rappresentano più i cittadini, che la società civile non è rappresentata da nessuno, eccetera.
Il problema è molto serio, perché noi viviamo in una democrazia rappresentativa, cioè che fa della rappresentanza il proprio modello fondativo. Allora partiamo dai concetti di base: che cosa significa rappresentare? La parola viene dal latino e vuol dire “mettere davanti agli occhi, riprodurre, raffigurare mediante immagini o simboli”. Una rappresentazione teatrale simula la vita sulla scena. Un ritratto ci rimanda ad un determinato soggetto. Sappiamo tutti che è una finzione, ma ci riconosciamo in essa, cioè le attribuiamo una parvenza di verità.
Un meccanismo da cambiare
Che c’entra tutto questo con le fondazioni, da cui siamo partiti? C’entra perché, come dicevamo, la loro governance è costruita sul meccanismo della rappresentanza e, se non funziona più, occorre inventarsi qualcos’altro. La mia opinione è che non è il fatto di essere rappresentante di qualcosa o delegato di qualcuno che fa di una persona un bravo consigliere di amministrazione – e, corrispondentemente, se una persona è competente e capace, non rileva il fatto che non abbia un ruolo o un’investitura. Anzi, oggi il fatto di rappresentare qualcosa o qualcuno può addirittura diventare un alibi per giustificare l’incapacità. Peggio, il fatto sedere in un consiglio di amministrazione in rappresentanza di qualcuno comporta il mandato a tutelare gli interessi specifici di chi ha espresso la candidatura – che non necessariamente coincidono con quelli, generali, della fondazione.
Quindi non è migliorando i processi di ascolto, temo, che si ottiene una visione più completa sulla realtà di un territorio; non è sul cencellismo che si ricostruisce una rappresentazione compiuta della società.
Servono modelli alternativi
In un sistema in cui nessuno rappresenta più niente, se non se stesso, è solo dalla qualità dei singoli (intesa come competenza, indipendenza, correttezza) che si può ripartire. Penso che sarebbe interessante sperimentare dei modelli alternativi. Prendo ad esempio (senza ovviamente pensare che possa essere ripreso tal quale) quello adottato in alcune società private a capitale diffuso – quelle che, nei Paesi di cultura anglosassone, vengono chiamate public companies: in questo caso, in cui non c’è un azionista di riferimento, è lo stesso board che, attraverso un proprio “comitato nomine”, istruisce e governa un processo di ingaggio dei propri futuri membri: definisce i criteri, spesso affida l’individuazione dei possibili candidati a delle società specializzate (head hunters) e poi valuta quelli migliori in modo trasparente.
I consiglieri così selezionati sono davvero indipendenti, nel senso che non devono rappresentare degli interessi di parte; non sono espressione di qualcuno; non devono fare quello che questo qualcuno si aspetta; non devono rendere conto a nessuno – se non all’ente stesso che amministrano e alla propria coscienza professionale. Poi, se agiscono bene hanno probabilità di essere riconfermati – o viceversa.
Regole e accountability sui risultati
È chiaro che questo tipo di processo richiede un contesto adeguato, in assenza del quale il rischio dell’arbitrio e nella cooptazione mafiosa è molto alto. Servono innanzitutto regole: procedure di candidature aperte e trasparenti, criteri chiari, valutazione indipendente e, soprattutto, accountability sui risultati.
Ma, ancor più, servono due elementi fondamentali. Il primo è una cultura del servizio: chi siede in un consiglio di amministrazione agisce per il bene dell’organizzazione, non il contrario. Dobbiamo cominciare a guardare a questi ruoli come una funzione di servizio. Dobbiamo guardare al potere non come arbitrio e autorità, ma come opportunità, come possibilità di far accadere delle cose.
Watchdog credibili e principio di responsabilità
Il secondo è una cultura del controllo: non una vigilanza formale e burocratica, ma un giudizio politico sui risultati, basato su evidenze. Servono dei watchdog credibili, in grado di verificare quanto degli obiettivi dichiarati sia stato ottenuto, e come. C’è mai stato, in Italia, una valutazione seria su quanto le fondazioni hanno fatto? O, ancor più puntualmente, su quanto abbiano fatto le singole consigliature? Ce ne sarebbe un gran bisogno …
Insomma, dobbiamo sostituire il principio della rappresentanza col principio della responsabilità.
In apertura photo by Shubham Dhage on Unsplash
Vuoi accedere all'archivio di VITA?
Con un abbonamento annuale potrai sfogliare più di 50 numeri del nostro magazine, da gennaio 2020 ad oggi: ogni numero una storia sempre attuale. Oltre a tutti i contenuti extra come le newsletter tematiche, i podcast, le infografiche e gli approfondimenti.
