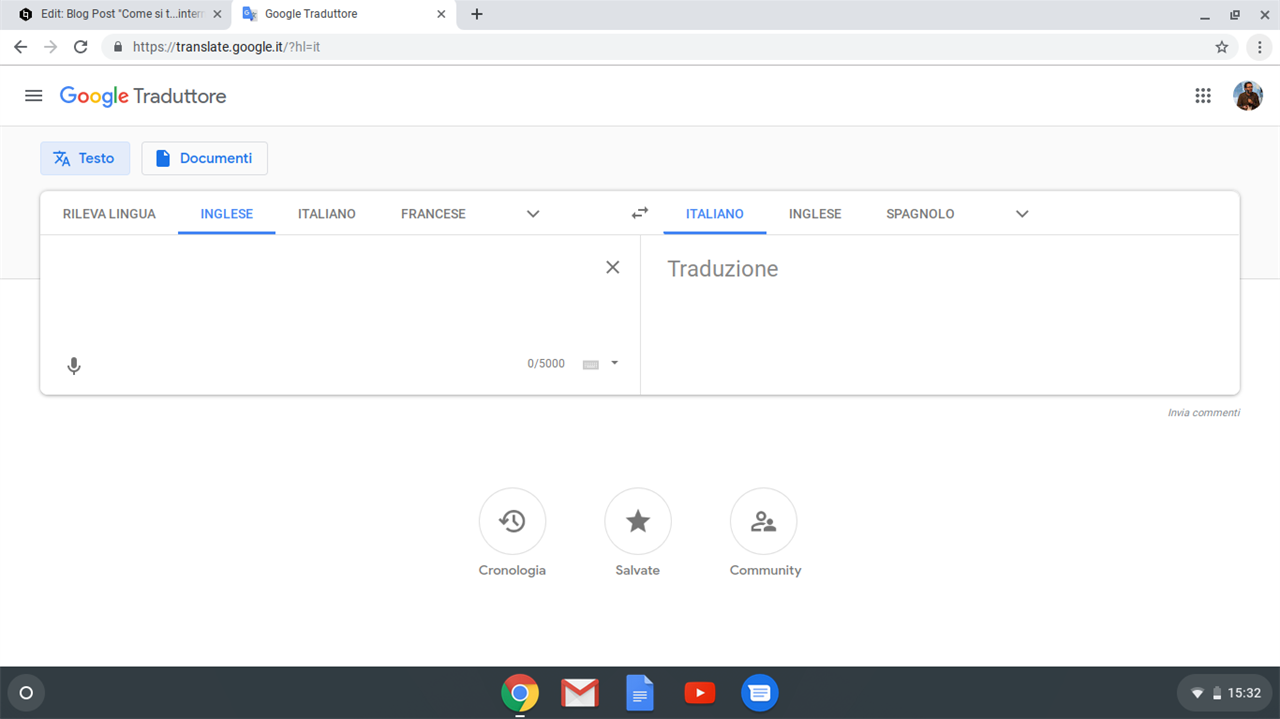L'innovazione aperta non va in vacanza. Anzi, per gli appassionati del genere può essere l'occasione per incontrarla non solo nei luoghi dove viene fatta accadere grazie a programmi di accelerazione e a risorse dedicate che solitamente si concentrano in contesti già densi di opportunità come quelli urbani generando un divario sempre più consistente con le cosiddette aree interne. Invece non è così (o non è sempre così) grazie in particolare al ruolo svolto da imprese sociali e di comunità che, come ricorda Mario Calderini, svolgono (anche) un ruolo cruciale di riequilibrio nella distribuzione e accesso a una risorsa chiave della nostra società: la conoscenza. Anche questo è "fare l'interesse generale" come recita la missione sancita dalla legge di riferimento per le imprese sociali e pare anche per le imprese di comunità grazie ad aggiustamenti normativi prossimi venturi.
Se quindi innovatori sociali urbani intossicati da eccessiva esposizione a programmi open innovation in vitro vogliono staccare e vedere all'opera quel che succede in contesti che potremmo definire più naturali (a livello di ambiente ma soprattutto di infrastrutture e relazioni) non hanno che l'imbarazzo della scelta. Un bel contesto di innovazione aperta – verrebbe da dire rurale ma il termine è fuorviante – si trova ad esempio nelle valli Trompia e Sabbia grazie al progetto Valli Resilienti e a change maker dotati di "forza tranquilla" come Claudia Pedercini. Ma un altro sta prendendo forma in Trentino precisamente nelle valli Giudicare grazie alla cooperativa di comunità Fuoco e al suo agitatore Luca Riccadonna.
A ben vedere gli ingredienti del'innovazione aperta ci sono tutti; la differenza, come spesso capita, sta nel manico: dosaggio e amalgama.
C’è un meccanismo sofisticato di scouting delle risorse che in questo caso sono malghe spesso gestite da usi civici o altre organizzazioni comunitarie. Risorse particolari quindi, perché sono beni comuni e non semplicemente “asset dormienti”. Richiedono quindi molta attenzione non tanto per essere rilevati ma piuttosto per essere riattivati o rigenerati. E’ interessante in tal senso la modalità di mappatura utilizzata. Se fossimo in un contesto urbano si tratterebbe di attivisti spalleggiati da community organizer e operatori culturali che approcciano le risorse di quartiere secondo il classico approccio ABCD: Asset Based Community Development. Qui invece a svolgere questo ruolo di “dissodamento” del terreno per svelarne la ricchezza in termini di opportunità è nientemeno che un gruppo di runners che, letteralmente, percorre il territorio con un approccio da performance, sportiva in questo caso, con l'obiettivo di evidenziare l’esistenza di infrastrutture ormai così parte integrante del tessuto paesaggistico e sociale da precludere il riconoscimento del loro potenziale di sviluppo e rimanendo così allo stato di economie marginali o di reliquie del passato.
Segue poi una fase che potremmo definire di incubazione volta a individuare e testare nuove forme d’uso degli immobili. E’ forse l’azione a più elevato tasso di rischio non solo imprenditoriale ma anche reputazionale. A essere messa in gioco infatti non è solo la bontà dell’idea e la solidità del suo business plan ma anche la tenuta di legami fiduciari rispetto ai quali basta poco perché network aperti con capacità di allargare le connessioni (bridging) rinculino a chiusi (bonding) stoppando sul nascere opportunità di cambiamento e di crescita che dopo fallimenti relazionali di questa portata potrebbero impiegare anni prima di poter ripartire.
E infine, dopo il test viene la famigerata messa a regime dell'innovazione attraverso un modello di piattaforma, ovvero abilitando nuovi soggetti gestori degli asset rigenerati andandoli a pescare non solo tra competenze “indigene” ma anche attraendo e includendo soggetti esterni. Un meccanismo peraltro sempre più praticato nei fatti, guardando a quanti rifugi, malghe, ristoranti, agriturismi, imprese agricole ecc. sono oggi gestite da “alieni” (soggetti che fanno la scelta consapevole di abitare un territorio di cui non sono nativi) e da “ritornanti” (ex abitanti che dopo esperienze in altri contesti decidono di tornare a casa ben sapendo di non essere più quelli di prima). Anche questo è un meccanismo davvero complicato e sfidante perché richiede di gestire processi che gli esperti chiamano di capacity building attraverso i quali favorire il matching tra risorse locali e capacità / aspirazioni anche a fini di replicabilità.

Tutto molto bello. E con la classica domanda finale: come si regge questa architettura sapendo che a costruirla non è una fondazione o un’amministrazione pubblica ma un’impresa? Un’impresa molto particolare perché sceglie di non internalizzare i processi produttivi, ma di creare le condizioni affinché tutto ciò che attiva dopo essere stato accompagnato possa proseguire sulle proprie gambe andando (più) velocemente a regime sia in termini di break even economico che d’impatto sociale. In sintesi quello che per le aziende normali (anche sociali) sono esternalità o "economie ulteriori" da collocare ai margini, per questa nuova generazione di imprese comunitarie diventa core-business.
In termini organizzativi questa conformazione da agenzia o hub è leggera e quindi non corre il rischio di ingolfarsi trasformandosi in una specie di multiutility locale che si occupa di tutto e di niente, con molti costi fissi ed esposta al controllo della politica. D’altro canto la stessa leggerezza rischia di essere insostenibile perché non è semplice drenare risorse sufficienti per finanziare l'azione attivazione comunitaria che fa da innesco.
Un bel dilemma che può essere risolto attraverso un mix di risorse che sono un po’ dello Stato, un po’ del mercato e un po’ del nonprofit. Da una parte potrebbe esserci una quota di risorse redistribuite che riconosce il valore pubblico di questa operazione in quanto essa genera, in ogni caso, coesione sociale quasi a prescindere dagli esiti in termini di business. Un’altra quota parte di risorse può venire da una componente donativa legata, ad esempio, al riuso degli immobili concessi dai proprietari attraverso affidamenti che non massimizzano l’interesse economico (ad esempio assumento una prospettiva di lungo periodo e adottando prezzi calmierati). Infine si potrebbe pensare a una sorta di “ritorno sugli investimenti” delle strutture rigenerate un po’ come succede con i finanziatori di tipo venture che si assumono, assieme ai promotori, il rischio d’impresa. Una percentuale dell'utile che viene redistribuita per remunerare il capitale economico e soprattutto fiduciario aggregato e investito in intraprese private e pure for profit ma dove è ben visibile l'interesse collettivo.
Non è semplice, soprattutto in termini di governance come dimostrano le alterne vicende dei commons, ma è fattibile nella misura in cui si può contare anche su inediti quadri di policy. Come avviene nel caso di Fuoco che sviluppa questa sua iniziativa in un contesto davvero particolare ovvero la biosfera Mab Unesco Alpi Ledrensi e Judicaria. Una sorta di certificazione della qualità ambientale e sociale che nel suo insieme si potrebbe configurare come un ecosistema a supporto. Ben più di un esperimento quindi. E che contiene molteplici elementi di apprendimento per tutti quei soggetti – imprese, istituzioni, soggetti sociali, cittadini – che hanno davvero voglia di fare cambiamento governando il principale elemento di valore della nostra società: l'apertura.
Vuoi accedere all'archivio di VITA?
Con un abbonamento annuale potrai sfogliare più di 50 numeri del nostro magazine, da gennaio 2020 ad oggi: ogni numero una storia sempre attuale. Oltre a tutti i contenuti extra come le newsletter tematiche, i podcast, le infografiche e gli approfondimenti.