Economia
Arriva il quarto settore? Bene, ma non bastano le parole
Paolo Iabichino, uno dei più importanti direttori creativi in Italia, interviene sulla scia di un articolo del professor Mario Calderini che ha individuato il futuro dell'economia post Covid nel "quarto settore". Una posizione nata dalla notizia dell'impegno per la purpose-first economy di 14 top manager. «Il rischio da evitare è che resti una grande dichiarazione di intenti. Ora serve agire»

Un documento sottoscritto da 14 top manager di grandi imprese internazionali, tra cui Philips, Danone, L'Oréal e MasterCard, con cui annunciano il proprio impegno per la purpose-first economy, cioè per un'economia che mette lo scopo al primo posto. È da questa notizia che prende le mosse la provocazione di Mario Calderini, lanciata su La Repubblica, in cui il professore del Politecnico di Milano, a capo del gruppo di studio Tiresia, spiega che per uscire dalla crisi post Covid, «la ricetta non potrà essere il fare cose apparentemente nuove con modelli vecchi ma scommettere su un ripensamento radicale della propria natura e identità di agente economico». A raccogliere la provocazione Paolo Iabichino, noto come Iabicus, direttore creativo ex Cco di Ogilvy Italia, miglior comunicatore dell’anno 2018 e maestro alla Scuola Holden di Baricco, che ha recentemente firmato la prefazione all'ultimo lavoro di Philip Kotler, scritto a quattro mani con Christian Sarkar, “Brand Activism – Dal purpose all'azione”, in uscita a settembre per Hoepli.
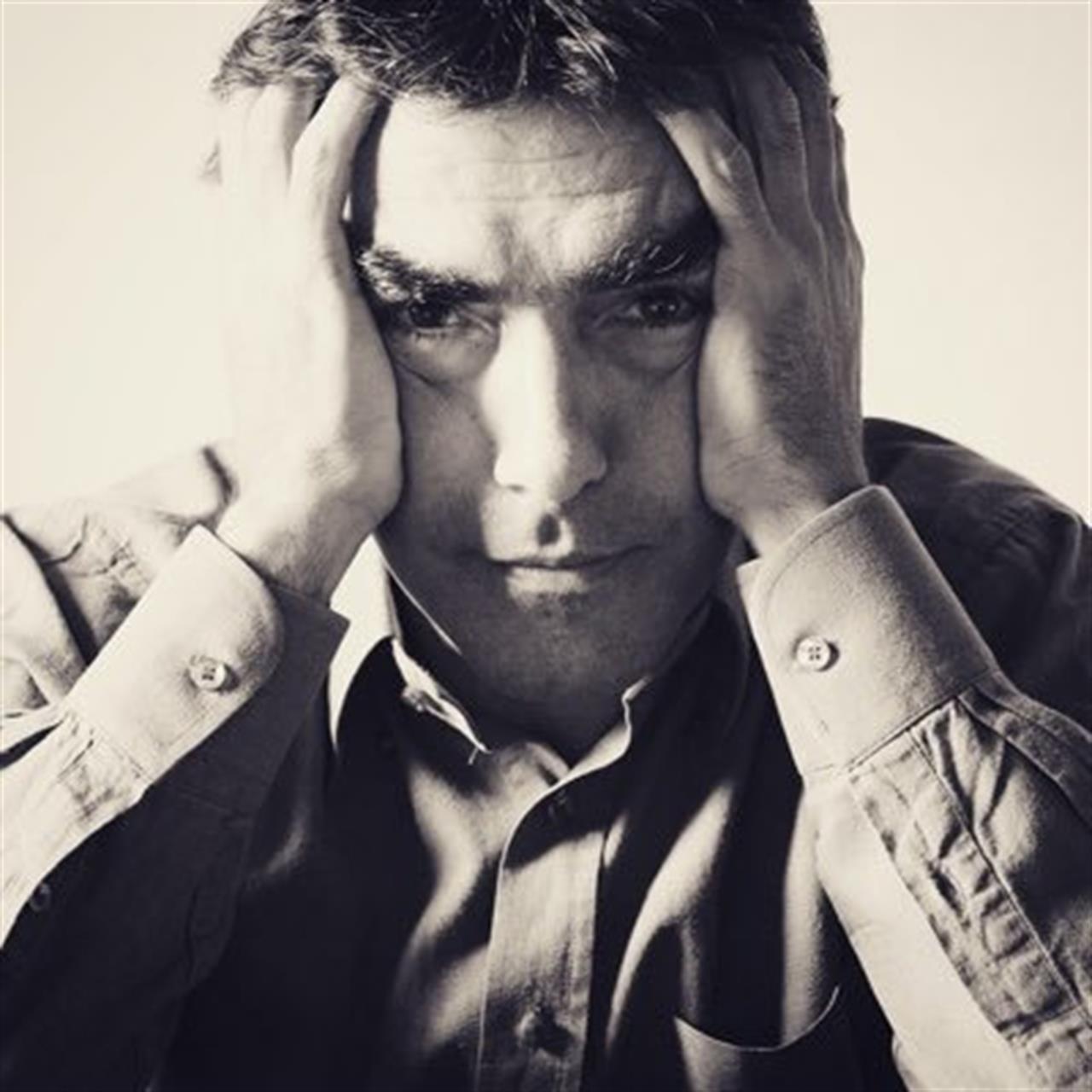
Mario Calderini definisce “quarto settore” quello spazio tra impresa tradizionale, terzo settore, Stato e innovazione sociale…
Ho trovato molto interessante e condivisibile l'articolo del professore. L'unica cosa che non mi ha convinto è proprio questa definizione. Dal punto di vista semantico chiamare quarto settore questo tipo di approccio è un po' come tradire il Terzo settore, che è sempre stato portatore di certi valori e istanze. Si genera un'idea di superamento che non mi piace. È come se questi temi non più in mano al mondo non profit o dell'impresa sociale venissero delegati al mondo imprenditoriale. L'idea di quarto settore la trovo ingenerosa rispetto al terzo settore insomma.
Al di là delle questioni semantiche però sembra davvero che la crisi dovuta alla pandemia di Covid19 stia spingendo gli attori economici e ricostruire un'economia migliore. È così?
Sì, non c'è dubbio che la crisi sia stata un acceleratore. Ha dato un impulso ulteriore a istanze che però erano ben presenti nelle agende macroeconomiche da prima. La vera questione di una purpose-first economy, almeno per chi come me la vede con gli occhi di chi scrive pubblicità e quindi è attivato ormai da anni su queste tematiche, è che ci sia il rischio che queste prese di posizione, come la lettera di Blackrock, restino tutte grandi dichiarazioni di intenti.
È per questo che ha fondato con Ipsos Italia l'osservatorio “Civic brands”?
Esattamente. Perché non basta una dichiarazione di intenti ma servono azioni. Quello che facciamo è monitorare con una ricerca periodica cosa realmente succede nel mercato italiano per quello che riguarda l'impatto sociale delle aziende. Un modo per fugare il dubbio che parlare di purpose sia soltanto scrivere manifesti. Sia chiaro non ho nulla contro i manifesti. Anche io con i miei studenti della scuola Holden ne ho scritto uno. Ma, come dicevo, servono più che mai azioni.
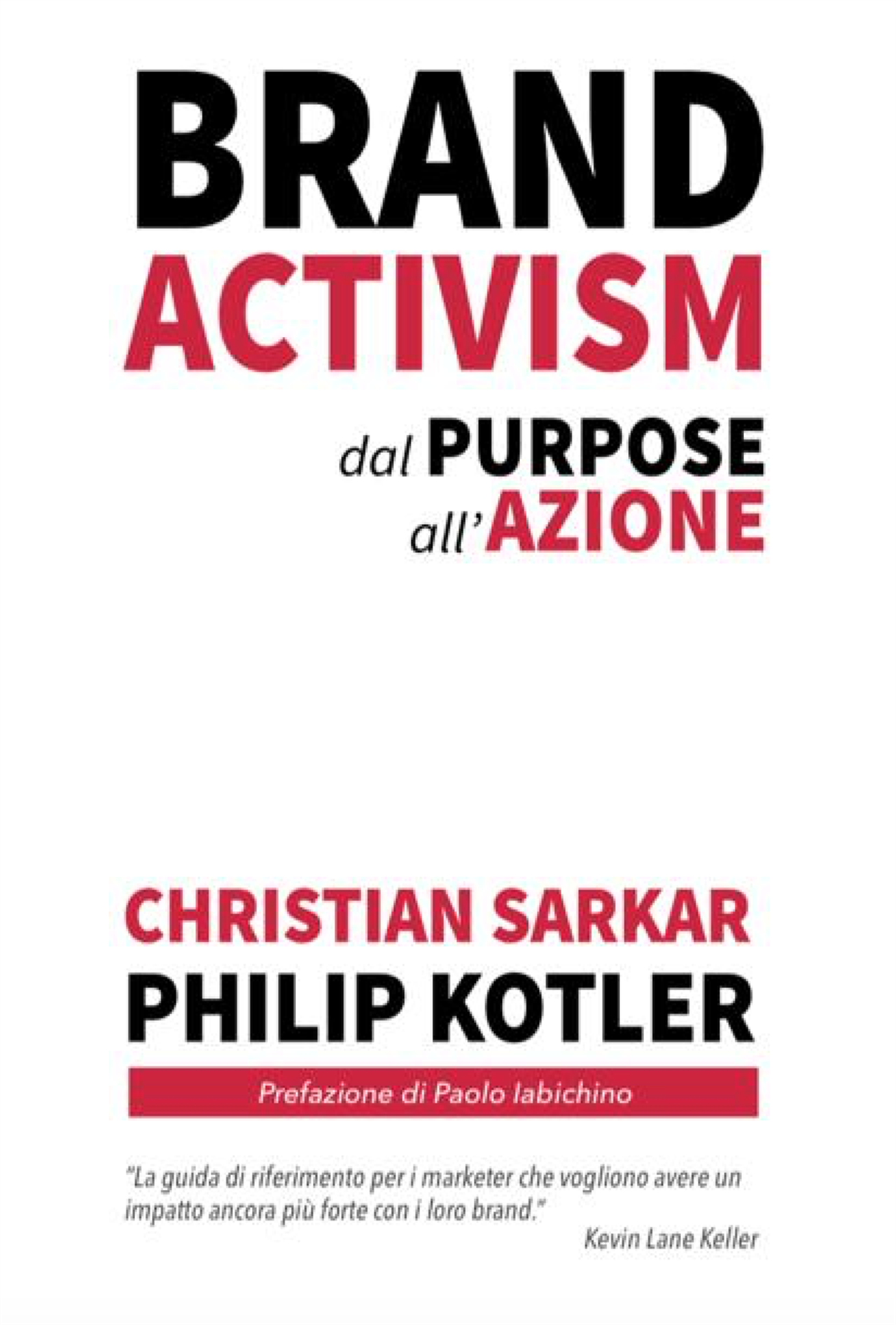
Un tema quello dell'agire concreto su questi temi che le sta molto a cuore. Tanto da vederla firmare la prefazione dell'ultima fatica di Philip Kotler, considerato il padre del marketing moderno, che si intitola proprio “Brand Activism – Dal purpose all'azione” in uscita a settembre in Italia…
Sì, il che dimostra come questi temi siano sul tavolo negli ultimi anni. Almeno da quando si è cominciato a parlare di brand activism, quindi si sono visti marchi come Nike o Patagonia comunicare e far diventare certi proclami anche un modo di stare sul mercato. Vedere molte aziende schierarsi durante un SuperBowl contro certe scelte politiche da questo punto di vista è stato rivoluzionario. Lo stesso è successo con “MeToo” e “Black Lives Matter”. Il mondo produttivo si è sentito obbligato a dover considerare, come scrive proprio Kotler nel libro, «il costo del silenzio». Tutto questo in qualche modo testimonia di tensioni culturali che sono precedenti la pandemia. Il Covid le ha rese mainstream.
Ha portato due esempi di brand activism che però sono molto lontani. Se per Nike si tratta di una questione legata alla comunicazione per Patagonia tutto questo è in qualche modo declinato nella produzione. Stando sempre al tema dell'agire il brand activism inteso esclusivamente in chiave comunicativa non è ancora troppo poco?
Non c'è dubbio. Oggi lo storytelling o le attività spot, magari emergenziali, non bastano più. Il confine in questo momento è proprio tra il dire e il fare. Oggi la dichiarazione di valore non è più sufficiente. Credo che da questo punto di vista ci sia stato uno switch importante con la crisi: queste tematiche afferivano a sensibilità di target e si pensava che il purpose fosse un'invenzione straordinaria per aggredire la generazione zeta e i millenials e per questo tutti ci si sono fiondati. La lezione della pandemia è che queste tematiche non appartengono a cluster di target ma sono universali, rilevanti per tutti. Naturalmente non tutte le aziende sono titolate a farlo. Ci sono realtà che hanno nel proprio heritage un certo modo di fare mercato e altre che invece lo fanno in maniera formale ma che o agiscono anche a livello sostanziale o saranno destinate a essere messe in discussione.
Non c'è quindi il rischio che tutto si risolva in una grande operazione di marketing? Se tutto è quarto settore niente lo è, per stare a Calderini…
No, non è più possibile. Perché il consumatore ormai è molto attento a certe cose. L'unico rischio è nelle mani di chi decide di giocare questa partita. Le furbizie e malizie narrative vengono smascherate immediatamente. Addirittura anche l'azione oggi non è detto che sia sufficiente perché il consumatore la valuta. È il motivo per cui non compaiono mai, in questi manifesti, le grandi compagnie tech. C'è la consapevolezza che il rischio è altissimo
Ancora una volta però viene da dire che in Italia abbiamo depauperato un patrimonio ricchissimo che avevamo, se pensiamo all'economia civile, a Adriano Olvetti e Enrico Mattei…
Non è un caso che la scuola olivettiana stia tornando prepotentemente di grende attualità. Gli scritti di Stefano Zamagni lo testimoniano. Tante aziende stanno facendo un grande lavoro di recupero degli archivi, andando a riscoprire le vocazioni che erano alla base della fondazione delle imprese. Recuperare le proprie radici in un tempo come questo significa recuperare i valori fondativi di un'impresa. Che 70, 80 e 90 anni fa non avevano mai al centro il profitto. Le imprese italiane sono nate sulla spinta di ideali, sogni, passioni.
Guardando alla crisi che viviamo recuperare le proprie radici è più semplice che inventarle. Può essere un nostro vantaggio competitivo?
Assolutamente. Siamo alla prese con un bivio: o assisteremo alla fine del capitalismo o vedremo un capitalismo che muterà profondamente. Quale sarà il vestito del capitalismo di domani non lo so, non so dire se saranno i panni del quarto settore. Quello che è certo è che il modo di fare mercato che abbiamo visto fino a ieri non sono più attuali.
Nessuno ti regala niente, noi sì
Hai letto questo articolo liberamente, senza essere bloccato dopo le prime righe. Ti è piaciuto? L’hai trovato interessante e utile? Gli articoli online di VITA sono in larga parte accessibili gratuitamente. Ci teniamo sia così per sempre, perché l’informazione è un diritto di tutti. E possiamo farlo grazie al supporto di chi si abbona.
