Welfare
Angelo Righetti: «Il desiderio di esclusione non diventi pratica di esclusione»
È matto perché è pericoloso ed è pericoloso perché è matto: è la grande tentazione da evitare quando si parla di salute mentale, anche decenni dopo Basaglia. Perché a quel punto non è più una questione di definire una giusta pena e una giusta riabilitazione, ma uno stigma. Righetti: «Tutti abbiamo in noi il desiderio di esclusione, di mettere le distanze fra noi e il male. Dovere di chi lavora nel welfare è far sì che il desiderio dell'esclusione non diventi pratica e poi governo dell'esclusione»
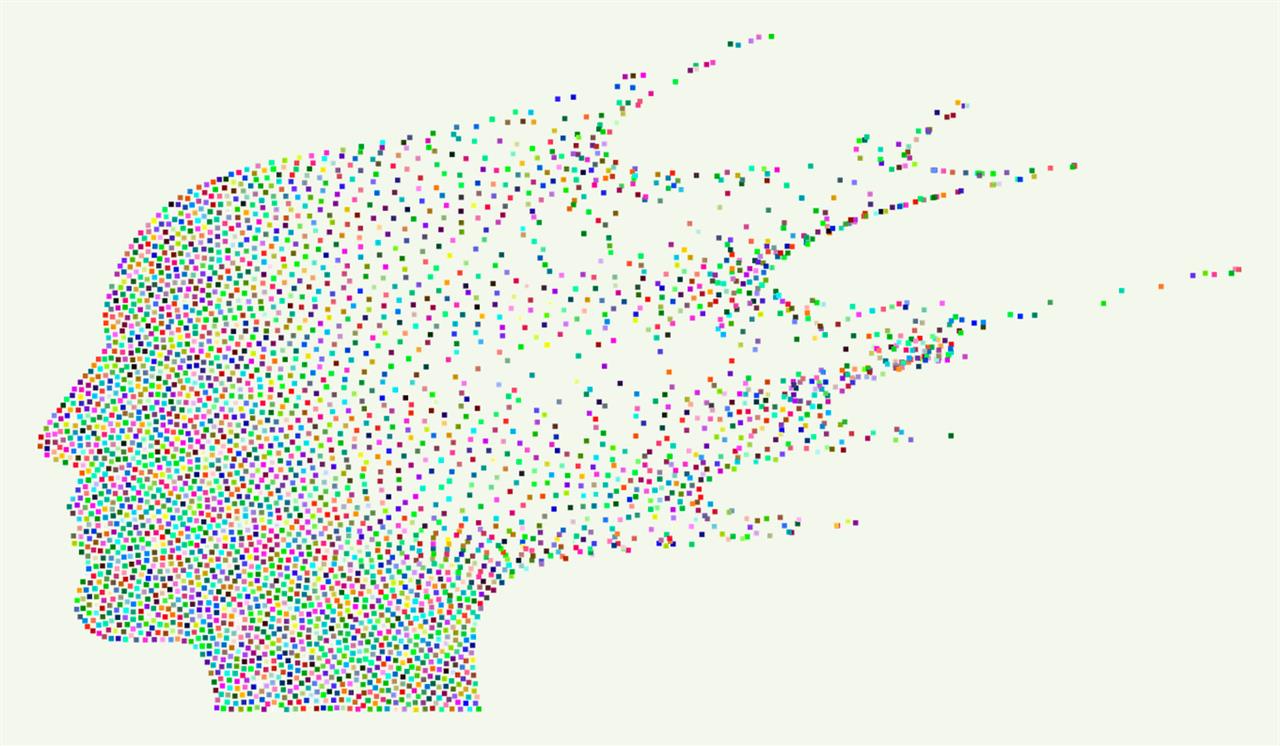
Una settantina di km, in Lombardia, separano due fatti di cronaca nera uniti dall’affacciarsi prepotente del tema del disagio psichiatrico e della salute mentale. Ci sono due persone morte uccise e le famiglie che le piangono, e dei feriti. E ci sono due uomini con storie molto diverse, ma oggi accomunate nella tragedia che li ha visti protagonisti e da un’etichetta che riaffiora: “pazzi pericolosi”. «È il “desiderio di esclusione” che tutti abbiamo», dice lo psichiatra Angelo Righetti. La sua storia è legata a Franco Basaglia e al suo «fare le cose, un passo dopo l’altro». Lavora sui modelli di welfare, sui budget di salute, sull'impresa sociale come strumento per l’inclusione di persone fragili. A Venezia ha rimesso in mare l’Edipo Re, l’imbarcazione che nel 1969 ospitò le riprese della Medea di Pier Paolo Pasolini, con Maria Callas, diventata il simbolo di un nuovo turismo culturale e inclusivo.
Non le chiedo un commento ai fatti di cronaca, ma alla reazione dell’opinione pubblica, che ancora una volta sembra “ammettere” la sofferenza psichiatrica e la malattia mentale solo dinanzi a episodi così gravi. E la reazione è ancora, sostanzialmente, “sono matti, rinchiudiamoli e buttiamo la chiave”.
La ragione di questa reazione è semplice ed è che tutti quanti abbiamo in noi il desiderio di esclusione. È una battaglia che non finirà mai. È il vero tema che dobbiamo affrontare, soprattutto nei sistemi di welfare, nella scuola, nella sanità, nella vita di comunità e di famiglia. Dobbiamo fare i conti con il desiderio di esclusione e dobbiamo farlo dando a noi stessi la possibilità di includere ma insieme di punire i reati. Perché la nostra Costituzione meravigliosa ci ha insegnato che chi merita una pena, al contempo merita anche una possibilità riabilitativa.
Che cos’è il desiderio di esclusione?
Il desiderio di potersi sentire non contaminati dal male, di poter mettere le distanze con il male. L’illusione di stabilire un’alterità. La verità è che abbiamo paura del nostro male, cioè di ciò che possiamo fare noi. Il desiderio di esclusione diventa particolarmente grave quando viene richiesto in termini professionali e si trasforma in pagamento di “secondini” che dovrebbero fare i medici o i professori e invece si limitano a tenere rinchiuse le persone. La professionalità di chi lavora nel welfare – che sia nella salute mentale o nella scuola, poco cambia – al contrario è proprio riuscire a evitare la pratica del desiderio dell'esclusione. Questo è il tema davvero importante, perché dentro il desiderio di esclusione si nasconde molto di più della semplice paura della diversità: si nasconde anche la possibilità della pratica dell’esclusione, che poi diventa governo dell'esclusione. Non ne siamo lontani, nel momento in cui immaginiamo che la nostra perfezione sia la perfezione dell’esclusione delle diversità, quando usiamo le nostra capacità, conoscenze e ricchezze per escludere gli altri. Percorrendo questa strada si arriverà a dire che le persone che commettono gravi fatti violenti sono matte, che la violenza è il segno che la follia è pericolosa di per sé e quindi che la follia va eliminata e contenuta. È matto perché è pericoloso ed è pericoloso perché è matto: capisce che a quel punto non è più una questione di definire una giusta pena e una giusta riabilitazione, è uno stigma. Di per sé dire "riapriamo i manicomi” è una barzelletta… nessuno è in grado di sostenere una cosa del genere: però che lo si dica è un segnale pericoloso. È la guerra alla diversità.
È un po’ l’accusa che si fa sempre, anche dopo anni o persino decenni: aver chiuso i manicomi prima e gli opg dopo, senza aver adeguatamente curato i servizi alternativi sul territorio. Concretamente però qual è lo stato dei servizi di salute mentale oggi? Con il Covid forse molti percorsi sono stati interrotti e questo ha lasciato il segno.
I servizi. Da un lato stanno molto bene, perché i manicomi non esistono più, ma questo non era il punto centrale. Noi non volevamo solo chiudere i manicomi, volevamo de-istituzionalizzare la follia. Volevamo che la follia non stesse sotto l'istituto dell’esclusione. Su questa strada abbiamo fatto passi avanti, ma tanti altri passi non li abbiamo ancora fatti. I servizi – che dovrebbero fare questo – sono prevalentemente dediti alle cure somatiche, biologiche, con farmaci e ambulatori. Che sono cose importanti, ma non sono la cosa più importante. La cura invece è sempre una relazione tra persone. Una persona che ha un disturbo mentale ha un disturbo in almeno tre sfere: quella biologica, quella psicologica e quella sociale e istituzionale… Queste sfere abitano nella comunità, nelle famiglie. Quindi un intervento sulla salute mentale o dei tecnici della salute mentale che non tenga in buon conto le famiglie e la comunità… non interviene là dove i problemi si connotano. Mentre quelle sfere che dicevo sono solitamente legate alla povertà: materiale, di occasioni, di opportunità, necessità di uguaglianza, mancato sviluppo di un territorio, di case… Si deve entrare nel merito della riproduzione sociale di queste persone. Si devono dare opportunità.
Sicuramente non è facile, ma è impossibile?
In verità non è una cosa così difficile, però richiede competenze e forti investimenti: pur sempre minori, tuttavia, di quel che investivamo nei manicomi e che ancora oggi siamo disposti ad investire nella tecnica e nel governo dell'esclusione. Mentre con la metà di quel che serve per escludere le persone, potremmo farle vivere bene, aiutate e – dico di più – anche volute bene nella comunità. Alla riproduzione sociale però ci si deve dedicare in modo proattivo, bisogna costruire per esempio una domiciliarità di comunità che è un’altra cosa dalle "Case della Comunità" di cui si parla nel Pnrr: o meglio, nelle nostre speranze quella è la "centrale operativa” delle imprese sociali di una comunità, del fatto di incentivare le possibilità che le persone si aiutino fra loro, che i servizi vadano nei territori, ma si può scommettere che al più saranno dei poliambulatori. La violenza gratuita che scoppia in un supermercato, non ci sarebbe stata se avessimo tenuto in attenzione non solo la persona ma tutta la sua famiglia, andandole a intercettare. Non lo dico perché sono un sognatore ma perché avendo accompagnato tanti territori al superamento dei manicomi mi sono accorto che in quel territorio aumentava anche il livello di solidarietà, diminuivano i reati, aumentavano le occasioni di lavoro. L’integrazione è un grande dono alle persone fragili, certo, ma anche alle comunità.
Si può usare la Carta docente per abbonarsi a VITA?
Certo che sì! Basta emettere un buono sulla piattaforma del ministero del valore dell’abbonamento che si intende acquistare (1 anno carta + digital a 80€ o 1 anno digital a 60€) e inviarci il codice del buono a abbonamenti@vita.it
