Cultura
L’ultimo saluto a Gabriel García Márquez
Si è spento a Città del Messico uno dei più grandi scrittori del XX secolo. Giornalista coraggioso e narratore impareggiabile, Premio Nobel nel 1982, controverso amico di Fidel Castro, "Gabo" è stato autore di romanzi senza tempo, come "Cent'anni di solitudine" e "L'amore ai tempi del colera".
di Marco Dotti

«La vita non è quella che si è vissuta, ma quella che si ricorda. E come la si ricorda, per raccontarla». La vedeva così, Gabriel Garcia Márquez, tra i più grandi scrittori di sempre, ultimo esponente della grande corrente del realismo magico, Premio Nobel per la Letteratura nel 1982.
Nato in Colombia, a Aracataca, un paesino divenuto celebre grazie alle sue trasfigurazioni romanzesche, Gabo – così era universalmente conosciuto – inizò a scrivere nel 1948 sulle pagine di "El Universal". Poi, la scoperta dell'Europa, l'iscrizione al Centro Sperimentare di Cinematografia di Roma, la vita a Parigi, nel 1958 il ritorno nelle Americhe e infine la Cuba della Rivoluzione e il Messico, dove si è spento il 17 aprile, all'età di ottantasette anni. Questa la geografia minima di uno scrittore che, per tutti, rimarrà di casa sempre e soltanto a Macondo, il paese immaginario al centro del romanzo che nel 1967 lo rese noto al grande pubblico, Cent'anni di solitudine.
Quando, giovanissimo, confessò a suo padre che avrebbe voluto fare lo scrittore, il padre gli rispose: "mangerai carta". Un grande poeta e scrittore, Luis Cardoza y Aragón, scriveva però che «la poesia è l'unica prova concreta dell'esistenza dell'uomo» e se mangiar carta ne era il prezzo, Gabo dovette pensare che non era poi troppo alto.
Gabriel Garcia Márquez faceva parte di una generazione che, comunque agisse e ovunque scrivesse – su un giornale, un taccuino, in un libro – prendeva terribilmente alla lettera quelle parole: «per noi le parole dei poeti erano più rilevanti delle notizie politiche sempre più deprimenti».
Il 22 ottobre del 1982, sulle pagine del Corriere della Sera, Carlo Bo scriveva: «Tutta la storia e possiamo dire tutta la poetica di Gabriel García Márquez sta negli anni della sua infanzia trascorsa in un paese della Colombia, un paese di piantagioni di banane, Aracataca. Il paesaggio, la figura della nonna, i racconti delle donne che giravano per casa, si direbbe che lo scrittore non abbia fatto altro che interrogare quel passato e speculare sulle origini di quello che i suoi critici chiamano “realismo magico”. (…) Su questo fondo eterno si sono naturalmente inseriti gli altri motivi che, volta per volta, l’esistenza gli avrebbe fornito o imposto: lo spettacolo della miseria, le ribellioni della sua gente sottoposta a regimi di sfruttamento, il bisogno di rendere testimonianza di quanto vedeva crescere intorno a sé La cronaca dei suoi giorni, dei viaggi, dei suoi lunghi soggiorni all’estero non è che la conseguenza di questa sua inquietudine civile e politica che peraltro egli riesce benissimo a saldare con quel suo primo mondo poetico impastato più di mito che di realtà, bagnato e in qualche modo irrobustito da un’autentica passione sociale».
Resta tra i più celebri di tutta la storia della letteratura uniersale l'incipit di Cien años de soledad: «Molti anni dopo, di fronte al plotone di esecuzione, il colonnello Aureliano Buendía si sarebbe ricordato di quel remoto pomeriggio in cui suo padre lo aveva condotto a conoscere il ghiaccio. Macondo era allora un villaggio di venti case di argilla e di canna selvatica costruito sulla riva di un fiume dalle acque diafane che rovinavano per un letto di pietre levigate, bianche ed enormi come uova preistoriche. Il mondo era così recente, che molte cose erano prive di nome, e per citarle bisognava indicarle col dito».
Molti anni prima, nel 1968, sempre sulle pagine del Corriere della Sera, recensendo proprio Cent'anni di solitudine Mario Luzi aveva parlato di «fedeltà alla vita» dello scrittore colombiano: «Macondo è il suo centro, i fasti e i nefasti della famifglia Buendia la sua iperbolica, reale e fantastica sostanza. Un destino appunto di solitudine lega gli uomini e le donne di questa prolifera ceppata al paese che, nato con loro, è destinato a sparire dopo aver conosciuto la felicità dei pionieri, la mortificazione della legge, la tragicommedia della guerra civile, l’insidiosa prosperità della colonizzazione bananiera e molte altre calamità di cui è difficile stabilire l’ordine – se naturale o metafisico – come una pioggia durata quasi cinque anni o un’epidemia d’insonnia che toglie la memoria. Márquez confessa di aver trovato un maestro in Faulkner e un esempio nel suo microcosmo di Yoknapatawpha e confessa anche il fascino subito dalla Peste di Camus. Due indicazioni che, a rigore, potrebbero rimanere esterne se si considerano la sua felicità e la sua euforia narrativa, sintomi certi della congenialità radicale della materia e dei modi stilistici strettamente conformi che le danno movimento e respiro – un respiro alterno di realtà e di leggenda.Ma possono essere indicazioni utili per conoscere la natura dell’artista che in atto è così occupato dalla “simpatia” con gli uomini, gli eventi, i tempi e con il compito di raccontarli da nascondere ogni retroterra problematico».
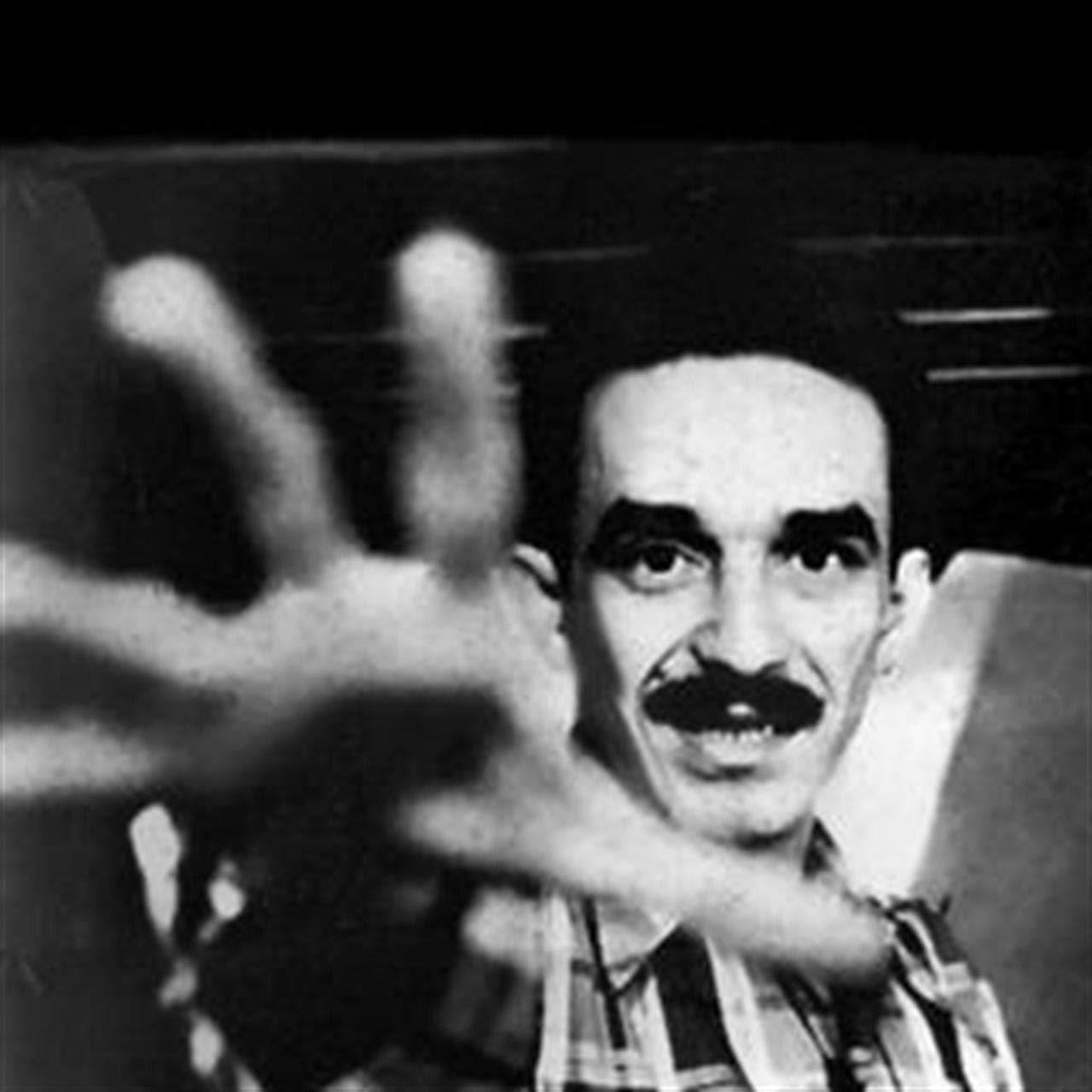
Il tragico e allucinato naturalismo di Faulkner, l’allegoria di Camus – proseguiva Luzi – «dicono infatti qualcosa delle esigenze che lo scrittore vuole soddisfatte dalla sua creazione letteraria: e che potrebbero definirsi di fedeltà al senso della vita, della profonda realtà nazionale, e di più vasta significazione simbolica. In Cent’anni di solitudine la potenza di metafora che hanno alcuni episodi e poi la vicenda nel suo insieme è evidente. Lo spreco di ambizioni, di energia, di desideri dell’uomo continuamente respinto dalle promesse della storia all’inerzia della natura e al farnetico della solitudine può essere un simbolo latino-americano e valere in assoluto come risposta fondamentale all’interrogativo che ogni poeta si pone sulla sorte dell’uomo».
@oilforbook
Cosa fa VITA?
Da 30 anni VITA è la testata di riferimento dell’innovazione sociale, dell’attivismo civico e del Terzo settore. Siamo un’impresa sociale senza scopo di lucro: raccontiamo storie, promuoviamo campagne, interpelliamo le imprese, la politica e le istituzioni per promuovere i valori dell’interesse generale e del bene comune. Se riusciamo a farlo è grazie a chi decide di sostenerci.
