La ricerca
L’irresistibile fascino dei complotti
Perché tutti (o quasi) credono ad almeno una teoria cospirazionista? Il saggio degli scienziati sociali americani Joseph E. Uscinsky e Adam M. Enders, appena uscito in Italia per i tipi di Franco Angeli, è un incubatore di domande e interessanti analisi. Spazza via equivoci, false evidenze e luoghi comuni sui complotti e su coloro che vi credono

Una crociera a tema, dedicata ai complotti e alla guarigione da cospirazioni ordite ai danni dei partecipanti. Non è uno scherzo, è una proposta che risale al 2016, di cui scrissero diverse testate internazionali. A subire il fascino delle teorie cospirazioniste non è una minoranza: i sondaggi dicono che tutti (o quasi) gli abitanti di questo pianeta crede ad almeno una congettura del complotto. Sulle possibili cause di ordine psicologico, sociale e politico che ci portano a diffonderle, due scienziati americani, Joseph E. Uscinski e Adam M. Enders, che si occupano di Scienze politiche rispettivamente alle università di Miami e Louisville, hanno scritto a quattro mani un saggio, Le teorie cospirazioniste – Un’introduzione, uscito in Italia per i tipi di Franco Angeli. Un interessante excursus su ciò che accade nella testa di chi teorizza complotti. Nulla di troppo lontano da chiunque si muova nella società contemporanea: siamo tutti coinvolti, nessuno escluso. Il perché lo abbiamo chiesto ai due ricercatori.
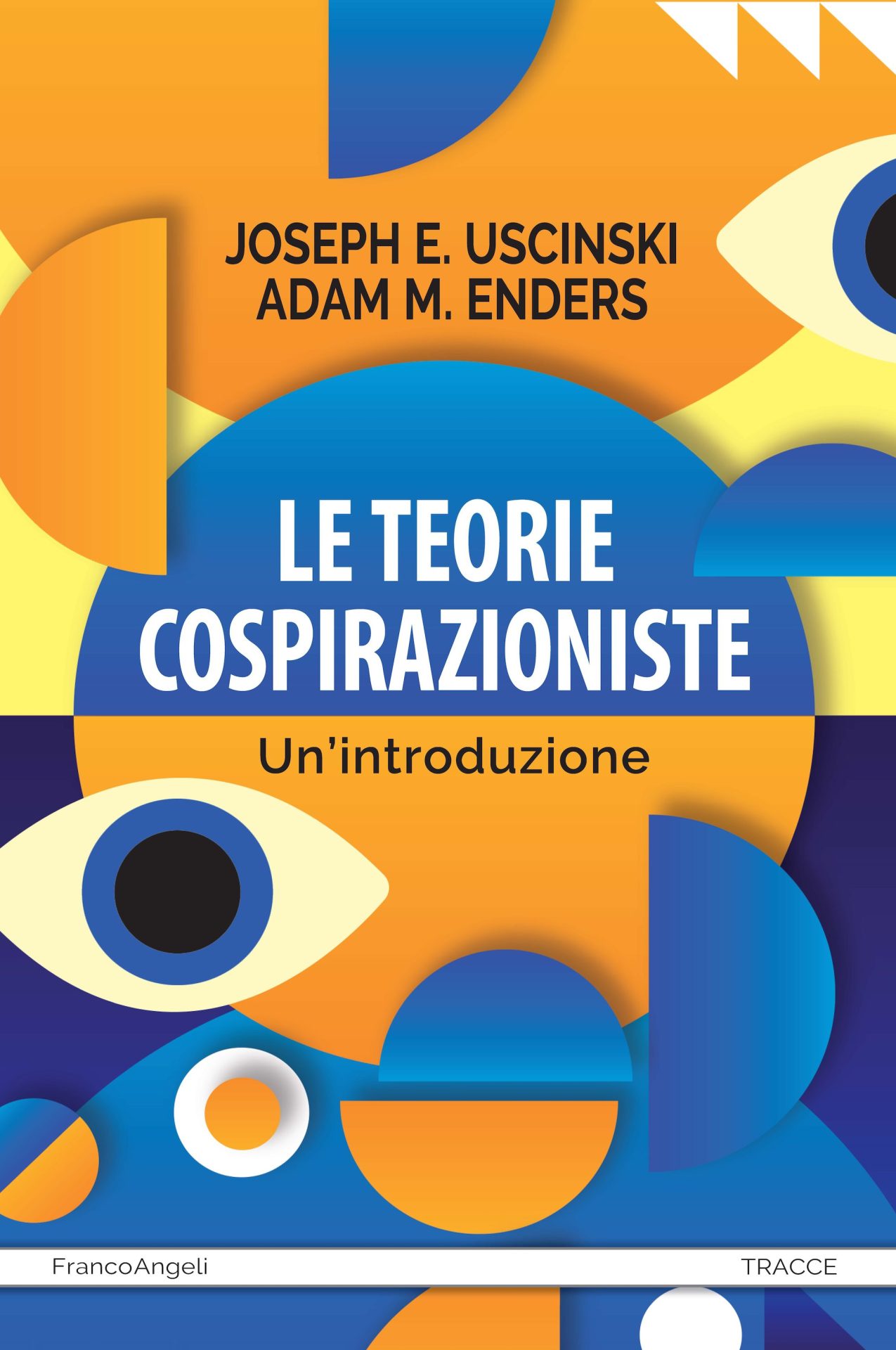
Nell’introduzione al volume, c’è un’avvertenza per chi si accinge a leggere: «Alcune tesi di questo libro possono apparire polemiche, ma non è una scelta intenzionale: è semplicemente inevitabile. […] le teorie cospirazioniste hanno a che fare con la verità e con il potere, e ciò le rende controverse». C’è un legame tra verità, potere e manipolazione delle informazioni?
Sì, esiste. Quando le persone sentono l’espressione “teoria della cospirazione” tendono a supporre che l’idea a cui fa riferimento sia falsa o non supportata. L’etichetta di teoria del complotto porta con sé un bagaglio epistemologico. Questo farà arrabbiare qualcuno: quando le idee in cui credi vengono definite “teorie della cospirazione”, l’ipotesi naturale è che le tue convinzioni siano accusate di essere false. E poiché le teorie della cospirazione vengono usate per spiegare i comportamenti dei politici e delle élite culturali, o gli esiti delle politiche pubbliche, sfidano intrinsecamente il potere mettendo in discussione la verità e le intenzioni. Le persone al potere a volte usano quel potere per manipolare l’informazione, ma al di là di questo, in generale gli esseri umani sono in disaccordo su ciò che è vero. Praticano diverse fedi, hanno opinioni diverse sul bene e sul male e hanno valori diversi: questo porta inevitabilmente a vedere la verità in modo diverso.

Piani, astuzie, personaggi orribili e vittime con cui è difficile non simpatizzare. Come nasce un complotto?
Le teorie della cospirazione nascono in molti modi. A volte le persone le inventano, altre volte le sentono da amici o alla tv, o ancora le intercettano sui social media.
Dalla pandemia da Covid-19, l’esempio forse più emblematico durante il quale si diffusero credenze sganciate da prove scientifiche o conoscenze di esperti, ai presunti brogli durante le elezioni presidenziali americane del 2020. Dai “terrapiattisti” al cosiddetto “Pizzagate” secondo il quale alcuni esponenti democratici, tra i quali Hillary Clinton, avrebbero gestito nel seminterrato di una pizzeria un traffico sessuale di bambini. C’è un ambito più fertile alle cospirazioni di altri? Esiste un argomento immune al complotto?
La gente tende a credere alle teorie del complotto che accusano gruppi di cui non fanno parte. Alle persone piace accusare “gli altri”: per esempio, i repubblicani accusano i democratici di cospirazione e viceversa. Credere nelle teorie della cospirazione è qualcosa che riguarda soprattutto le caratteristiche di chi crede. Le persone che sospettano dell’autorità, diffidano del governo e di chi considerano altro da sè, che mostrano livelli relativamente alti di insensibilità alle regole, narcisismo e sentimenti populisti per citarne alcuni, sono tutte più propense a credere nelle teorie della cospirazione. È anche logico che il contesto ambientale in grado di attivare o “innescare” una simile predisposizione possa anche alimentare le fiamme del cospirazionismo. Le campagne elettorali calde, soprattutto in un periodo di polarizzazione politica senza precedenti, incoraggiano gli individui a essere particolarmente sospettosi nei confronti dei gruppi esterni (ad esempio i partiti politici con cui non si identificano) e a proteggere la propria identità, rendendo così le teorie della cospirazione più attraenti del solito.
Le persone che sospettano dell’autorità, diffidano del governo e di chi considerano altro da sè, che mostrano livelli relativamente alti di insensibilità alle regole, narcisismo e sentimenti populisti, sono tutte più propense a credere nelle teorie della cospirazione
Joseph E. Uscinski e Adam M. Enders, scienziati sociali americani
Le teorie cospirazioniste contribuiscono a inquinare il nostro ambiente relazionale e tendono a polarizzare il dibattito. Perché?
Perché di solito vengono usate contro gruppi “altri”. Non c’è niente di male nel complotto in sé: le teorie cospirazioniste potrebbero potenzialmente aiutare a smascherare errori. Da teorie cospirazioniste possono diventare vere e proprie “cospirazioni” quando vengono prodotte prove che dimostrano che un individuo o un piccolo gruppo sta, di fatto, lavorando in segreto per il proprio interesse, violando norme, leggi o ostacolando il bene comune. Tuttavia, nel panorama politico contemporaneo le teorie della cospirazione tendono a essere usate come metodo per mettere in discussione la verità e le intenzioni di gruppi e posizioni avversarie. Sono probabilmente più la conseguenza della polarizzazione che la causa. È difficile negoziare con gli altri se si crede che gli altri stiano cercando segretamente di uccidervi.
Che cosa determina il successo di un complotto piuttosto che un altro?
Le teorie della cospirazione convincono più persone quando accusano i grandi cattivi che tutti conoscono e non amano. Per esempio, le teorie che riguardano i ricchi, i partiti politici, le grandi banche di solito hanno successo.

Nel volume sottolineate più volte che non c’è mai stata, in tutta la storia umana, un’epoca in cui non fossero diffuse idee pseudoscientifiche, paranormali, sovrannaturali o criptozoologiche. Oggi le teorie cospirazioniste sono più popolari rispetto al passato?
Dipende da cosa si intende con “popolare”. Possiamo probabilmente concordare sul fatto che l’argomento generale delle teorie del complotto è più interessante per i giornalisti e i ricercatori oggi di quanto lo fosse 20 o 50 anni fa. Tuttavia, non troviamo prove che dimostrino che le persone siano più cospirative oggi di quanto lo fossero in passato. Infatti, esaminando la percentuale di individui che credono a decine di teorie del complotto (anche prima dell’avvento di Internet o dei social media), troviamo che il numero di “seguaci” tende a diminuire o a rimanere relativamente stabile a seconda della teoria analizzata. Le teorie della cospirazione non sono più popolari oggi rispetto ad altre epoche.
La metafora del vaccino che i ricercatori spesso usano per parlare di disinformazione è fondamentalmente difettosa. La realtà è che la verità è difficile da decifrare e spesso sfumata. Le teorie della cospirazione fanno parte della condizione umana e non saranno sradicate così facilmente
Joseph E. Uscinski e Adam M. Enders, scienziati sociali americani
Esiste un vaccino per renderci più forti di fronte al complottismo?
In una parola, no. La metafora del vaccino che i ricercatori spesso usano per parlare di disinformazione è fondamentalmente difettosa. Si presume che le persone possano essere magicamente spinte a distinguere ciò che è vero da ciò che è falso attraverso una formazione capillare sulla disinformazione, l’alfabetizzazione mediatica o il pre-bunking. La realtà è che la verità è difficile da decifrare e spesso sfumata, e nessuna formazione è in grado di infondere nelle persone capacità epistemiche simili a quelle di Dio per sapere cosa è vero e cosa è falso (specialmente in settori in cui non hanno alcuna competenza). Inoltre, gli esseri umani credono alle cose per almeno una ragione. Forse non “buone” ragioni (a seconda della propria interpretazione soggettiva), ma comunque ragioni. I “vaccini” che alcuni ricercatori indicano come efficaci non prendono sul serio il fatto che le teorie della cospirazione siano sostanzialmente il prodotto di orientamenti individuali stabili e fondamentali (ad esempio, visioni del mondo, ideologie, personalità), esperienze che non possono essere manipolate o cancellate o essere oggetto di interventi volti a distogliere le persone dalle proprie convinzioni. Le teorie della cospirazione fanno parte della condizione umana e non saranno sradicate così facilmente.
La fotografia in apertura è di Osama Madlom su Unsplash
17 centesimi al giorno sono troppi?
Poco più di un euro a settimana, un caffè al bar o forse meno. 60 euro l’anno per tutti i contenuti di VITA, gli articoli online senza pubblicità, i magazine, le newsletter, i podcast, le infografiche e i libri digitali. Ma soprattutto per aiutarci a raccontare il sociale con sempre maggiore forza e incisività.
