Il Papa delle carceri
Francesco, così vicino ai detenuti da sentirsi uno di loro
«Ogni volta mi chiedo perché mai io non sono lì dentro». Lo disse Francesco all'uscita dal carcere Regina Coeli di Roma. Luigi Manconi ricorda proprio questa frase: «Avvertire la tentazione del male ci turba. Rimuoviamo il carcere perché ci fa paura come una delle tragiche possibilità della nostra avventura umana»

«La novità e la grandiosità della figura di Papa Francesco è che ha saputo trovare la dimensione spirituale in questa sua attenzione per tutto ciò che costituisce la sofferenza delle persone, la loro condizione di disumanità, nel destino dei migranti, dei poveri, dei detenuti». A parlare è Luigi Manconi, già docente di Sociologia dei fenomeni politici, una vita in militanza a difesa dei diritti.
Manconi, Papa Francesco è stato sempre vicino agli ultimi, ai fragili, ai sofferenti. In particolare, alle persone detenute. Cosa ci vuole dire?
Io ricordo che qualche anno fa lui disse che, quando era a Buenos Aires, era frequentissimo il suo visitare le carceri, la sera. Così raccontò. Io non so se fosse una sorta di parabola oppure il racconto di un’esperienza reale, perché sembrava quasi eccessivo raccontare di un suo recarsi nelle carceri così frequentemente. Fatto sta che l’ha fatto spesso pure da Papa, e questo, ancora una volta, resta un’eccezionale testimonianza. Vanno ricordate per esempio le parole all’uscita da una sua visita nell’istituto Regina Coeli di Roma.
Quali parole?
«Ogni volta che vengo in carcere mi chiedo perché mai le parti non andrebbero invertite, cioè perché mai io non sono lì dentro e i detenuti non sono fuori». È una frase, come spesso quelle di Francesco, semplice, aneddotica, elementare. Però dietro c’è una saggezza fondamentale, cioè l’idea che sfugge a tanti, persino ad alcuni tra coloro che nel carcere svolgono la loro attività di volontariato, che nel carcere si interessano.
“Ogni volta che vengo in carcere mi chiedo perché mai le parti non andrebbero invertite, cioè perché mai io non sono lì dentro e i detenuti non sono fuori”: è una frase che racchiude una saggezza fondamentale, che sfugge pure a tanti che in carcere fanno volontariato
Luigi Manconi
Cosa sfugge a tanti?
Sfugge che il destino umano, la sua deperibilità, la sua precarietà sono tali che il carcere è una tragica possibilità per tutti. Non esistono i predestinati al carcere e quelli che, invece, sono predestinati a non capitarci mai dentro. Non è così, in alcun modo. La caduta, l’errore, il reato sono alla portata di tutti, a partire dal peccato originale per chi ci crede, e per chi non ci crede a partire dall’imperfezione dell’essere umano. Il nostro rapporto difficile col carcere, e la nostra tendenza a rimuoverlo, nasce proprio da questo processo che riguarda il nostro inconscio. L’idea, cioè, che in carcere ci sono coloro che hanno ucciso, violentato, rubato, rapinato, usato violenza, ingannato. E l’idea inconscia che anche noi siamo stati (o siamo o saremo) tentati da quello, cioè dall’uccidere, dal rubare, dal rapinare, dal violentare, dall’ingannare.

Se non cediamo a quella tentazione, e quindi siamo fuori e non dentro, è perché è successo qualcosa, cioè una buona educazione, oppure un innamoramento che ci ha portato lontano da quella tentazione, o delle buone relazioni oppure una vita sociale piena. Avvertire nel nostro inconscio che la tentazione del male esiste anche per noi, ci turba. Anzi, come direbbe Freud ci «perturba». E questo ci porta a rimuovere il carcere, perché in sostanza ci fa paura come una delle tragiche possibilità della nostra avventura umana.
Cosa la colpisce della pastorale di Francesco?
C’è una cosa che mi colpisce. Questa pastorale di Francesco è stata letta in questi giorni assai criticamente, come se fosse una sorta di tendenza “sociologizzante” del Papa, e addirittura “socialisteggiante”, corrispondente cioè alla sua impostazione tutta terrena, militante addirittura, della sua missione. Io penso che le cose non stiano affatto così.
La novità e la grandiosità della figura di Papa Francesco è che ha saputo portare la dimensione del sacro nella cura del dolore del mondo. La capacità di trovare, negli aspetti materiali, una dimensione spirituale
Luigi Manconi
Come stanno le cose, secondo lei?
Penso che l’aspetto più importante della pastorale di Francesco sia stato di portare la dimensione del sacro nella cura del dolore del mondo. Quindi, non una sorta di estremismo militante, cioè una sorta di concentrazione sugli aspetti materiali della vita degli esseri umani. Ma all’opposto, la capacità di trovare, in quegli aspetti materiali, una dimensione spirituale. La differenza è enorme perché, nel primo caso, avremmo un Papa dimentico della sua missione spirituale. E sarebbe grave perché la missione spirituale è il primo compito di un pontefice, di un capo della cristianità.
Qual è la novità e la grandiosità della figura di Francesco?
La novità e la grandiosità della figura di Papa Francesco è che ha saputo trovare la dimensione spirituale in questa sua attenzione per tutto ciò che costituisce la sofferenza delle persone, la loro condizione di disumanità, nel destino dei migranti, dei poveri, dei detenuti. Se non ci fosse tale dimensione spirituale, il Papa sarebbe da considerare come un leader politico, un capo, un trascinatore sociale.
Ma io non la vedo affatto così, la vedo nel senso opposto, nella capacità di questo Papa di trovare il senso del sacro dentro quella dimensione di sofferenza. Mi sembra che questa sia stata la cosa più importante che ci abbia consegnato. Il che passa attraverso questa indicazione fondamentale: il dolore è sofferenza, è patimento dei corpi, è materialità delle condizioni di privazione.
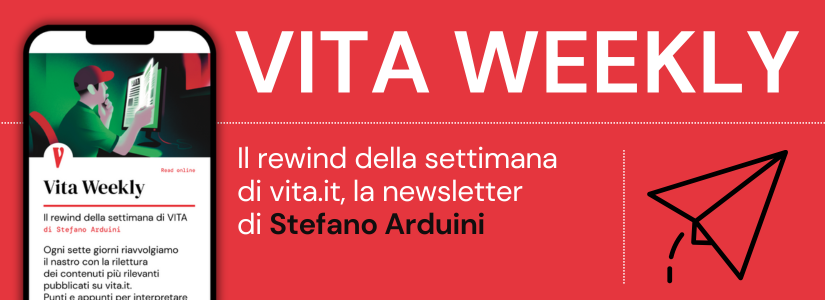
Tutto questo, a mio avviso, consente di trovare nelle parole e negli atti del Papa una pastorale del corpo fino a elaborare una sorta di teologia del dolore, che arriva fino all’ultimo tempo del suo pontificato. Il fatto che abbia non solo non occultato, ma al contrario, resa pubblica la propria malattia, mi sembra qualcosa di importante. È come se avesse voluto dare un senso intenso e più tangibile (in questo senso uso il termine “materiale”) della sofferenza umana per come si manifesta nella vita degli esseri umani: caduchi, cagionevoli, imperfetti, quali noi siamo.
In un articolo per la Repubblica, lei ha scritto: «In un mondo dove le figure morali tendono a esaurirsi o ad appannarsi irreparabilmente, l’autorità spirituale di Francesco è ancora viva e trae alimento proprio dalla capacità di “patire insieme”».
È proprio così. È stato partecipe del dolore del mondo, non per un processo mentale, non per una cognizione intellettualistica. Al contrario, la sua è una cognizione del dolore che parte dal proprio corpo, arriva al corpo delle persone che in tutto il mondo patiscono e, infine, torna a lui. La sua è stata una ostensione del dolore, proprio un’ostensione in senso liturgico, nel presentare al mondo il dolore. Mi ha colpito l’atto di offrirlo, di mostrarlo. Infatti, le parole del testamento di Francesco dicono: «Offro la mia sofferenza».
In questi 12 anni Papa Bergoglio è stato un punto di riferimento costante per tutto il mondo che a VITA fa riferimento. Per questo abbiamo messo a disposizione di tutti il numero di VITA che ha celebrato i primi dieci anni del pontificato di Francesco. Puoi scaricare il magazine gratuitamente da qui, semplicemente registrandoti.
Foto nell’articolo dalla pagina Facebook dell’intervistato. In apertura, aprile 2022, Papa Francesco lava i piedi a dodici detenuti nel carcere di Civitavecchia. Foto Vatican Media/LaPresse
Nessuno ti regala niente, noi sì
Hai letto questo articolo liberamente, senza essere bloccato dopo le prime righe. Ti è piaciuto? L’hai trovato interessante e utile? Gli articoli online di VITA sono in larga parte accessibili gratuitamente. Ci teniamo sia così per sempre, perché l’informazione è un diritto di tutti. E possiamo farlo grazie al supporto di chi si abbona.
