Idee Generazioni
Volere, ma non potere. Il paradosso dei giovani nel Terzo settore
Esistono forti barriere che rendono complicato il passaggio da desiderio di impegno civico e partecipazione che si scorge in maniera evidente nelle nuove generazioni, alla capacità di strutturarsi in percorsi di imprenditorialità sociale o nell’ingresso in organizzazioni della società civile. Perché? La riflessione di Adriano Bertone, fondatore di GenerazioneT e Federico Mento, co-country director di Ashoka Italia
di Adriano Bertone e Federico Mento

L’attenzione sulla questione giovanile da parte dell’opinione pubblica segue strane traiettorie, scandite in maniera serrata da fatti di cronaca. E meglio se questi fatti sono roboanti, pronti a catalizzare l’indignazione collettiva e la sequela di commenti, che hanno come tratto comune lo stigma generazionale. Uno strano meccanismo che spinge il dibattito su crinali quasi paradossali, basta leggere le dichiarazioni di chi dovrebbe avere un atteggiamento professionale e misurato, come Paolo Crepet, che sollecitato dai media tradizionale, tende a “spararla sempre più grossa”, l’ultima in ordine di tempo è la proibizione all’uso degli smartphone sino al compimento della maggior età. Non sappiamo se la ricerca della trovata ad effetto sia frutto di ponderata e profonda riflessione – ci auguriamo davvero non lo sia – o piuttosto determinata dal meccanismo distorto dell’audience, del fare rumore per il rumore, tanto caro ai media mainstream.

Il quadro è desolante, le giovani generazione sono strette nella narrativa banalizzante dei “maranza”, delle eccessi della scena “trap”, spesso apostrofati come “analfabeti emotivi”, descritti come “inerti. A queste rappresentazioni, fa da controcanto un astratto richiamo al merito da parte delle generazioni più anziane, che dimenticano, però, di essersi sedute ad una tavola già imbandita. Perché, come ci ricorda Michael Sandel, la stucchevole retorica del “merito”, che rimbalza sulle pagine degli editoriali o nei propositi della politica, dimentica però che senza dei meccanismi redistributivi in grado di generare uguaglianza delle opportunità, il richiamo al merito non fa altro che legittimare le profonde differenze che caratterizzano questo tempo.
Un’agenda puramente discorsiva, che non intende dar seguito ai propri propositi, mettendo a terra ciò che serve: politiche, strumenti, agevolazioni ecc. Eppure, i numeri sono impietosi: negli ultimi 20 anni, il Paese ha perso 3,5 milioni di under 35, tra 2011 e il 2021 la fuga di cervelli è aumentata del 280%. La condizione di precarietà coinvolge il 41% dei giovani nel mercato del lavoro, a cui si accoppia la trappola dei bassi salari, con crescenti differenziali di reddito e basso potere d’acquisto. Questi squilibri determinano, inoltre, una costante perdita di “peso politico”, oggi gli elettori under 35 rappresentano circa il 20% della base elettorale, 20 anni, rappresentavano quasi un terzo degli aventi diritto. Tale tendenza si riversa naturalmente sulla rappresentanza, nelle ultime elezioni l’età media degli eletti è tornata a crescere, soltanto il 10,7% dei parlamentari è under 40.
Non ci deve sorprendere, quindi, la dispercezione sulle priorità, la questione generazionale si esaurisce quasi esclusivamente nel tema dei Neet, con un approccio profondamente paternalistico – di nuovo sono loro a non funzionare mai le scelte degli adulti- mentre non ci si interroga su come le giovani generazioni possano attivamente contribuire al cambiamento. Lavorando da tempo in processi di attivazione del protagonismo giovanile, siamo convinti esista nella società una forte domanda di cambiamento da parte delle giovani generazioni. Lo abbiamo, di recente, verificato con l’esito della call Civico25 , nata dalla collaborazione tra Fondazione Finanza Etica ed Ashoka Italia. Obiettivo della call è supportare organizzazioni o gruppi informali under 29 che operano nell’ambito del protagonismo giovanile. La risposta è andata oltre le nostre aspettative, 155 candidature, da nord a sud, esperienza già consolidate, accanto a gruppi che sono ancora nella fase iniziale del proprio percorso.
Così come, l’esperienza di GEN-C, acceleratore del protagonismo giovanile che ha sostenuto e accompagnato numerose esperienze di innovazione sociale: il semplice schema di una precisa individuazione e mappatura di giovani attori del cambiamento nei territori, unita al tentativo di costruire prima momenti di networking e poi percorsi su misura per l’accelerazione delle loro organizzazioni, ha permesso di raggiungere specifici risultati. È il caso, ad esempio, dell’impresa sociale Generazione T, che da oltre 3 anni si impegna nell’ambito del coinvolgimento giovanile nelle aree interne fra Umbria e Toscana. È stato proprio nel coacervo di stimoli ed idee degli eventi di Generazione Changemaker, che affondano le radici di una organizzazione totalmente under 35 che ha fatto della sua fiducia nel terzo settore la leva per lo sviluppo di numerosi progetti ad alto coefficiente di innovazione sociale. Dalla collaborazione con oltre 80 comuni, alle sinergie intraprese con numerose fondazioni, Generazione T in pochi anni ha saputo rilanciarsi sulla sponda dei percorsi costruiti nell’ambito del progetto GEN-C, trovando in esso la benzina e le informazioni per capire come muoversi nel mondo del social impact.
Da questo punto di vista, evidentemente, emergono due osservazioni che non possiamo più permetterci di rimandare: da un lato ci accorgiamo di come oggi, ancora troppo spesso, si sottovalutino gli effetti indiretti degli investimenti che vengono fatti nei soggetti in grado di alimentare gli ecosistemi dell’innovazione sociale. Come quantificare l’impatto indiretto di GEN-C nell’aver ispirato i giovani delle tante organizzazioni che sono nate e cresciute negli anni a venire da quel percorso? Dove inserire nella rendicontazione della valutazione di impatto di un progetto come quello, le tracce che emergono ad anni di distanza e non nella precisa contingenza del progetto? E ancora, come possiamo fare in modo che ci sia una sana comprensione del “ritorno sociale dell’investimento”, quando l’attenzione è sempre orientata verso i numeri di output e la componente di matrice economica?
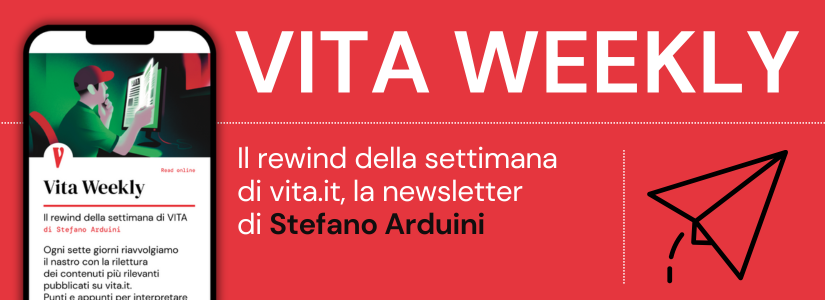
Dall’altro lato, pare evidente che storie come quella di Generazione T sollevino l’attenzione su quello che potremmo definire come il più radicale “paradosso del Terzo settore”: le nuove generazioni oggi ci appaiono spesso disilluse e apatiche, ma i dati sembrano mostrarci altro. Come ricorda Eticaeconomia, nel periodo 2019-2022 le dimissioni dei lavoratori a tempo indeterminato sono aumentate del 24%, decisamente meno di quelle dei lavoratori con contratti a termine o atipici (34%). In particolare, le dimissioni degli under 30, già molto più alte rispetto alle altre fasce di età, dopo la pandemia, hanno raggiunto tassi record: nel triennio 2020-2022, in numeri assoluti, sono aumentate del 72%, a fronte di un aumento del 56% per la fascia 30-50 e del 30% per la fascia di età più matura. Tra le motivazioni principali di questo movimento della storia troviamo un’alta insoddisfazione sul posto di lavoro: i giovani di oggi non si accontentano di lavori funzionali, ma puntano a cercare di realizzare in primo luogo una propria dimensione identitaria, il famoso purpose.
Ed è in questo contesto che il Terzo settore dovrebbe avere gioco facile a presentarsi come quell’ambito dell’economia in cui sia più facile per questi giovani sviluppare percorsi di autoimprenditorialità o trovare soddisfazione nel perfetto allineamento tra purpose personale e mission delle organizzazioni. Al contrario, come osserva Openpolis, nonostante le nuove generazioni siano il perno del volontariato, visto che l’1,6% delle persone con almeno 14 anni nel 2022 ha partecipato a riunioni di queste organizzazioni, quando nessuna classe demografica over-25 raggiunge la quota del 2%, grandi problemi emergono rispetto alla presenza di giovani nelle imprese sociali: come osservato da Euricse, per citare un caso esempio, in Toscana oltre il 77,5% di questi enti non presenta neppure un under 35 nel Cda, con un valore che cala drasticamente all’1,8% se si osserva il numero di imprese sociali con almeno il 50% di giovani.
Esistono, dunque, una serie di barriere all’ingresso che rendono complicato il passaggio da quel desiderio di impegno civico e partecipazione che si scorge in maniera evidente nelle nuove generazioni, alla capacità di strutturarsi in percorsi di imprenditorialità sociale o nell’ingresso in organizzazioni della società civile.
I giovani non sono il futuro, ma vivono il presente, talvolta con rassegnazione, spesso con il desiderio di cambiarlo
C’è dunque un urgente bisogno di investire in percorsi che accompagnino questi giovani, ispirandoli e mostrando loro che esiste un modo per appagare quel bisogno di senso che emerge dalle pieghe di una società ormai da tempo genuflessa su se stessa. Ma per favorire questo processo, dobbiamo agire in diverse direzioni.
La prima è legata alle modalità di supporto, che oggi sono ancora “impacchettate” nella forma rigida del progetto, mentre risorse flessibili direzionate sulla missione genererebbero un effetto positivo sulla capacità delle organizzazioni del protagonismo giovanile di crescere e consolidare il proprio impatto.
Una seconda direttrice è quella del supporto non-finanziario che può essere articolato in crescita delle competenze, mentoring e coaching e networking, quest’ultimo particolarmente prezioso in una funzione evolutiva. Un’ulteriore linea d’azione è quella dell’ascolto, che presuppone l’uscita da posture giudicanti, e un nuovo posizionamento culturale basato sul riconoscimento reciproco e sulla fiducia. Se andiamo ad analizzare le ragioni del fallimento di molte iniziative rivolte alle giovani, ci accorgiamo che queste parlano dei giovani, senza volere realmente parlare con i giovani. Quante volte abbiamo sentito dire che i giovani sono il futuro, quasi a dilazionare nel tempo l’urgenza del confronto tra le generazioni. I giovani non sono il futuro, ma vivono il presente, talvolta con rassegnazione, spesso con il desiderio di cambiarlo. Apriamoci, accettiamo con coraggio questa sfida, il terzo settore ha tutto da guadagnare dall’incontro con il protagonismo giovanile.
Foto: Pexels
Vuoi accedere all'archivio di VITA?
Con un abbonamento annuale potrai sfogliare più di 50 numeri del nostro magazine, da gennaio 2020 ad oggi: ogni numero una storia sempre attuale. Oltre a tutti i contenuti extra come le newsletter tematiche, i podcast, le infografiche e gli approfondimenti.


