Sono trascorsi due mesi dalla strage degli studenti di Iguala del 26 settembre 2014. La storia contemporanea del Messico sembra già contenere le tracce di quella teratogenesi dell’umano nell’epoca del capitalist realism.
Lo scorso 26 settembre si verificavano le vicende brutali di Iguala, nello stato di Guerrero in Messico. Gli studenti della Scuola Normale Rurale di Ayotzinapa stavano protestando contro la povertà estrema del loro istituto, opponendosi alle riforme neoliberiste dell’educazione. La polizia interveniva brutalmente: sei studenti-attivisti venivano uccisi, altri 43 arrestati.
Ad oggi non si conoscono le sorti dei 43 studenti di Iguala: alcuni pensano siano stati massacrati, bruciati vivi, sepolti in una delle tante fosse comuni segrete. Il dato di realtà è che quasi sicuramente questi 43 ragazzi non torneranno più alla loro vita.

Si è ormai aperta una nuova fase drammatica nella storia contemporanea del Messico: dagli episodi sempre più frequenti di repressione violenta delle manifestazioni popolari, da parte delle forze dell’ordine, all’acuirsi degli scontri all’interno delle organizzazioni criminali. Un climax sociale di estrema violenza pervade l’intero paese, come espresso da molti intellettuali messicani, tra cui Enrique Alvarez Alcàntara, attivista, neuropsicologo, nonché docente presso l’Universidad Autónoma del Estado de Morelos (Cuernavaca, México).
Il destino del Messico è, da tempo, segnato da una violenza che salda l’idea dello stato con le strutture militari, attraverso il collante di quelle che vengono eufemisticamente indicate come “agenzie di criminalità organizzata”. Il tempo recente di questo destino di violenza – “di bassa intensità, perché il nostro paese non è in una guerra civile”, precisa Enrique Alvarez Alcàntara– è stato scandito da centinaia di migliaia di morti, da oltre 35.000 dispersi, da un numero imprecisato di femminicidi.
In un paesaggio violento, di cui non è conosciuta l’esatta cartografia delle fosse comuni in cui sono nascosti, i corpi spesso smembrati di persone assassinate, o considerate disperse. “Come se la violenza fosse diventata il nostro pane quotidiano” commenta Alvarez Alcàntara.

Una crisi sociale che si sovrappone alle distrofie del modello di sviluppo economico neoliberista a cui, come ad un dogma, si sono religiosamente affiliati i governi messicani a partire dal 1988. Da queste distrofie dell’economia di stato è scaturita una povertà diffusa che ha inevitabilmente costretto molti messicani ad arruolarsi nella produzione e nel traffico degli stupefacenti. Una necessità umana di sopravvivenza sostiene le fabbriche della droga, gestite all’interno degli spazi economici e politici ambigui di quella connivenza stato-mafie che percorre e divora il paese, in nome di una tecnologia del potere declinata con tattiche terroristiche e paramilitari.
“I gruppi criminali della droga sperimentano inedite collaborazioni con i diversi organi dello stato, dai membri del governo federale all’esercito, dalla polizia alle municipalità, passando per magistrati e legislatori” spiega Enrique Alvarez Alcàntara. E da queste celate collaborazioni ne risulta ibridata, alterata la struttura antropologica delle mafie messicane che– spiega Alvarez Alcàntara–sembrano aver perso del tutto anche quella originaria e arcaica forma di rispetto per le persone.
Il Messico come un inferno dantesco contemporaneo – racconta Alvarez Alcàntara, evocando la visione del poeta Javier Sicilia – in cui Enrique Peña Nieto, succedendo a Felipe Calderón Hinojosa, non ha fatto altro che proseguire una tradizione infernale. E questa tradizione non può che nutrirsi di rabbia e di violenza, in una fenomenologia complessa che dalla strage di Iguala, con l’uccisione degli studenti della Scuola Normale “Raúl Isidro Burgos” di Ayotzinapa, si dipana in un cortocircuito caotico, inafferrabile con gli omicidi delle giovani lavoratrici delle maquilas, le fabbriche di assemblaggio di Ciudad Juárez.

Un tessuto sociale magmatico e inquieto assiste agli scontri tra attivisti e militari, tra narcotrafficanti e autodefensas, nella disgregazione del ruolo storico-politico dello stato, travolto dall’affermarsi di micro-comunità generate da un patto di sangue ispirato all’esercizio della forza, in nome di una disperata e istintiva lotta per la vita, come sottolinea Enrique Alvarez Alcàntara. Ad emergere è una mutazione delle categorie storico-politiche, definita sovente come narco-stato, attraverso cui probabilmente già si intravede, come in una prospettiva evolutiva, il futuro assetto psico-patologico del capitalismo, non solo nel contesto messicano. Nel 1950 Luis Buñuel realizzava il film “I figli della violenza”, raccontando la storia di alcuni ragazzi perduti della periferia di Città del Messico. Una storia di crudeltà oggettiva, mai eccessiva, in cui si rappresentava come la miseria, la povertà fossero state, e siano tuttora, generatrici di un mondo in cui un’umanità cieca, priva di lucidità, vaga senza possibilità di riscatto. Un mondo dove l’unica certezza è la morte, come nella scena finale del film di Buñuel con il cadavere di un ragazzo rovesciato fra i rifiuti. Sembrano impossibili le soluzioni, o quantomeno le prospettive di un’alternativa, ad un sistema capitalistico planetario chiaramente fondato – come aveva pienamente descritto Marx – su rapporti di dominio, di coercizione, di disuguaglianza. Uno scenario in cui la violenza diviene prassi ordinaria per realizzare “l’accumulazione originaria”, nonché strumento di stabilizzazione dei processi economici globali.

Eppure occorre rispondere all’imperativo di compiere un atto di responsabilità etico-politica, misurandosi con la violenza costitutiva dell’odierno capitalismo – come scrive Žižek – ma anche prendendo una posizione chiara contro l’anonimizzazione di milioni di esseri umani che scelgono di auto-asservirsi alle nuove logiche del capitale. Dal Messico fino alle metropoli occidentali abitate da individui assuefatti al dovere inconscio della jouissance.
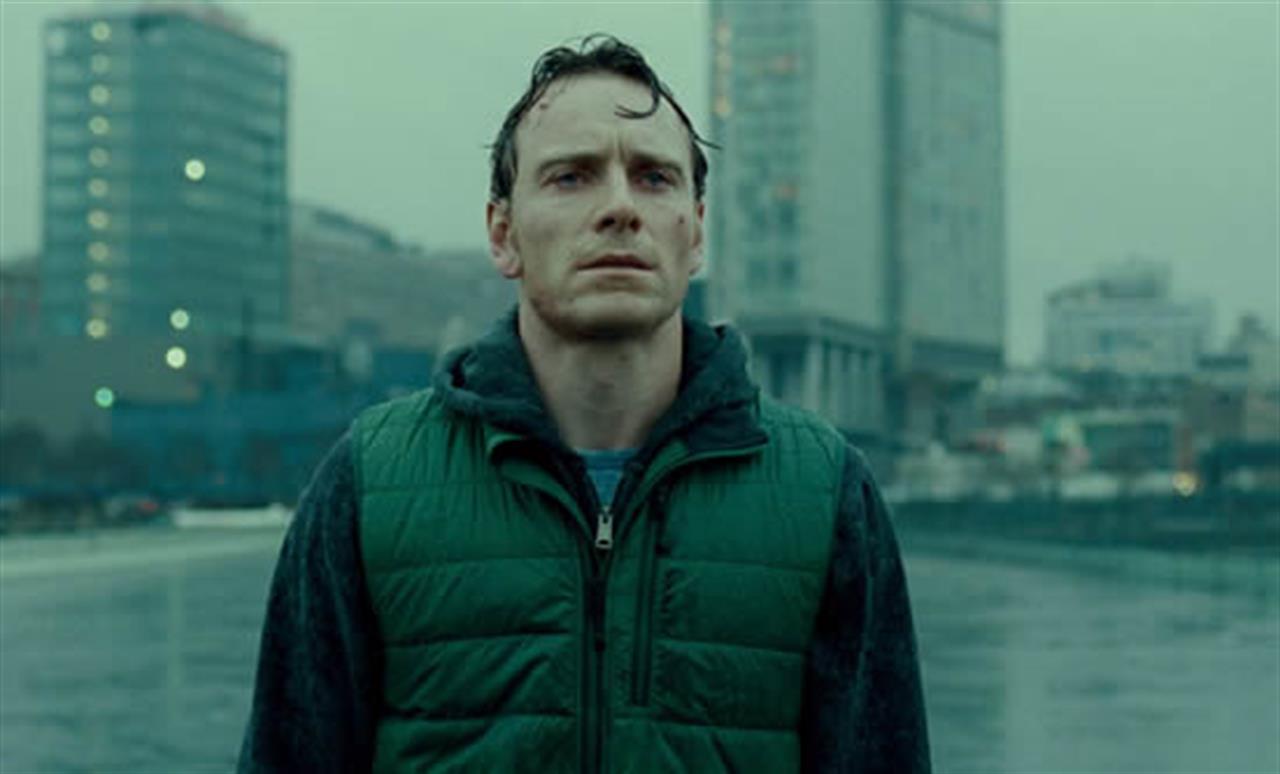
Una posizione è stata assunta dal poeta citato da Alvarez Alcàntara. Javier Sicilia nel 2011 perde suo figlio, Jaun Francisco, assassinato brutalmente e ritrovato a Temixco, nei dintorni di Cuernavaca, all’interno di un furgone insieme ai cadaveri mutilati di altri tre giovani. Una morte tragica, anche perché frutto di una fatalità, di uno “sbaglio”: Juan Francisco e gli altri ragazzi erano stati erroneamente identificati come membri di una banda rivale. Uno dei tanti episodi delle faide intestine al narcotraffico, allevate nell’ambito di quella militarizzazione del conflitto contro la criminalità, decisa nel 2007 dal presidente Felipe Calderón Hinojosa.Nel marzo 2011, percorrendo la distanza che separa Cuernavaca da Ciudad Jarez, al grido di “Estamos hasta la madre!”, Javier Sicilia fonda il Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad. A quel grido moltissimi rimasero inerti, indifferenti: di lì a poco – nel luglio 2012 – veniva eletto, presidente, Enrique Peña Nieto.

Eppure questo poeta ha rinnovato la scelta di non fermarsi, ha continuato a camminare. Giorni fa presso il College of Liberal Arts di Austin in Texas, Javier Sicilia ha tenuto un’appassionata lettura sulla condizione di profonda, dilagante crisi dell’umanità nel presente di stati-nazione che hanno ormai da tempo smesso di occuparsi della pace, della sicurezza e del benessere dei popoli, in nome di inumani interessi economici – politici, legali o illegali che siano.

Cosa resta da fare, se non mettersi in cammino e farsi testimoni di una resistenza. Continueranno ad esserci cadaveri di ragazzini, figli della violenza, i dimenticati, che noi stessi abbiamo contribuito ad abbandonare. Prendere coscienza con lucidità di questo mondo di atrocità travolge di dolore, ma con questo dolore bisogna imparare a convivere, a non farsene soffocare, evitando di rifuggirlo in una diffusa e rassicurante anestesia.
Spalancare gli occhi sul terribile presente ed incerto futuro, camminare anche se tra le lacrime, e resistere.
Cosa fa VITA?
Da 30 anni VITA è la testata di riferimento dell’innovazione sociale, dell’attivismo civico e del Terzo settore. Siamo un’impresa sociale senza scopo di lucro: raccontiamo storie, promuoviamo campagne, interpelliamo le imprese, la politica e le istituzioni per promuovere i valori dell’interesse generale e del bene comune. Se riusciamo a farlo è grazie a chi decide di sostenerci.

