Economia
Il Nobel Stiglitz: «Contro le diseguaglianze, investite sul Terzo settore»
I dati dell'Istat lo confermano: nel nostro Paese cresce il divario tra (pochi) mega-ricchi e la massa della popolazione, sempre più precaria e sconnessa. Nel nostro presente ci sono povertà assoluta, fine della classe media, diseguaglianze sociali, economiche e di genere. Per cambiare rotta, spiega il Nobel in questa intervista a Vita, «dobbiamo far leva sul no profit»
di Marco Dotti
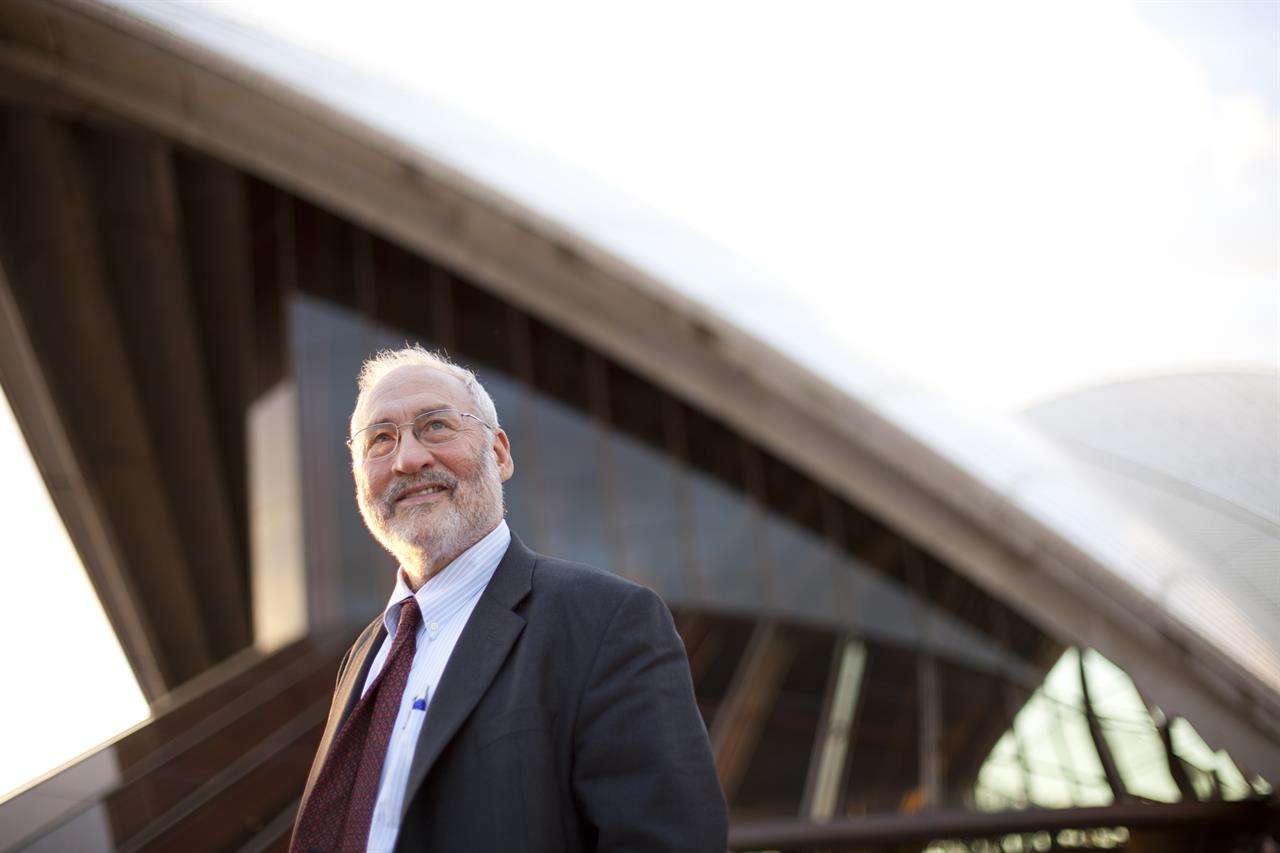
Oggi, spiega il premio Nobel per l’Economia Joseph Stiglitz, l’Italia è «uno dei paesi con il più alto livello di diseguaglianze al mondo». Per una volta, gli Usa non sono tanto distanti da noi: «classe media spolpata, base della popolazione impoverita e l’1% della stessa popolazione che gode di extra profitti. Con i figli di questo 1% che si ritroveranno ricchi per mera “discendenza” »ed erediteranno un vantaggio competitivo che non farà che allungare la catena delle diseguaglianze. Qualcosa non torna, qualcosa non va, forse tutto.
Dal punto di vista teorico, è saltato un modello: quello della “teoria del gocciolamento”, ovvero l’idea che le diseguaglianze – di benessere, salute, reddito e di opportunità sociali – potessero in qualche modo essere mitigate dal fatto che i vantaggi ricevuti dalla popolazione più abbiente, sarebbero ricaduti sulle fasce più basse in termini di offerte di lavoro e via discorrendo. Al contrario, ci spiega Stiglitz, che abbiamo incontrato a margine dell'incontro sulla "jobless society“ organizzato da Adecco e Fondazione Feltrinelli, crescita degli ultimi decenni è andata a chi stava in cima, che si è preso tutto condividendo niente. Il salario minimo di un lavoratore è più basso di 40 anni fa», negli Usa come in Italia.
Professor Stiglitz, lei ha disegnato un quadro a tinte fosche del nostro presente. Ma per il futuro?
Poiché siamo esseri capaci di scelta e capiamo che così le cose non vanno, io sono ottimista: sappiamo scegliere, dobbiamo scegliere, ma dobbiamo anche capire in che direzione orientare questa scelta. Le diseguaglianze non sono inevitabili e la disoccupazione non è un destino. Il lavoro deve però essere luogo dove queste diseguaglianze si affievoliscono e garanzia della mobilità sociale. Se diventa luogo di diseguaglianza e discriminazione, siamo in un nuovo feudalesimo,
Dove orientarla, allora, la nostra scelta?
Dobbiamo contrastare in ogni modo le disuguaglianze. Per farlo, dobbiamo riscrivere le regole del mercato, garantendo una migliore distribuzione del reddito, rafforzando il potere di contrattazione dei lavoratori e riducendo la forbice tra i compensi dei manager e il salario medio dei dipendenti. Oggi, il sistema garantisce l’accumulo di ricchezza finanziaria e disincentiva, di fatto, gli investimenti nell’economia reale, nelle infrastrutture e a supporto delle piccole e medie imprese. Dobbiamo andare in un’altra direzione, sia sul piano delle regole, sia su quello della governance aziendale.
Come può il terzo settore contribuire a questa riconfigurazione dell’economia?
Facendo quello che sa fare e facendolo al meglio. Prendiamo il caso degli Stati Uniti: se osservi le istituzioni americane, se le osservi bene intendo, che cosa noti? Noti che quelle di maggiore successo sono le istituzioni no profit. E tra queste istituzioni, particolare successo hanno le università. Direi che se il terzo settore tiene fede ai propri compiti, il suo successo va a un vantaggio di tutti. Non ci sono istituzioni “for profit” di successo.
Eppure, il corporate storytelling ci dice il contrario…
Lo ha detto lei, è corporate storytelling…
Diciamo pure: menzogne.
Infatti l’unico successo concreto di queste “for profit” sta nello sfruttare persone. Sfruttare persone povere. In questo riescono benissimo. Ma se guardi le università come Harvard, le fondazioni, le associazioni che davvero incidono positivamente sul piano economico e sociale, sono tutte no profit. Quando la gente parla dell’economia di mercato, io dico che non siamo una vera economia di mercato. Non lo siamo negli Stati Uniti, dove l’intero settore dell’educazione, dalla Stanford University in giù, è retto da un sistema no profit. Non lo siete in Italia dove – non devo essere io a insegnarvelo – il terzo settore ha un ruolo preminente. Guai se saltasse.
Non capirlo ha dei costi enormi, non crede?
Infatti, ci dimentichiamo che esistono istituzioni importanti che agiscono not -for-profit e, dimenticandocene, tendiamo a non capire la loro capacità di riconfigurare l’intera economia. Pensiamo al settore sanitario: credo che una delle ragioni per cui il sistema sanitario negli Stati Uniti sta andando così male risieda nel fatto che un tempo avevamo strutture che non operavano in primo luogo per profitto, ospedali religiosi e ospedali di comunità per esempio, e ora invece abbiamo “for profit hospitals”. Avevamo compagnie di assicurazione sanitaria cooperative, ora abbiamo imprese di assicurazione sanitaria “for profit”. Quello che voglio dire è che dobbiamo stare attenti ai piccoli cambiamenti. Sono stati i piccoli cambiamenti che hanno cambiato l’intera cultura di queste organizzazioni.
Un esempio positivo di questo no profit americano?
Penso a un istituto finanziario che si è comportato bene, le unioni di credit che sono no profit …
Anche piano del lavoro, oggi più che mai, il no profit ha molto da dire, soprattutto per produrre cambiamenti positivi nella cultura organizzativa.
Credo, infatti, che questa sia la sfida, non per generare ibridi ma per creare mentalità, cultura.
Il modo migliore per qualunque paese per ridurre la disoccupazione giovanile resta comunque intervenire sulla disoccupazione complessiva. L’Italia, ora, ha un problema in più. Non solo è uno dei Paesi al mondo dove le diseguaglianze di reddito sono più marcate…
… e questo è già un bel paradosso, vista la presenza di quel terzo settore di cui parlavamo…
Chiediamoci cosa accadrebbe se non ci fosse.
Accennava comunque a un problema in più, per l’Italia, sul piano delle politiche del lavoro…
Il problema è l’eurozona, per come è stata configurata. Intervenire sulla flessibilità non poterà a molto, perché anche nei paesi all’interno dell’eurozona in cui si è tentato di incrementare la flessibilità, l’unico risultato è indebolire ancora di più la tenuta interna dell’economia.
Se diciamo eurozona, diciamo in sostanza Germania…
All’interno dell’euro per i giovani italiani è molto difficile essere pienamente occupati, sarebbe facile per la Germania cambiare le sue politiche, per l’Europa cambiare e quando dico “facile” non mi riferisco alle politiche economiche. Parlo di politica. La diseguaglianza è conseguenza di una scelta del sistema politico. Poiché la Germania ha un peso imponente, lo fa valere. Bisogna riformare le regole dell’eurozona, condividendo il debito e cancellando il fiscal compact, tornando a favorire investimenti pubblici. Senza procedere in questa direzione non si uscirà dal problema della disoccupazione di massa che, secondo la Bce, nell’area euro, è al 18,5%.
Conseguenza di questa politica e della gabbia di ferro dell’eurozona è che, in Italia, oggi 1,6 milioni di persone vive in condizioni di povertà assoluta.
Non solo, se i paesi più virtuosi in tema di reddito, lotta alla disuguaglianza e mobilità sociale sono Norvegia (che è fuori dall’eurozona) e Svezia, l’Italia è ai primi posti al mondo per tasso di diseguaglianza, forbice di reddito e immobilismo sociale. In Italia, come negli Stati Uniti, hai un reddito alto se nasci da famiglie con un reddito alto, come negli Stati Uniti. Per questo, se l’eurozona è una trappola, gli Stati Uniti non sono certo il modello.
Si rischia, anche sulle tematiche del lavoro, di dare come il Barone di Münchhausen
che voleva tirarsi fuori dalla palude tirandosi per i capelli.
Tanto più che, in Italia, è in atto un sotto investimento, anche culturale, sulle politiche della ricerca. I ricercatori non trovano lavoro e fuggono all’estero, coloro che potrebbero dare tanto a questo Paese sono costretti in condizioni di precarietà permanente e subiscono disuguaglianze al limite dell’umiliazione. Ecco, se torniamo al punto da cui siamo partiti: anziché invocare austerity o seguire ricette importate da chissà chi e da chissà dove, cercare di ridisegnare i confini dell’economia spingendo sul terzo settore, sulla sua capacità di agire sul legame sociale non sarebbe cosa da poco. Se non ripartiamo da questa forza motrice, sarà difficile. Se vogliamo riscrivere le regole e ridefinire la forma dell’economia, dobbiamo partire dal lavoro e ricordarci che abbiamo delle alternative alla crisi, all’austerity, alla crescita delle diseguaglianze. Una di queste alternative è imparare dal no profit come si opera un vero cambiamento sociale.
Vuoi accedere all'archivio di VITA?
Con un abbonamento annuale potrai sfogliare più di 50 numeri del nostro magazine, da gennaio 2020 ad oggi: ogni numero una storia sempre attuale. Oltre a tutti i contenuti extra come le newsletter tematiche, i podcast, le infografiche e gli approfondimenti.
