“Io vengo da. Corale di voci straniere” è un viaggio appassionante alla scoperta delle storie dei nuovi italiani. È l’ultimo libro (illustrato da Giordano Polini ed edito da Einaudi ragazzi, 2019) di Daniele Aristarco, autore di racconti e saggi rivolti soprattutto ai ragazzi, pubblicati sia in Italia, sia in Francia. Una raccolta di testimonianze di bambini stranieri che abitano il nostro Paese, attraverso cui scoprire in quanti modi si può essere stranieri, anche nella propria casa. Aristarco ci mostra che essere straniero è una possibilità, un dono, una scelta nostra o degli altri.
L’autore, classe 1977, ex insegnante di lettere nella scuola media, oggi dedito anche alla scrittura per il cinema e la radio e regista teatrale, ideatore di laboratori di scrittura creativa per l’infanzia presso scuole e associazioni culturali, è stato protagonista del terzo appuntamento di “Un caffè verde con… – Incontri che fanno bene” , il nuovo format di Dirette Facebook che la Fondazione Vincenzo Casillo ha inaugurato durante la pandemia e che ogni settimana ospita talenti di varia natura che in qualche maniera hanno dimostrato che il mondo può essere un posto migliore.
Dialogando con Aristarco abbiamo avviato una vera e propria investigazione sulle nostre origini.
Alcuni dei titoli di altri suoi libri sono uno straordinario biglietto da visita: “Lettere a una dodicenne sul fascismo di ieri e di oggi”, “Io dico NO! Storie di eroica disobbedienza”, “Io dico SI! Storie di sfide e di futuro”. Sono tutti libri che insegnano a pensare, ad essere differenti nel pensiero, a sviluppare una coscienza critica. Come è arrivato a scegliere il tema di questo libro?
I miei libri nascono dagli incontri nelle scuole, mi piace ascoltare e prestare particolare attenzione alle voci che vanno fuori tema. In questo caso mi sono sintonizzato sui cambiamenti che sta vivendo la nostra società, questa nuova composizione del nostro Paese. Come succede in libreria dove spesso sono i libri a sceglierci, così succede a me per la scrittura: a volte mi sembra di aver scelto un tema, ma in realtà è un momento particolare che si incrocia con il mio interesse e con quello die miei lettori, che nel mio caso sono ragazzi. Arthur Schopenhauer diceva che noi acquistiamo libri illudendoci di acquistare del tempo per leggerli; secondo me li scriviamo anche per illuderci di acquistare un tempo ulteriore, diverso. Quando scrivo un libro mi prendo un tempo differente per ragionare. E allora mi sono detto: spesso il racconto dei media in questi anni è stato un racconto catastrofico, quando invece girando per le scuole italiane spesso mi sono trovato davanti a realtà in cui la curiosità nei confronti dell’altro è uno stimolo. Mi sono chiesto: come mai i bambini vivono già in una società multietnica dove ogni differenza può essere un valore, e il racconto degli adulti è invece così negativo? La spiegazione forse è semplice: non viene data voce ai bambini, che invece raccontano spesso il racconto degli adulti. Così ho iniziato questo viaggio nelle scuole, nei centri di prima accoglienza, nelle associazioni culturali, ragionando con i nuovi e i vecchi italiani su come sta cambiando il nostro Paese e su che cos’è questa migrazione, facendomi portavoce delle storie dei ragazzi che difficilmente ottengono ascolto.
Molto spesso viene chiesto ai ragazzi cosa vorranno diventare. Lei ha scelto di raccontare invece chi sono e lo ha fatto ponendo una domanda diretta: Da dove vieni? In che modo ripercorrendo il cammino che ci ha condotti fino a qui possiamo delineare la nostra identità?
In genere i bambini, anche quelli che hanno vissuto esperienze drammatiche, che sono scappati da realtà complicate, difficilmente condividono il dolore, tendono a fare un racconto che ha più a che fare con il gioco, tendono a condividere lo stupore, la novità. Come dico nel libro, ogni società ha bisogno di uno sguardo straniero che la racconti, che la descriva e faccia anche da specchio, come un amico, un amore, che ti aiuta a comprendere meglio chi sei e cosa fai. Ecco, il racconto di una identità si muove secondo me sempre tra due punti: la nascita e la morte. Noi possiamo muoverci lungo questa linea guardandoci alle nostre spalle, raccontando da dove veniamo, oppure guardarci attorno con uno scopo. I ragazzi hanno sempre uno scopo. In generale, chi si muove da un Paese verso l’altro e intraprende in genere un viaggio anche pericoloso, ha uno scopo, anche se non delineato. I ragazzi hanno una curiosità che è un grande motore, e quindi la loro identità, ciò che raccontano nel libro, è la capacità di sognare e la consapevolezza che quel sogno si può realizzare.

In quanti modi si può essere stranieri?
Nel concetto di straniero c’è una duplice natura a mio parere. C’è una possibilità o una condanna. Se noi giocassimo a volte a sentirci stranieri attraversando le strade delle nostre città come se le vedessimo per la prima volta, lo sguardo che porteremmo si caricherebbe di odori e colori nuovi, come se non ci appartenessero. Quando invece veniamo definiti stranieri, ossia estranei a ciò che sta accadendo, quella è una condanna che può diventare molto pesante. Un ragazzo nordafricano che vive in Italia da qualche anno mi raccontava che ogni volta che rientrava a casa la sera indossava il cappuccio e i guanti per nascondere il colore della sua pelle, perché aveva paura. Ogni volta che bolliamo una persona per un dato così superficiale, come a volte succede anche nei confronti delle donne, non ci accorgiamo che quel dato è molto difficile da sconfiggere in una società costruita sul pregiudizio. Io gioco spesso con i ragazzi sul confine tra la parola “straniero” ed “estraneo”, perché spesso è una percezione. Noi riusciamo a sentirci estranei o stranieri anche all’interno del nucleo familiare, della classe, del contesto in cui lavoriamo: io credo che l’identità sia anche il desiderio di adesione ad un sogno, a un gruppo, a un progetto. Se sostituissimo l’identità con la dignità, forse vivemmo in un mondo dove tutti possono decidere dove si sentono a casa e cosa vogliono raccontare.
Il libro si apre con la storia di Mircea, un bambino rumeno, e muove i tassi dal ricordo di un racconto di suo nonno. Dice: “Mettersi in viaggio è l’unico modo che abbiamo per diventare umani, altrimenti si resta pupazzi di fango”. Il tema del viaggio è ricorrente in questi racconti: cosa sta a simboleggiare?
Ha detto bene: è un simbolo. Io sono un appassionato lettore di Mircea Eliade, uno storico delle religioni rumeno, che dice che il simbolo può rappresentare tutto, perché ciascuno proietta su questo simbolo dei significati. Io sono partito da questo, ossia che il viaggio è ciò che si desidera farne e spesso ce ne rendiamo conto solo a metà percorso. Molti di questi bambini hanno passato già metà della vita viaggiando, per loro il viaggio non è una parentesi come spesso invece è per noi, è una condizione quasi stabile seppure nell’instabilità. È il loro modo di stare al mondo, a me affascina molto. Bruce Chatwin, un noto autore di racconti di viaggio, dice che quando siamo in viaggio siamo felici, perché è il ricordo di una dimensione lontanissima. Quando sei in viaggio hai con te solo quello che ti serve, non sei appesantito fisicamente né dal ruolo sociale, e andando in un posto in cui nessuno ti conosce l’unica cosa che vale è la nostra capacità di raccontare storie. Per questi bambini il viaggio è un modo di stare al mondo che ha a che fare con il racconto.
Chang è un bambino cinese, ha 10 anni, una grande passione per le arti marziali e per i sorbetti al limone. Ogni mattina in classe prima dell’appello alza la mano e dice: “Voglio cambiare nome”. Qual è la sua storia?
Ho incontrato questo bambino in una scuola romana, in uno dei quartieri più multietnici della capitale. Nella sua classe c’erano 20 bambini che provenivano da 20 Paesi differenti e che comunicavano soprattutto facendo musica. Una mediatrice culturale mi ha raccontato di questo bambino che più volte aveva espresso il desiderio di cambiare nome, anche perché soprattuto nelle comunità cinesi è difficile e faticoso insegnare agli altri la giusta pronuncia. Nel suo caso però il desiderio non era legato al conformismo o ad una vita d’uscita da un imbarazzo perpetuo, ma dal desiderio di diventare invisibile, così come lo erano stati in tante classi dei ragazzi che si chiamavano Paolo e che nessuno aveva mai notato. Lui voleva cambiare nome per non dover chiedere un’autorizzazione, ogni giorno, per essere se stesso, per poter restare in silenzio e seguire il volo dei propri pensieri.

Leggendo le storie di questi bambini, figli di coloro che spesso sono appellati come “barbari invasori”, si scopre un fatto: tutte le persone che scappano hanno elaborato un sogno. Che cosa significa avere un progetto migratorio?
Questa è una delle scoperte che ho fatto ragionando con i ragazzi. Mi ha colpito moltissimo la storia di un ragazzo dell’Est-Europa che aveva 12 anni quando l’ho incontrato la prima volta. Era stato separato da suo fratello per molte ragioni, in nome di regolamenti mostruosi. Lui raccontava che avrebbe finito le medie, si sarebbe iscritto ad un professionale, avrebbe presto il diploma e a 18 anni lo avrebbe rivisto. Da una parte certamente quel racconto serve a quel ragazzo a stare con la schiena dritta e lavorare per uno scopo preciso, ma negli occhi di quel ragazzo c’era una determinazione incredibile. L’ho rincontrato anni dopo e sta andando su quella linea.
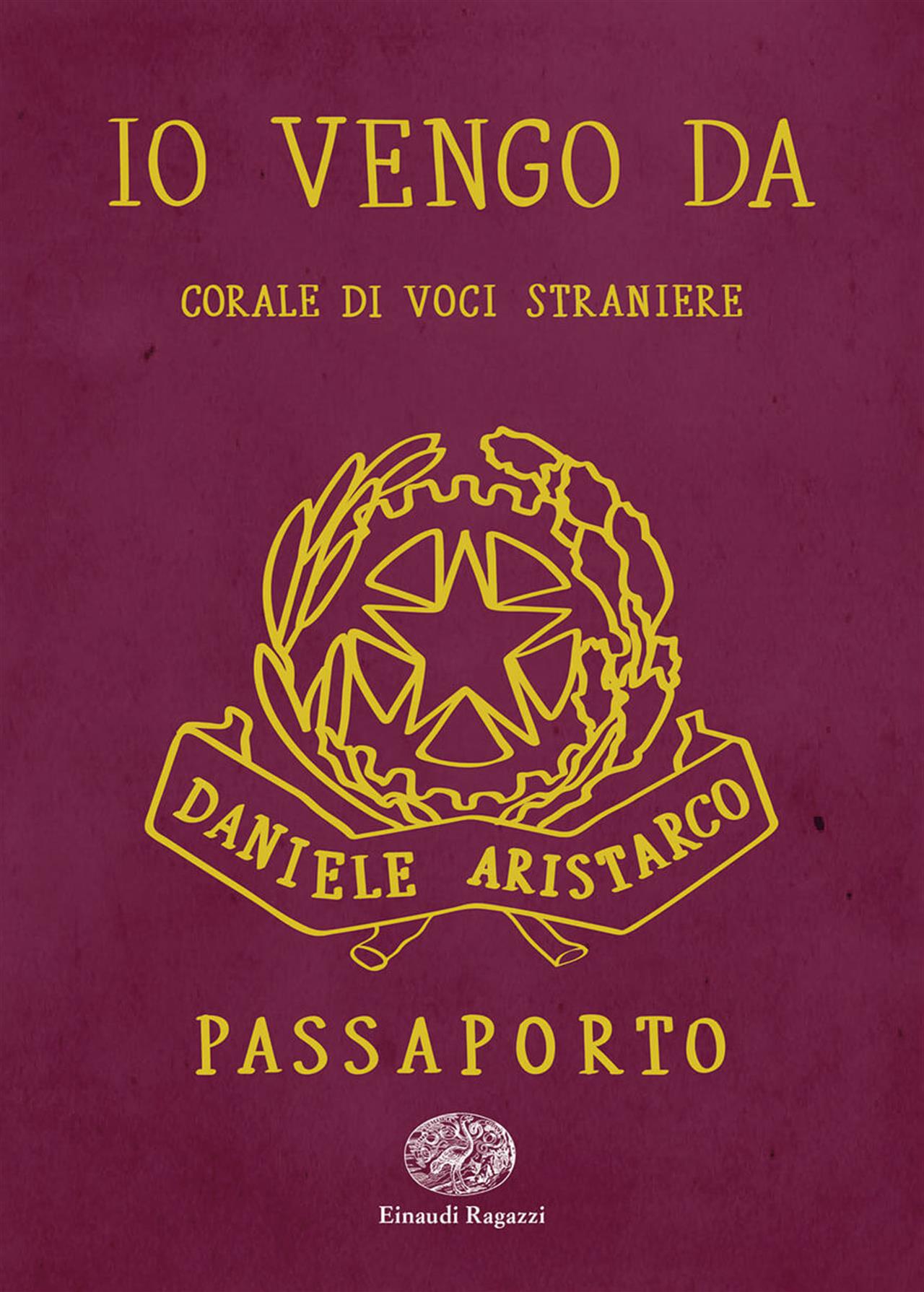
Questo cerco di raccontare ai bambini che spesso non lo sanno: una persona che fugge da un luogo si sta mettendo di fronte a dei rischi enormi. Ma se lo fa, quando lo fa, elabora un sogno, un progetto. Sono spesso progetti molto semplici, concreti e sono esattamente gli stessi progetti che hanno i ragazzi italiani, anche se questi ultimi quasi sempre posticipano, perché noi siamo abituati ad avere un appuntamento con il futuro eternamente rimandabile. Quello che voglio dire è che i sogni sono cose estremamente concrete e che i bambini me l’hanno insegnato, quindi un progetto migratorio ha a che fare con due elementi che vivono dentro di noi. Tutti desideriamo conoscere ciò che è diverso da noi, ma chi si trova a volte nell’obbligo di farlo riesce ad arrivare in fondo a quel sogno.
Nessuno ti regala niente, noi sì
Hai letto questo articolo liberamente, senza essere bloccato dopo le prime righe. Ti è piaciuto? L’hai trovato interessante e utile? Gli articoli online di VITA sono in larga parte accessibili gratuitamente. Ci teniamo sia così per sempre, perché l’informazione è un diritto di tutti. E possiamo farlo grazie al supporto di chi si abbona.

