Lo sguardo filosofico possiede una forza di resistenza che, scriveva Theodor W. Adorno, coincide col «non farsi instupidire da niente, né dell'affermazione della profondità, né dal culto dei fatti». Il pensiero, la critica risiedono forse proprio in questa forza di negazione. In questo dire di no – che «non illumina, puntandolo, un evento, un personaggio, un atto del mondo, ma lo scenario stesso in cui accadono eventi, personaggi, atti». Eppure, osserva Andrea Tagliapietra, professore di Storia della filosofia all'Università Vita e Salute del San Raffaele di Milano, critica non significa accettare lo status quo, limitarsi alla cartografia delle cose, attestarne l'ordine, legittimare i poteri che le attraversano e, attraversandole, le informano. Critica è un sentire altrimenti. Critica è l'arte – diceva Foucault – di «non essere eccessivamente governati».
Nessun mondo, se finisce il mondo
Uno dei limiti di comprensione dell'attuale crisi è nel paradigma di lettura. Siamo dinanzi alla fine di un mondo o siamo già «alla fine del mondo»?
La fine è sempre la fine di qualcosa, è sempre una fine finita. Il problema è dunque la razionalizzazione di questa fine. Una razionalizzazione che il proliferare delle immagini apocalittiche, in questo nostro tempo di crisi, rende altamente problematica. Problematica perché la nostra cultura ha assunto la fine attraverso una contrapposizione tra il logos greco (capace di pensare la finitezza) da un lato e una reazione orientale, di quel pensiero che chiamiamo genericamente ebraico-cristiano, che introduce nell’orizzonte antico la categoria di infinito. La modernità è erede di questo scontro e di un infinito che tuttavia l'Oriente intendeva su un piano non immanente, non mondano. Questo infinito la modernità lo ha proiettato nel finito, rendendolo per così dire immanente. Nasce da qui la teoria del progresso, come logica lineare. Una teoria che oggi si percepisce in maniera netta, evidente anche e soprattutto nel dogma della crescita infinita. Oggi, 8 agosto (nel 2015 arrivò il 13 agosto, mentre nel 2000 fu a fine settembre) la Terra ha raggiunto il suo Earth #Overshoot Day, ossia il punto in cui si considerano esaurite per l'anno in corso le riserve rinnovabili del pianeta e si intaccano le risorse naturali e, per così dire, “intangibili” del pianeta. L'Earth Overshoot Day è inoltre il giorno in cui il reddito annuale a disposizione finisce e la generazione attuale, vive grazie a una sorta di “prestito” le cui conseguenze verranno accollate alle generazioni future, poiché le risorse intaccate non potranno essere rigenerate. È interessante e drammatico osservare che il pianeta va in “rosso” molto prima della sua chiusura temporale di bilancio, fissata al 31 dicembre…
I fautori della crescita infinita fingono di non accorgersene o forse non se ne accorgono proprio, ma la loro corsa trascina il pianeta alla rovina, la denegazione della fine accelera la fine di tutte le cose. Ma per capirlo bisogna risalire alle origini del nostro pensiero…
Potremmo pensare anche alla contrapposizione che sfocia, oggi, nel cattivo-infinito del progresso. Al tempo stesso, però, questa “gioiosa marcia” verso il nulla si alimenta di persistenti immagini apocalittiche…
Sia come genere letterario, sia come forma mentis l'apocalisse nasce dallo scontro tra una cultura vincente, quella greca appunto, e una cultura perdente, quella orientale o semitica. Dallo scontro con la cultura greca nasce l'apocalittica come reazione culturale della parte che soccombe. Di fatto, la vicenda della spedizione di Alessandro Magno in Oriente rappresenta un gesto di imperialismo culturale che fonda la cosmopoli ellenica, l'impero antico. Tanto la Grecia è pensiero del logos che esprime anche una volontà di potenza, quanto l'apocalisse è una risposta in termini di contrapposta volontà di potenza. Risposta a una crisi epocale.
Oggi, dinanzi alla crisi che stiamo vivendo, c'è effettivamente un profluvio di riprese dell'immaginario, dei simboli e del tema apocalittico. Vorrei però sottolineare con forza che, per la prima volta nella storia dell'uomo, a differenza di tutte le crisi che ricorrentemente, nel nostro passato culturale abbiamo vissuto, quella in cui ci troviamo è una crisi in cui realmente ci si misura con la fine delle risorse, del pianeta, di una certa idea di umanità. Per la prima volta, la questione della fine non si consuma all'interno del “sì” o del “no” all'immagine della fine, o all'immagine dell'infinito come negazione della fine, ma diventa uno scontro tra un apparato simbolico e dei limiti strutturali.
Questa forza fa sì che emerga in tutta la sua chiarezza l'ambivalenza che il pensiero apocalittico ha sempre avuto. Perché l'apocalisse, se prendiamo ad esempio l'Apocalisse di Giovanni, dopo un brevissimo prologo catechetico, altro non è che una sequenza di immagini.
Questa sequenza di immagini presuppone uno spettatore, qualcuno che guarda. Il paradosso dell'apocalisse è dunque quello di essere una fine con spettatore.
La fine di tutte le cose presuppone quindi la sopravvivenza dello spettatore, con la conseguenza che mettersi dalla parte dello spettatore significa affrontare la visione orrorifica della fine ma, allo stesso, tempo, sopravviverle. L'ambivalenza dell'apocalittica è la fine di un mondo a cui, però, in qualche modo abbiamo la certezza di sopravvivere. A livello dell'apocalittica, nella fine di tutte le cose, troviamo pienamente operante quel dispositivo psicologico che Freud aveva individuato riguardo al pensiero della nostra morte. Quando pensiamo alla nostra morte, affermava Freud, in realtà non crediamo mai alla nostra morte, perché ci pensiamo sopravvissuti a fianco del nostro cadavere. Di fatto, di fronte alla crisi reale della fine delle risorse, del mondo, dell'umanità stessa vediamo proliferare una sequela di immagini apocalittiche che ci accompagnano a una tematizzazione della fine ma, al contempo, proprio per la loro ambivalenza, fungono quasi da rimozione e da schermo. Non sappiamo concepire questa fine senza spettatore e, di conseguenza, non sappiamo razionalizzarla fino in fondo.
Dovremmo quindi uscire da questo circolo vizioso, razionalizzando la fine, portando il pensiero alle sue estreme conseguenze?
La fine è sempre una fine finita, è sempre una fine di qualcosa. Finisce qualcosa e ne inizia un'altra. Solo che nella nostra cultura, abbiamo “mondanizzato” l'idea di infinito, trasformandolo in un sottoprodotto ideologico del denaro, inteso come meccanismo e ingranaggio che fa funzionare un'economia capitalistica che si basa – oggi lo diciamo apertamente, ma era implicito già ai tempi di Adam Smith – sull'idea di crescita infinita.

Roma, giugno 2016
Tiziana Fabi/Afr/Getty Images
Il capitalismo è stata una grandiosa partita a poker con continui rilanci. Ora non è più possibile rilanciare, è il momento di passare la mano perché la partita si sta per chiudere. Non possiamo rimanere nel cerchio fantasmatico della crisi, perché questa non è una crisi.
Se hanno ragione Karl Polanyi e Serge Latouche, che vedono la logica della crescita come implicita nell'essenza dell'economico, allora non ha però alcun senso sostituire una buona economia a una cattiva economia, o una buona crescita a una cattiva crescita. Si tratterebbe, assumendo in pieno la crisi, per dirla con Latouche, di «uscire dall'economia» e da quella «economizzazione del mondo» nata nel Secolo dei Lumi, contemporaneamente all'idea del Progresso.
Il capitalismo è stata una grandiosa partita a poker con continui rilanci. Ora non è più possibile rilanciare, è il momento di passare la mano perché la partita si sta per chiudere. Non possiamo rimanere nel cerchio fantasmatico della crisi, perché questa non è una crisi. Questa è una strepitosa fine d'epoca e di paradigma. Va detto che ai tempi in cui Adam Smith scriveva la sua Indagine sulla natura e le cause della ricchezza delle nazioni (1776), l'Australia, di fatto, non era ancora stata scoperta – i viaggi di del capitano Cook sono proprio di quegli anni – e la possibilità di portare a un punto di non ritorno le risorse del pianeta non era nemmeno lontanamente percepibile. Ai tempi di Smith, i limiti della terra, anche dal punto di vista geografico, non erano ancora chiari. Oggi, invece, siamo nell'epoca in cui questi limiti sono percepibili. È l'epoca nella quale un essere umano ha visto – con il primo volo orbitale (1961) o, al più tardi, col primo viaggio sulla Luna (1969) – la Terra dal di fuori e ha visto che il pianeta è finito. Questo sul piano simbolico, ma è chiaro che – conoscendo le misure della Terra e, approssimativamente, anche le risorse in essa disponibili – il sistema fondato sull'immanentizzazione dell'infinito, sulla crescita senza limiti confligge in una maniera poderosa coi limiti del mondo. Ogni volta che tentiamo di misurarci con la fine, sovrapponiamo immagini apocalittiche all'idea di fine e di finito ed entriamo in crisi.
Questo avviene anche nell'informazione?
Certamente. L'informazione ha una modalità apocalittica di presentare accadimenti e notizie. È una modalità paradossale perché mentre drammatizza la catastrofe “X”, piuttosto che la catastrofe “Y” avvicinandola, la allontana e la rimuove. Nel trionfo di un'informazione globale si produce un effetto di allontanamento.
L'informazione è un fattore di strepitosa accelerazione del sistema. L'accelerazione immessa in questo sistema è stata, però, eccessiva. Parafrasando un libro di Rüdiger Safranski, potremmo dire: quanta informazione (ossia: quanta velocità di connessione) possiamo ancora sopportare?
La velocità e l'accelerazione producono l'accettazione di nessi non logici come se fossero logici. Producono, inoltre, la plausibilità di una narrazione che se seguisse il proprio ritmo non avrebbe senso. Pensiamo alla questione del montaggio, che nel cinema e nei servizi televisivi è sempre più accelerato, con nessi che si fanno sempre più sfumati rispetto alla giustificazione razionale dell'analogia. È un fatto percepibile anche a livello generazionale: pensiamo a certi anziani che fanno fatica a seguire determinati spettacoli o film che si muovono a una velocità per loro inconcepibile, mentre questi spettacoli vengono tranquillamente consumati dalle giovani generazioni. La moltiplicazione delle immagini e la sua accelerazione, sia a livello cinematografico, si a livello di comunicazione non significa una moltiplicazione delle capacità della mente. Tutt'altro, è semmai un suo asservimento. Un asservimento fondato sulla vertigine. Direi che l'informazione ha, nel nostro tempo, una modalità apocalittica di presentarsi che risulta evidente nei servizi sull'economia, la finanza, sull'andamento giornaliero della Borsa. Non vengono trasmessi fatti, opinioni, interpretazioni, ma stati d'animo e immagini. Immagini di una continua, inesorabile apocalisse culturale. Abbiamo raggiunto il limite del pianeta da parte di un sistema umano e simbolico (anche il denaro lo è) che invece lo ignora, essendo proiettato su un altro sistema, del tutto virtuale. Calato nell'immanenza, questo sistema diventa catastrofico. La veggenza di questo limite è fondamentale.
La si può ottenere coltivando e non rimuovendo il pensiero simbolico?
Diciamo di più: il produttivismo che sta sotto l'idea di crescita infinita – intesa come produzione, nel senso di moltiplicazione quantitativa anche di beni materiali – va sostituito con un nuovo oggetto del lavoro. Il lavoro, costruito dentro il tratto delle crescita infinita, è lavoro inteso come produzione per rimuovere l'idea della propria morte. Una morte a cui non crediamo ritenendoci semplici spettatori della fine. Questa morte solipsistica e questa idea di crescita infinita devono essere sostituiti da una concezione del lavoro che è presente in maniera quanto meno accennata nella forma che il lavoro ha assunto nelle civiltà tradizionali. Lavoro che è certo produzione dell'oggetto, ma carica di senso, non fine a se stessa. Questo fare è un fare immediatamente comunicativo perché anche quando produce il manufatto è insieme una forma di cura. Quando lavori a un oggetto, lavori per chi lo userà, hai quindi cura di lui. L'artigianato è un produrre, ma è un produrre che sta all'interno di quelle che potremmo chiamare nella maniera più vasta le attività della cura. La cura – prendersi cura dell'altro, prendersi cura del mondo, prendersi cura di un mondo che occorre “aggiustare” non solo sostituire con un oggetto nuovo e pronto al consumo – significa essenzialmente inserire il lavoro in un progetto comunicativo fondamentale.
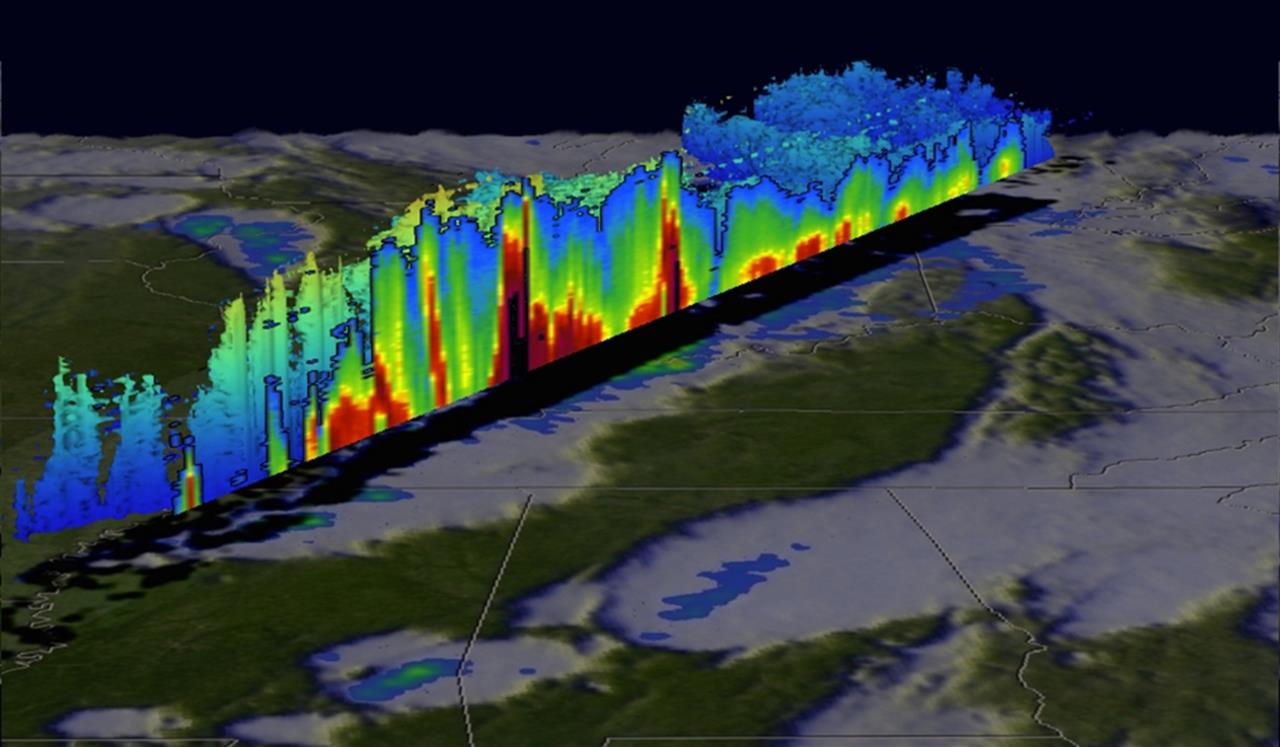
L'artigianato è un produrre, ma è un produrre che sta all'interno di quelle che potremmo chiamare nella maniera più vasta le attività della cura. La cura – prendersi cura dell'altro, prendersi cura del mondo, prendersi cura di un mondo che occorre “aggiustare” non solo sostituire con un oggetto nuovo e pronto al consumo – significa essenzialmente inserire il lavoro in un progetto comunicativo fondamentale.
Non come oggi, dove la tristezza del non lavoro e della disoccupazione è tristezza dell'isolamento e del non comunicare. Cento lavoratori in una fabbrica parlano, discutono, sono un corpo sociale che può anche protestare e reagire. Un milione di disoccupati sparsi per tutto il Paese non riescono a comunicare come quei cento lavoratori. La disoccupazione e il non lavoro contemporaneo generano malinconia, atomismo sociale, noia, abbandono, scarsa cura degli altri e, di conseguenza, pessima cura di sé.
Le risorse simboliche sono state consumate anche in questo ambito, rendendo impossibile o quasi quella “disoccupazione creativa” di cui parlava Ivan Illich…
Certamente, anche perché queste risorse simboliche sono state accantonate da quella trasformazione del simbolico – inteso come momento comunicativo e creativo, espressivo e artistico – in quella parte del tempo libero ludico di una realtà che invece è seria, molto seria. È un altri aspetto di quella frattura che si è venuta a creare nella nostra mentalità e nella nostra epoca tra l'artistico e il simbolico come momenti di lusso e di eccesso, quando in realtà sono fondamentali. Sono quelli su cui si regge il tempo.
La fine di tutte le cose
Torna la domanda che Kant poneva, in uno scritto risalente all'ultima fase della sua vita, Das Ende aller Dinge: perché gli uomini si aspettano la fine di tutte le cose? Che cosa li spinge a giocare con l'estremo, su quella soglia dove il pensiero incontra il suo limite e, prigioniero della vertigine e del paradosso, arretra un istante prima di affondare…
Se noi immaginiamo la fine di tutte le cose – e Immanuel Kant lo scrive a chiare lettere – arriviamo a una specie di aporia del pensiero. Il pensiero è sempre temporale, come concatenazione, e ci risulta difficile elaborare concettualmente l'immagine di un pensiero estremo che si blocchi alla fine del tempo. Si tratta quindi di un'immagine che accogliamo, che ci rassicura e viene in qualche modo sovrapposta a una voragine vertiginosa che comporterebbe una perdita di pensiero. Di fronte a questo dispositivo, le immagini apocalittiche in cui viviamo evocano la vertigine, la fine, il disastro, l'abbandono. Ma una seconda voce fuori campo ci dice: rassicurati, perché se vedi questo, se vedi quello che sta accadendo vuol dire che la cosa è superata. È vero che qui ci dibattiamo – ed è la difficoltà della nostra epoca – tra la difficoltà di una comunicazione dell'immagine che ha prerogative ambivalenti e la necessità di recuperare – proprio in chiave critica, facendo in modo che si sia noi a controllare le immagini, e non viceversa – il pensiero discorsivo. Recuperare il pensiero discorsivo, ovvero la parola.
La grande frattura tra immagine e parola è una frattura temporale. In un certo senso, questa frattura ha reso possibile quella «morte del prossimo» che è, forse, uno dei tratti più acuti e paradossali della crisi attuale.
Nell'immediatezza, tanto l'immagine è illusoria e potente nella pretesa di avvicinarci alle cose quanto la parola, che pure distanzia, distanziando avvicina. È un movimento contraddittorio: l'immagine della catastrofe ci viene portata davanti agli occhi, ma ci vincola alla situazione di spettatori non coinvolti. Questa possibilità di non coinvolgimento, dischiude un allontanamento progressivo. La parola è invece distanza – pensiamo a una conversazione al telefono – ma è al tempo stesso evocazione di un vincolo emotivo e di partecipazione attiva (parliamo e ascoltiamo) forte. L'ascolto e la parola creano una distanza che tende alla comunità, mentre la comunicazione dell'immagine che si spaccia come villaggio globale sta in realtà creando una distanza e, in certi casi persino un deserto.
La globalizzazione ha prodotto una sorta di indifferenza sistemica. Qualcosa che si approssima a quel regno della mobilitazione totale, di cui parlava Ernst Jünger in un suo acuminato e acuto saggio del 1930. Nel '30, con tono ancora tragico, da spettatore partecipato, Jünger poteva infatti scrivere che nell'era della totale Mobilmachung ogni uomo intuisce «con un senso di sgomento e di ebbrezza che non c'è un solo atomo che non sia al lavoro e che questo processo delirante è, in profondità, il nostro stesso destino». Oggi, potremmo declinare questa analisi anche ai processi di globalizzazione dove ogni parte di noi, ogni «atomo» per dirla con lo scrittore tedesco, sembra partecipare a un progetto infinito di cui non riesce a cogliere tratti, profilo e direzione di marcia…
Uno degli aspetti più deleteri della globalizzazione è proprio questa distanza. Forse la verità più profonda sul processo di globalizzazione l'ha detta, in maniera ovviamente letteraria, Honoré de Balzac. In Père Goriot, Balzac fa formulare a uno dei suoi personaggi il celebre “Apologo del mandarino cinese”. Cosa faresti, chiede Rastignac all'amico Bianchon, se ti venisse proposto in cambio di un'ingente guadagno, forse la maggiore delle ricchezze possibili di provocare con la sola forza del pensiero la morte di un mandarino cinese? Potresti ucciderlo, afferma Rastignac, senza che tu ne sia responsabile se non di fronte alla tua coscienza, poiché nessuno lo vedrà. Quello che Rastignac pone come sfida morale – provocherai la morte di un altro individuo senza averne la diretta e chiara responsabilità se non nel tuo animo – è progressivamente diventato il legame modello della cosiddetta globalizzazione. Partecipiamo tutti dell'economia del globo, ma i nostri rapporti commerciali, per quanto sempre più intensificati, sono all'insegna dell'interesse. E che cos'altro è l'interesse se non ciò che afferma che, se non rilevo una immediata relazione tra la morte di qualcuno e un'azione moralmente turpe, allora non sono responsabile? Se uccido “visibilmente” qualcuno, la condanna morale funziona ancora. Ma se affamo un intero paese in base a una complesso meccanismo finanziario di derivati, in questo caso la logica del mandarino cinese di balzachiana memoria è perfettamente operante. Non solo, nella globalizzazione a differenza dell'Apologo di Balzac, io non so nemmeno che sto uccidendo qualcuno. Semplicemente consumo, mangio, parlo, lavoro. O magari mi diverto.

Umanità del simbolo
La parola “crisi” deriva dal greco krísis, i cui significati si possono riassumere attorno a tre nuclei semantici. Dalla krísis come “separazione”, alla krísis come “giudizio”, giungendo alla krísis come “evento”. La modernità ha concepito la crisi come evento perfetto, come Apocalisse… Una lettura non solo economica, ma anche simbolica della crisi appare quanto mai necessaria…
Bisogna ricordare a una certa concezione idealistica della cultura le sue basi materiali. Le idee, rammentiamolo, sono al contempo la struttura materiale e la struttura simbolica – due aspetti non separabili – del nostro mondo. C'è un'integrazione continua tra forme di vita e comportamenti intesi come corpi che agiscono e interagiscono tra di loro. Questa è la storia. E nella storia noi vediamo che l'uomo non ha mai conservato per troppo tempo il medesimo sistema economico e il medesimo sistema simbolico. L'attuale crisi è, reciprocamente, crisi del sistema economico e crisi del sistema simbolico. O si rimane nella crisi a tempo indeterminato o se ne esce. La prima ipotesi è ovviamente un azzardo, visto il potenziale tecno-scientifico distruttivo che l'uomo ha nelle sue mani. Rischiamo che questa crisi sia realmente la fine di tutte le cose, ma non dal punto di vista di un senso, bensì di un non-senso casuale, una catastrofe senza senso.
C'è un'altra ipotesi?
L'altra ipotesi è l'uscita dalla crisi costruendo un nuovo modello di attività simbolica e di convivenza non basato più sull'azzardo capitalistico, ma sulla razionalizzazione della fine e sulla sua comprensione. “Comprensione della fine” significa “comprensione dell'altro”, poiché la fine vuol dire anche fine di me stesso che mi mette in contatto con l'altro. Se non fossimo individui finiti, non potremmo mai incontrare l'altro. L'individuo infinito è un folle, è la follia dell'Unico di cui scriveva Max Stirner. Oggi viviamo in un delirio dell'unico e in un sistema dove vige quel famoso aforisma di Hume secondo il quale «piuttosto che farmi male all'unghia del mignolo, perisca il mondo intero». Siamo di fronte a un egoismo potentissimo, esteso su scala globale.
Questo egoismo pone un'unica alternativa a sé, il deserto, la desertificazione del mondo…
Il capitalismo si regge sulla possibilità che ci sia uno spazio – quello delle decisioni economiche – in cui non si intravede immediatamente chi può trarre un vantaggio o uno svantaggio. Si regge, in sostanza, su una non previsione degli esiti delle transazioni. Questa non previsione è aumentata vertiginosamente col crescere della complessità del sistema ma, soprattutto, col fatto che la figura vincente della razionalità è una figura automatizzata. L'idea dell'automatismo è stata inserita all'interno della logica razionale e così perseguiamo un pensiero che, in realtà, ci fa arrivare a delle conclusioni automatiche. Non a caso, la vecchia questione dell'intelligenza artificiale si declina, oggi, nella forma di computer sempre più potenti, in grado di calcolare con rapidità e, quindi, di presentare delle sequenze che restringono lo spazio aleatorio della decisione umana. Già durante l'Illuminismo, ci si chiedeva cosa sarebbe rimasto, dopo che tutto fosse stato scoperto. Sarebbe rimasta la noia. È una visione profetica, perché già allora si stabiliva una asincronia tra lo sviluppo tecnologico e uno sviluppo che potremmo chiamare politico-morale. Questo era valido all'inizio, ha visto trionfante questa visione nel Novecento, ma ora siamo arrivati alla fine di una parabola. Al culmine di questa parabola, la tecnica è riuscita a diventare estremamente seducente quando presentava grandi vantaggi con costi minimi. La scoperta del fuoco o della ruota hanno portato vantaggi tecnologici altissimi, ma i costi erano limitati o nulli. Anche la scoperta della penicillina rientra in una casistica del genere. Le grandi scoperte, fino all'inizio del Novecento, hanno richiesto poco più che i mezzi di sussistenza dello scienziato.
L'individuo infinito è un folle. Oggi viviamo in un delirio dell'unico e in un sistema dove vige quel famoso aforisma di Hume secondo il quale «piuttosto che farmi male all'unghia del mignolo, perisca il mondo intero». Siamo di fronte a un egoismo potentissimo, esteso su scala globale.
Questo fino alle soglie della postmodernità ma oggi in questa postmodernità sia tuttI imbrigliati, scienziati inclusi…
Oggi le scoperte tecnologiche sono costosissime e, spesso, hanno una serie di controindicazioni pericolosissime. Per fare una scoperta, oggi, si richiedono sempre più risorse e i risultati di questa scoperta sono sempre più circoscritti. Succede, allora, che forse anche su questa parabola della tecnologia si è raggiunto un rapporto critico tra costi e benefici che è al limite della sostenibilità. Se anche vi fosse la possibilità di scoprire cose mirabolanti, non avremmo probabilmente la capacità di sostenerle visti i costi eccessivi. Sono trent'anni, giusto per fare un esempio, che nel campo della ricerca biomedica si annunciano mirabolanti scoperte che debelleranno non si sa cosa. Poi, al netto delle dichiarazioni propagandistiche, i risultati scarseggiano. Si tengono alte le aspettative, ci si procura un ottimo ufficio stampa, si impiegano fior di risorse ma poi si tace sui risultati…
Così, detto in altri termini, non si può andare avanti…
La mia impressione è che si sia raggiunto un limite sistemico. E questo va detto, perché oggi una delle forme in cui si declina il discorso della crescita infinita è anche questo: spostare su un piano di sviluppo della conoscenza una logica che altrove ha già mostrato i propri limiti. Questo spinge certi uomini di scienza, che anno dopo anno sono sempre meno preparati culturalmente, a mostrare tutta la loro supponenza di fronte all'attività simbolico immaginativa. Abbiamo recentemente assistito a una polemica tra Piergiorgio Odifreddi e Umberto Eco sul rapporto tra cultura scientifica e cultura umanistica. Secondo Odifreddi, la cultura umanistica sarebbe un insieme di finzioni e, inebriandoci di finzioni, finiremmo per dimenticare i fatti, custoditi dalla scienza. Purtroppo per lui, Odifreddi non riconosce il fatto che tutta la cultura scientifica nasce da un grande comparto simbolico, è, a suo modo, una finzione (si pensi al grado di finzione necessario per produrre le condizioni artificiali di un esperimento). D'altra parte, vivere nei simboli non significa “inebriamento” ma la normale definizione antropologica dell'uomo come animale simbolico. Noi non abbiamo un rapporto diretto con il mondo, ma l'abbiamo sempre attraverso dei simboli che ci consentono di dare forma e di chiamare “mondo” il mondo. Altrimenti avremmo sempre e soltanto una serie di percezioni disarticolate. Quella della scienza assolutamente benefica che migliora, al posto di Dio, la condizione della vita nel mondo è una favoletta e uno scienziato degno di questo nome deve saperlo. Non può cadere in una sorta di teologia rovesciata.
Anche questo è il sintomo di un problema complesso, dove la crisi investe ogni sapere, lo erode da dentro e esplode in vari punti del sistema… È come se questa crisi richiedesse, per dirla con Günther Anders, solo uomini senza mondo…
Negli scorsi anni, siamo stati “allietati” da dibattiti filosofici a mezzo stampa su quello che è stato chiamato “nuovo realismo”. Non sarà, mi domando, la terza ondata di quel positivismo sterile che accompagna a ondate ogni grande crisi economica del capitalismo moderno? Grande crisi degli anni Trenta e Quaranta dell'Ottocento: nascita del Positivismo. Grande Crisi del '29: nascita del Neopositivismo logico del Circolo di Vienna. Crisi che stiamo vivendo: Nuovo realismo. È fin troppo evidente, per uno storico della filosofia e del pensiero, osservare il ritorno ciclico di persone che anche in buona fede ripercorrono le stesse strade. Con gli stessi esiti.

Belgio
Siese Veenstra/Afp/Getty Images
Del breve periodo
È un altro espetto di quell'attitudine inerziale del pensiero attraverso la quale, oramai, la nostra società funziona. In questo senso, Bernard Stiegler ha potuto parlare di una crisi generata da una "vision court-termiste". Da una mancanza di pensiero…
La visione a breve è evidente soprattutto nella diseconomia dell'attuale economia. Questo è un buon esempio di crisi. Perché nel momento in cui abbiamo assodato che le risorse del pianeta sono limitate, consumarne in eccesso significa consegnarsi a una deriva suicida. È finita l'illusione di un’economia che, negando la sua stessa etimologia, non tenga conto dell'oikos, della “casa” in cui abitiamo. L'economia, così come viene studiata nelle università, è un clamoroso inganno che spaccia per “scienza” la matematizzazione dei processi di arricchimento di alcuni singoli attori economici, senza alcuna considerazione complessiva e sistemica che non sia l’astrazione generalizzante di questi punti di vista particolari! Altro che breve termine. Gli economisti formati dalle nostre scuole, fatte le dovute eccezioni, rischiano di essere solo dei manutengoli del sistema che producono retoricamente una specie di consenso al cosiddetto sistema economico, ma che economico, nel vero senso della parola, che apparenta intimamente, oserei dire strutturalmente, l’eco-nomia con l’eco-logia, non è affatto.
Come uscirne, dunque, se non con uno sforzo del pensiero? Uscire dalla crisi esercitando la critica…
È evidente che il pensiero è, fondamentalmente, qualcosa che ci capita. Ognuno di noi, quando pensa, non pensa “adesso mi metto a pensare”. Semplicemente, ci capitano dei pensieri. In questo accadere il pensiero non è qualcosa di autistico. Non si può cercare, come fanno i filosofi analitici, di professionalizzare all'estremo il pensiero. La filosofia non è “filosofia della filosofia”. La filosofia è filosofia del mondo. Ciò che fa pensare filosoficamente non è la lettura di un altro filosofo, quanto l'impatto delle cose stesse. L'impatto della vita. La filosofia è un evento. Anche quando leggi un libro, la filosofia inizia quando quel libro lo rimetti in movimento. E proprio in questo può rappresentare un tentativo di pensare la crisi, di assumerla, di uscirne. La cura, il pensiero e l'attività simbolica sono le uniche vie attraverso le quali l'essere umano, a differenza del normale “produttore-consumatore”, riesce a produrre di più nel momento in cui consuma. Un libro rimane un libro, anche se letto da dieci, cento persone. Persone che vi aggiungono un sovrappiù di pensiero. La grande sfida aperta dalla crisi è che, dinanzi allo schianto della produzione materiale del pianeta, l'uomo ha la possibilità di trasferirsi proprio in quel campo simbolico che è il suo oikos, la sua “casa” più propria. Qui può trovare un conforto nello sviluppo infinito dell'interpretazione e del pensiero.
Pensare è già agire, in questo senso?
Noi viviamo in un mondo che, con sforzi di pensiero tutto sommato limitati, ma comuni, può imbrigliare la sua enorme capacità distruttiva e, al tempo stesso, liberare nella voglia di infinito una grande capacità creativa. Questa è la svolta necessaria alla nostra epoca. Una svolta critica, perché la filosofia è quel dire contro che non consiste tanto nel “dire la verità”, quanto, da Socrate in poi, nel dire ciò che la verità non è. Non c'è critica e, di conseguenza, non c'è vera autonomia dell'individuo, senza quest'esser contro, senza un'opposizione, senza una protesta. La verità, come concetto, sorge come positività del contenuto dalla funzione della negatività (il “dire di no”). Sorge proprio da quella contrapposizione, da un mondo così come è a un mondo come potrebbe essere. È il poter essere, la parola della verità.
L'ospite
Andrea Tagliapietra, nato a Venezia nel 1962, è professore ordinario di Storia della filosofia alla facoltà di filosofia dell’Università Vita-Salute del San Raffaele di Milano, dove insegna Storia della filosofia moderna e contemporanea, Ermeneutica filosofica e Storia delle idee. Con Sebastiano Ghisu è direttore del "Giornale critico di storia delle idee" (www.giornalecritico.it). Tra i suoi libri: Il velo di Alcesti. La filosofia e il teatro della morte, Feltrinelli, Milano 1997; Filosofia della bugia. Figure della menzogna nella storia del pensiero occidentale, Bruno Mondadori, Milano 2001; La virtù crudele. Filosofia e storia della sincerità, Einaudi, Torino 2003; La forza del pudore. Per una filosofia dell'inconfessabile, Rizzoli, Milano 2006; La metafora dello specchio. Lineamenti per una storia simbolica, Bollati-Boringhieri, Torino 2008; Il dono del filosofo. Sul gesto originario della filosofia, Einaudi, Torino 2009; Icone della fine. Immagini apocalittiche, filmografie, miti, Il Mulino, Bologna 2010.
In copertina: Berlino, 5 agosto 2016. Immagine di Clemens Bilan/Afp/Getty Images
17 centesimi al giorno sono troppi?
Poco più di un euro a settimana, un caffè al bar o forse meno. 60 euro l’anno per tutti i contenuti di VITA, gli articoli online senza pubblicità, i magazine, le newsletter, i podcast, le infografiche e i libri digitali. Ma soprattutto per aiutarci a raccontare il sociale con sempre maggiore forza e incisività.

