Cultura
Ricordare per dimenticare: il genocidio degli armeni
Riconoscendo il genocidio perpetrato nei confronti degli armeni, Joe Biden ha riaperto una questione, più che chiuderla: fu uno sterminio pianificato e silenzioso che non doveva lasciare testimoni. Tra i metodi impiegati per rendere “invisibile” la deportazione c’era quello di ammassare i deportati su convogli ferroviari tenuti a debita distanza da tutti i grossi centri abitati, per evitare che deportati e “depotanti” fossero visti e ricordati
di Marco Dotti

Quasi dovesse servire da mappa esistenziale, preciso come è nelle indicazioni geografiche e nei resoconti, il diario di Vahram Altounian costituisce un eccezionale documento su ciò che gli armeni definiscono il “Grande Male”.
Con queste parole – “Metz Yeghern” – le comunità armene della diaspora nominano infatti la deportazione e il genocidio – parola fino a poche ore fa "impronunciabile" sul piano delle relazioni internazionali – condotti contro il loro popolo dal governo dei Giovani Turchi, andato al potere dopo il crollo dell’Impero Ottomano. Uno sterminio pianificato e silenzioso che non doveva lasciare testimoni e in qualche modo ambiva a portare a termine l’opera di persecuzione iniziata, sul finire del XIX secolo, dai funzionari dell’Impero con la complicità di bande criminali.
In un appunto al testo, presentato al lettore col titolo Ricordare per dimenticare (Donzelli, Roma 2007, con il commento della figlia di Vahram, Janine Altounian) si sottolinea che fra i metodi impiegati dalle autorità per rendere “invisibile” la deportazione c’era quello di ammassare i deportati su convogli ferroviari tenuti a debita distanza da tutti i grossi centri abitati, per evitare che deportati e “depotanti” fossero visti e ricordati.
La pratica, che ricorda tristemente i “treni neri” nazisti, è indicativa della volontà di non lasciare tracce di sé e dietro di sé, non inscriversi in alcuna memoria e negarsi persino come genocidio. A questo scopo, le forze dell’ordine addette alla deportazioni venivano reclutate fra irregolari, per lo più malviventi comuni, e la morte quando non inflitta direttamente doveva essere “favorita con mezzi segreti”, ossia con marce da un punto all’altro dell’Anatolia, marce estenuanti che miravano a sfiancare i profughi, presto falcidiati dagli stenti, dal tifo e dalla dissenteria.
Vahram Altounian scrisse il suo diario nel 1921, probabilmente in seguito all’ondata emotiva seguita agli attentati che il quindici marzo e il sei dicembre di quell’anno, a Berlino e a Roma, costarono la vita all’ex ministro degli Interni turco Talat e al gran visir Said Halim; ma il quaderno rimase per molti anni chiuso in un cassetto confinato fra i segreti personali e di famiglia. Un documento da dimenticare, anche se mai dimenticato fino in fondo.
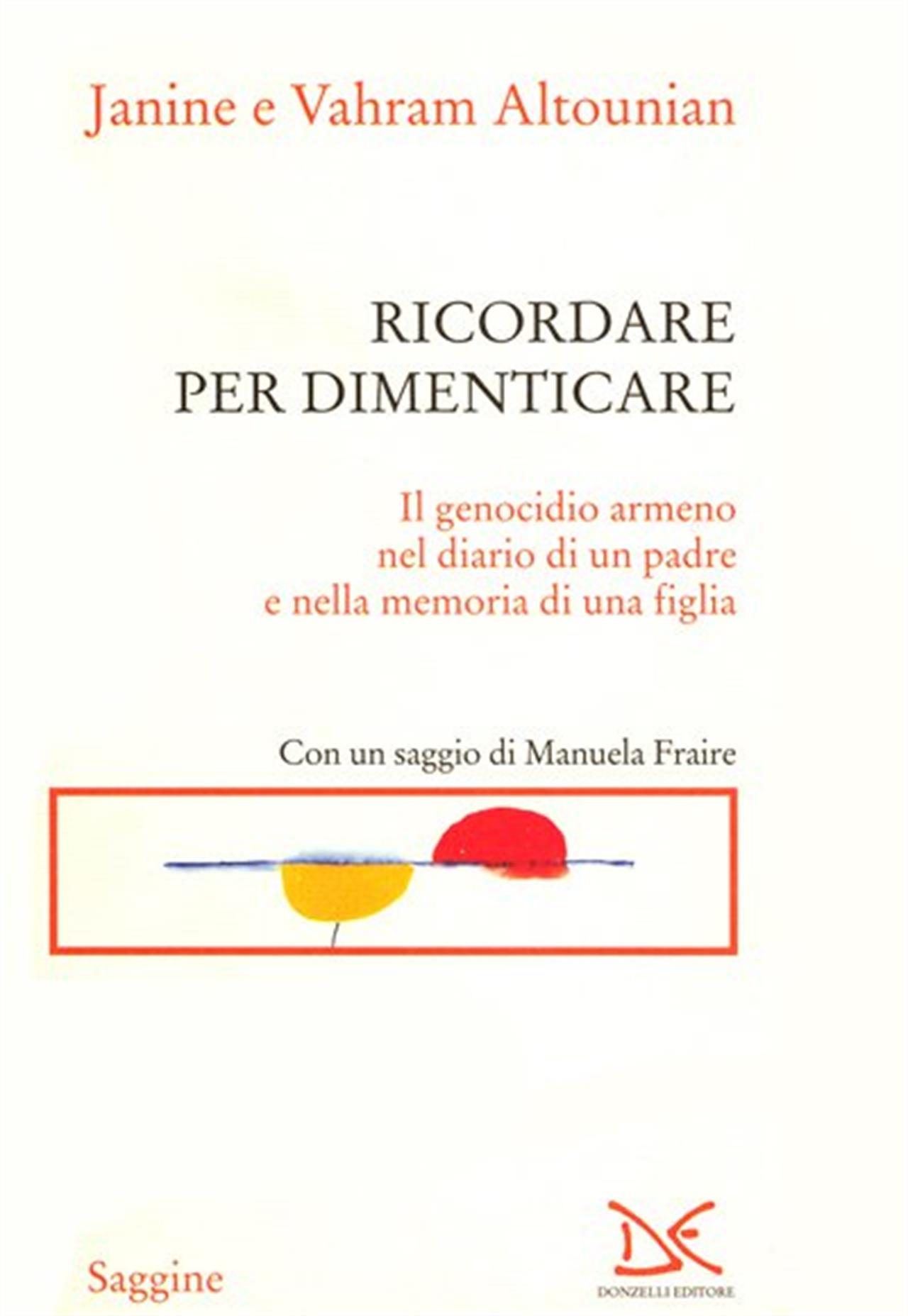
Nel 1981 un commando dell’organizzazione “Alala” fece irruzione nel consolato turco di Parigi prendendo venticinque ostaggi, fu solo allora che Janine Altounian trovò la forza per affrontare «la vergogna per me costituita dal dare alle stampe il diario di deportazione di mio padre». Senza la disperata determinazione di quel gesto terroristico «che alcuni armeni vivi osavano scandalosamente ostentare – scrive ancora Altounian nella sua premessa – avrei vissuto quella decisione come una profanazione dei morti».
Nel suo scritto Terrore e oblio. La letteratura come mezzo per salvare la figura del padre, tradotto da Rossana Rossanda, Janine Altounian affronta quella “memoria bianca” e quell’oblio apparente che, nel passaggio delle generazioni, pur nel silenzio ha permesso la trasmissione di una forma di ricordo “inconscio della catastrofe”. Invertendo la prospettiva ricorrente che vede nell’oblio un atto mancato, Janine Altounian – psicoanalista e traduttrice francese delle opere di Freud – si propone di interrogare l’oblio del dramma armeno e quel senso di spavento e terrore che sorgono “a posteriori” e sono ben identificati dal termine “apres-coup” come atto perfettamente riuscito anche se, avverte l’autrice, “riuscito in extremis”. Non rimozione, quindi, ma oblio dove le memorie e i ricordi dei sopravvissuti non rimandano a uno spostamento da “una data area dell’inconscio a un’altra”, ma “proprio al ‘non luogo’ del terrore, dal quale il soggetto si assenta per sopravvivere”.

Indice di questo atteggiamento è lo stesso clima di clandestinità, determinato forse dal sentimento di essere sopravvissuti a qualcosa di indecente da cui preservare madri e figli, in cui nei loro racconti i protagonisti confinano l’esperienza del genocidio.
Per Altounian si tratta quindi – ed è questo uno dei temi affrontati anche da Manuela Fraire nel suo interessante contributo al volume – di continuare il lavoro del padre, proprio là dove il padre si era fermato, per sottrarre la vergogna a uno spazio privato e riconsegnarla al mondo. In un percorso che va dalle riflessioni di Michel de Certeau sulla scrittura come rito capace di “esorcizzare la morte iscrivendola nel discorso”, fino alle considerazioni sulla morte del padre raccolte nel Primo uomo da Albert Camus o sul suicidio della madre descritto da Peter Handke in Infelicità senza desideri, Janine Altounian affronta quell’inestricabile paradosso secondo cui soltanto ciò che «è stato "localizzato" da qualche parte nel mondo dei vivi può essere rimosso».
Un paradosso tuttora presente nelle vicende e nei traumi degli armeni costretti a vivere in un mondo dove le coordinate della loro storia non sembrano esistere e, di conseguenza, anche il genocidio del 1915 non risulta “inscritto” in alcuno spazio della memoria occidentale. Localizzare e scrivere – suggerisce Altounian – sono allora le necessarie premesse per ricordare e, forse, persino per dimenticare.
Vuoi accedere all'archivio di VITA?
Con un abbonamento annuale potrai sfogliare più di 50 numeri del nostro magazine, da gennaio 2020 ad oggi: ogni numero una storia sempre attuale. Oltre a tutti i contenuti extra come le newsletter tematiche, i podcast, le infografiche e gli approfondimenti.
