Economia
Ieri Csr e social impact. Oggi serve un passo in più, dal purpose all’azione
In questo periodo di crisi da coronavirus, sono tanti i modelli e le prassi spazzate via. In particolare in relazione a consumi e impresa. Se prima della pandemia si parlava di impact finance oggi si è cominciato a parlare di purpose-first economy e quarto settore. Per questo riveste una grande importanza la pubblicazione in Italia del libro “Brand Activism. Dal purpose all'azione” di Philip Kotler, padre del marketing moderno, scritto a quattro mani con Christian Sarkar e con la prefazione di Paolo Iabichino, direttore creativo e fondatore dell’Osservatorio Civic Brands, con Ipsos Italia, da anni tra le firme di Vita.it

Il 2019 è stato l’anno d’oro per la finanza a impatto sociale. I temi legati alla sostenibilità sono diventati centrali nella coscienza collettiva e nel sistema economico e finanziario tradizionale: la famosa lettera di Larry Fink, amministratore delegato di Blackrock, il manifesto della Business Roundtable e la prima pagina del Financial Times hanno sancito la necessità di ripensare il capitalismo, hanno segnato la definitiva consacrazione dell’imperativo dell’impatto. Poi c'è stato il Covid19 e la crisi ha svelato un dibattito profondamente cambiato. In particolare con il documento sottoscritto da 14 top manager di grandi imprese internazionali, tra cui Philips, Danone, L'Oréal e MasterCard, con cui hanno annunciano il proprio impegno per la purpose-first economy, cioè per un'economia che mette lo scopo al primo posto. «Un fatto che mi ha profondamente colpito per un motivo semplice», racconta Iabicus, al secolo Paolo Iabichino, fondatore dell’Osservatorio Civic Brands, con Ipsos Italia e firma di Vita.it, «avevo appena finito di scrivere la prefazione all'ultima fatica editoriale di Philip Kotler, padre del marketing moderno, che finalmente, dopo due anni viene portato in Italia da Hoepli, e che titola proprio “Brand Activism. Dal purpose all'azione”».
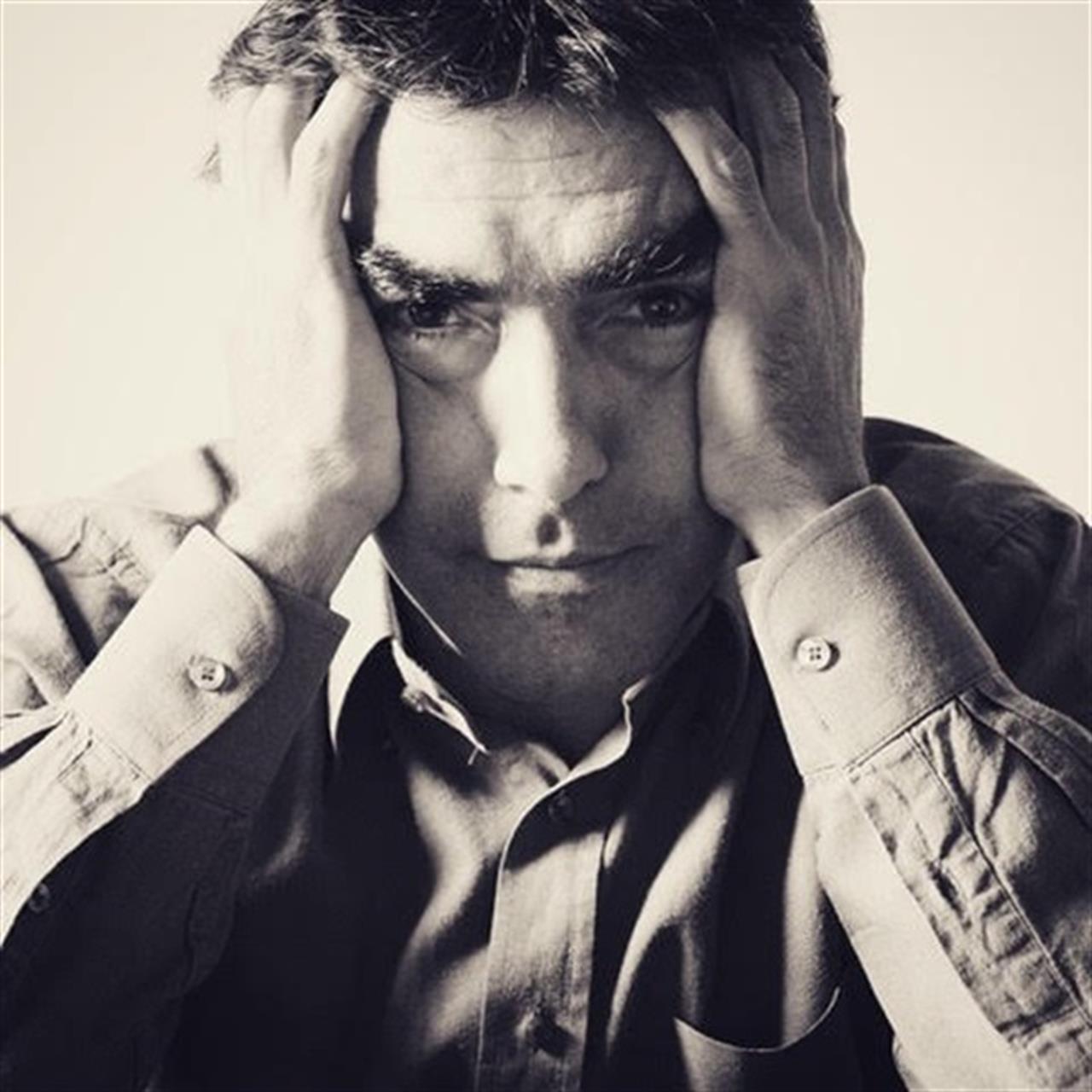
Il primo dato saliente è che questo libro, che in Italia Hoepli ha portato l'11 settembre scorso, in realtà Kotler e Sarkar lo hanno scritto nel 2018. Questo significa che la variabile Covid19 in realtà non basta a spiegare il fenomeno…
Come ho scritto nella prefazione il libro è nato prima della pandemia che ha stravolto il mondo e la stesura del mio contributo è avvenuta durante. La speranza è che le due cose insieme possano aiutare un dopo che mentre parliamo non ha ancora trovato le sue nuove coordinate. In questo senso il coronavirus ha solo, in qualche modo, accelerato qualcosa che c'era già, qualcosa che covava sotto la cenere.
Ma di cosa si tratta? Nella prefazione identifica un cambiamento generazionale dei consumatori, dai millenials alla generazione Z. Che tipo di mutazioni sono avvenute?
Provo a vestire i panni del sociologo. I consumi reagiscono a degli spostamenti di paradigmi che stanno nella società e in ultima istanza muovono i comportamenti delle aziende che a loro volta reagiscono ai trend dei consumatori. Fino a qualche tempo fa marketing, creatività, media e advertising hanno reagito a quelli che erano tendenze a cui più o meno repentinamente si adeguavano. Più di recente invece, un fenomeno che possiamo far risalire intorno al 2015, le tendenza a carattere sociale, che una volta facevano riferimento alla Csr, hanno cominciato a prendere piede in maniera più decisa rispetto alle altre. Il motivo è stata la spinta dal basso di nuove generazioni che hanno cominciato a vedere i consumi in un modo diverso. Sono diventate molto urgenti le istanze ambientali che hanno tirato la volata della prima ora. Cui sono seguite quelle legate alla gender equality, alle discriminazioni e alle diseguaglianze. Il motivo credo che sia riconducibili anche al contesto in cui questi giovani sono cresciuti. Siamo il mondo della crisi climatica, dei lavoretti della Gig Economy e dell'elezioni di Donald Trump alla Casa Bianca. Tutto questo ha generato uno tsunami, una piena cui le aziende hanno potuto solo reagire e risarcire. Una cosa però deve essere chiara…
Quale?
Non siamo di fronte a una tendenza o a un trend. Questa è una rivoluzione quantica ed è destinata a durare. Non si torna più indietro. Le regole del gioco sono cambiate per sempre.
Non siamo di fronte a una tendenza o a un trend. Questa è una rivoluzione quantica ed è destinata a durare
Per questo il libro di Kotler è molto importante: perché è il momento in cui stiamo passando dalle parole ai fatti, dal purpose all'azione…
Il grande equivoco dell'ultimo periodo era che bastasse un buon racconto che manifestasse una dichiarazione di intenti “buonisti”. C'è stato un eccesso di paternalismo comunicativo dove le marche si sono arrogate il diritto di manifestare il proprio impegno per un mondo migliore ma questo impegno rimaneva chiuso nei brand manifesto. Abbiamo assistito a una proliferazione enorme di questi strumenti, per altro bellissimi, ma che erano firmati da aziende che poi non prendevano alcun impegno nei confronti del pianeta, della comunità e della collettività. La pandemia ha scoperchiato il tappo della retorica. È come se il virus avesse svelato il trucco di questa retorica fine a sé stessa. Il risultato è stato che il mercato ha cominciato a premiare quelle marche che affianco a alla retorica facevano azioni concrete. Questo è il brand activism puro. L'esempio più lampante è Patagonia. Ma bisogna chiarire che non è necessario essere politicizzati per assumere un impegno civico. La cosa importante è che non deve trattarsi di una promessa pubblicitaria ma di un vero patto con i consumatori, affinché il proprio stare sul mercato lasci un'impronta civica, di qualunque tipo essa sia. Le istanze sociali sono tantissime. Le aziende devono solo capire quale di queste sia compatibile con il proprio côté narrativo.
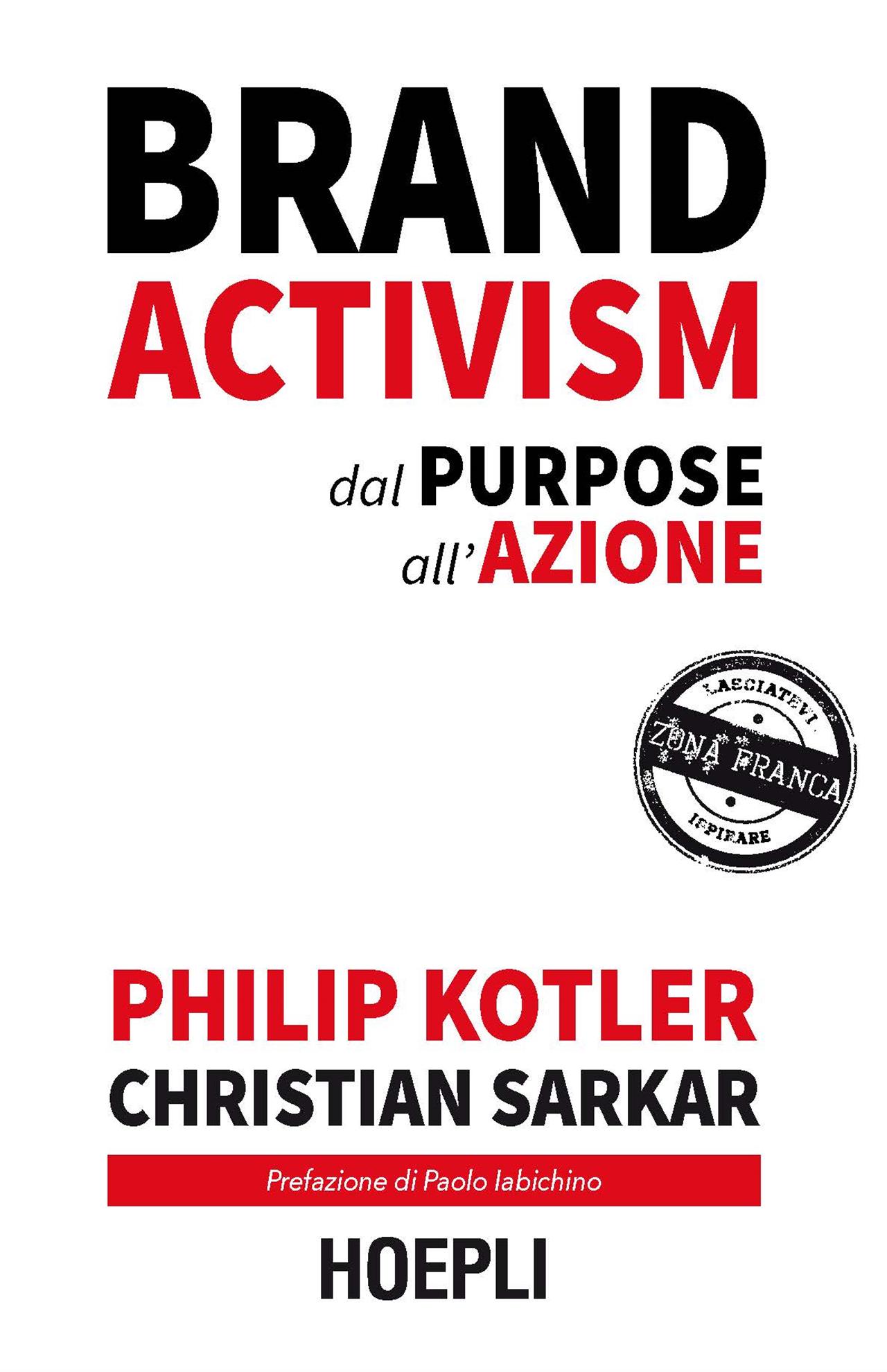
Sembrano delle istruzioni all'uso. Per questo, nella prefazione al libro, parla di modus operandi per identificare il cuore del pensiero di Kotler?
Il motivo per cui ho accettato di scrivere la prefazione al libro è proprio perché Kotler stabilisce un sistema operativo. Mette chiunque in condizione di definire il proprio purpose e far discendere da questa definizione un piano d'azione. Siamo lontani dal marketing delle grandi dichiarazioni e più vicino all'azione concreta.
Un tempo si diceva, circa la csr, che doveva permeare tutti i ruoli e gli ambiti aziendali. Lo stesso oggi si dice del marketing. Ma siamo sicuri che quello di cui parliamo si chiami csr o marketing?
Non è un caso che nella mia esperienza operativa di creativo su questi temi difficilmente l'incarico mi sia arrivato dal marketing. Molto più spesso è arrivati dai CEO, dagli AD, dai fondatori o dalla HR. Insomma dalla prima linea. Quindi laddove l'imput arriva dal vertice significa che c'è un commitment molto forte che riesce ad integrare operativamente le diverse funzioni aziendali. È interessante che quando l'incarico arriva da chi guida il progetto diventa realmente operativo rispetto addirittura al modello di business. Parti per scrivere un manifesto che poi diventa un'azione la quale poi irradia e impatta tutta la filiera.
Il grande equivoco era che bastasse un buon racconto che manifestasse una dichiarazione di intenti “buonisti”
Quindi ad essere centrali sono i leader e il ruolo competitivo del brand activism…
Non c'è dubbio. Ricordiamoci sempre che il marketing ha allenato generazione di professionisti alla creazione di valore per gli stakeholders interni. La rivoluzione copernicana è che diventa moneta la reputazione. Nella brand equity di chiunque, grandi e piccole e forse anche pubbliche amministrazioni, entra come asset e valore economico tangibile l'impegno nei confronti della società. Quella che si chiama impronta civica.
Qui però nasce un dilemma: non c'è il rischio che tutto si risolva in una grande operazione di comunicazione?
No, non è più possibile. Perché il consumatore ormai è molto attento a certe cose. L'unico rischio è nelle mani di chi decide di giocare questa partita. Le furbizie e malizie narrative vengono smascherate immediatamente. Addirittura anche l'azione oggi non è detto che sia sufficiente perché il consumatore la valuta. In questo il virus, come dicevo, è stato dirimente.
Ma questa transizione rivoluzionaria si può lasciare nelle mani dei leaders, più o meno illuminati che siano?
No, non c'è dubbio. Va monitorata e sorvegliata. Da chi ha maggiore sensibilità e competenze su questi temi e può aiutare CEO e marketer a muoversi nel modo più consono. Il confine è veramente sottile tra l'onestà intellettuale di un'azione e la percezione della stessa azione. C'è bisogno di antenne che in qualche modo tengano il punto. Penso ad esempio agli heritage di marca. Spesso nei miei progetti faccio un lavoro di archivio per risalire alle origine fondative dell'impresa e alla sua vocazione storica. Ecco perché abbiamo costruito l'Osservatorio Civic Brands. E in questo senso vanno lette anche le attività di realtà come Tiresia di Mario Calderini, o il voto con il portafogli di Next Economia e del prof. Leonardo Becchetti o ancora a Music Innovation Hub di Andrea Rapaccini. Tutte realtà “antenna” che lavorano, con tagli differenti, nella stessa direzione.
Le imprese hanno un'ossessione per il business plan. Il punto non deve essere come faremo i soldi ma come cambieremo il mondo
Delle sentinelle chiamate a fare un lavoro culturale dunque?
Come comunicatore sono molto attento ai termini e sentinella ha un retrogusto negativo (ride). Preferisco parlare di “radar”. Il lavoro è di pensiero. Siamo in un momento di riflessione e per questo il libro di Kotler arriva al momento giusto. Ci trova in mezzo a un guado e per uscirne abbiamo bisogno di modelli di riferimento e orizzonti cui guardare.
Cosa consiglierebbe ai giovani che oggi provano a fare impresa?
Quello che cerco di trasmettere a tutte le start up che mi capita di incontrare. Quando li accompagno in un percorso spesso mi accorgo di un'ossessione per il business plan. È giusto che ci sia, per ovvi motivi. Ma alla fine diventa l'unica istanza sul tavolo. Il punto non deve essere come faremo i soldi ma come cambieremo il mondo. Vincono oggi le start up che migliorano la vita delle persone.
Si può usare la Carta docente per abbonarsi a VITA?
Certo che sì! Basta emettere un buono sulla piattaforma del ministero del valore dell’abbonamento che si intende acquistare (1 anno carta + digital a 80€ o 1 anno digital a 60€) e inviarci il codice del buono a abbonamenti@vita.it
