Economia
Impresa sociale, quegli abbagli su distribuzione degli utili e agevolazioni fiscali
L'intervento di Roberto Randazzo, avvocato specializzato in diritto degli enti non profit
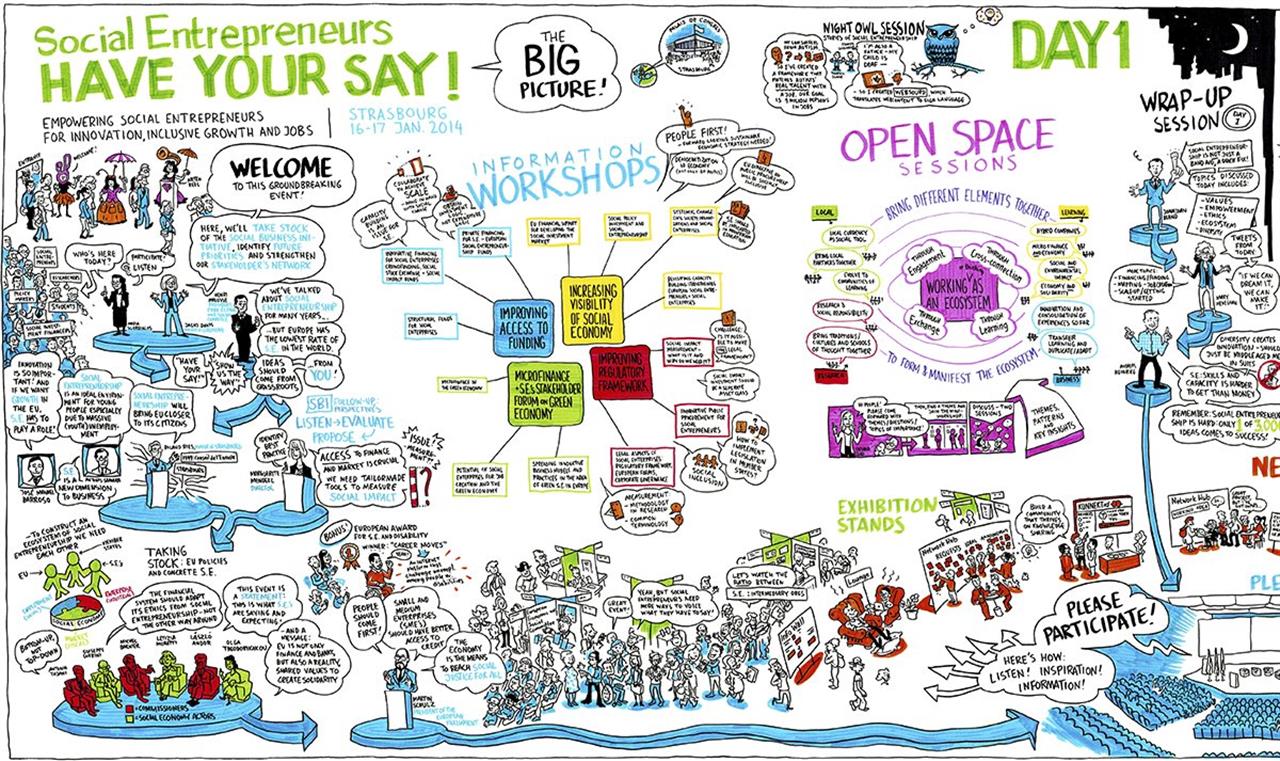
I commenti letti nelle ultime settimane (vedi correlate) impongono una riflessione sulla diatriba che sta animando il percorso di riforma del Terzo Settore riguardo alla disciplina dell’impresa sociale ed alla possibilità che quest’ultima possa distribuire, limitatamente, i propri utili. Cercherò di essere schematico.
Primo. Una premessa, sicuramente scontata: il Terzo Settore non è un insieme di “bravi ragazzi” animati solo da tanta buona volontà, ma è composto da soggetti che cubano il 5/6% (più o meno) del nostro PIL; inoltre, è vero che esso è formato da anime diverse e molto distanti tra loro – sia sotto l’aspetto valoriale che organizzativo – ma è chiaro che la valorizzazione della dimensione economicamente produttiva proviene da imprese sociali che operano sul mercato. La premessa porta ad una semplice constatazione: c’è un Terzo Settore con una matrice prettamente volontaristica ed uno con una vocazione imprenditoriale. Forse, sarebbe utile cominciare a tenere ben separati questi due mondi, sia nelle considerazioni socio-filosofiche sia nelle valutazione di carattere tecnico-legislativo, anziché continuare a metterli indiscriminatamente sotto lo stesso cappello.
Quindi? Il divieto di distribuzione degli utili è solo uno degli elementi che caratterizza gli enti del Terzo Settore e, a dire il vero, non è più così tanto solido, ormai anche nel nostro ordinamento.
Secondo. Prendiamola lunga e accantoniamo per un momento quest’ultimo passaggio. Riavvolgiamo il nastro al 1942, all’entrata in vigore del Codice Civile. La disciplina del nostro codice racconta (non uso il passato, perché la disciplina, come noto, è ancora in vigore) di enti senza scopo di lucro che non possono svolgere alcun tipo di attività economica e, men che meno, attività imprenditoriale. Solo dopo parecchio tempo, intorno alla metà degli anni Sessanta, dottrina e giurisprudenza hanno iniziato a far breccia in questa granitica posizione, per dare avvio ad un procedimento di interpretazione e di adattamento del diritto al contesto sociale di allora (inutile dirlo, ben diverso da quello che conosceva il legislatore del 1942), vale a dire aprendo al concetto di esercizio di attività economica da parte degli enti senza scopo di lucro. Se così non fosse stato, oggi, dovremmo applicare con rigore le disposizioni codicistiche. Che Terzo Settore sarebbe se non si potessero produrre e scambiare beni o servizi? Oggi, la stessa Agenzia delle Entrate conferma come il Terzo Settore sia alimentato, per il 47,3% da attività commerciali, evidenziando allo stesso tempo come “(…) la realtà ha ampiamente superato la norma civilistica sdoganando definitivamente l’idea che gli enti non profit si qualifichino per la finalità non lucrativa e non per l’attività svolta che può anche essere commerciale”.
E dunque? Il diritto cambia, sia attraverso la sua interpretazione ed applicazione, grazie a dottrina e giurisprudenza, sia per mezzo del legislatore che ha il compito di mettere ordine ai nuovi equilibri che la società, evolvendosi, produce.
Terzo. Non è arroccandosi su posizioni ideologiche e preconcette che si contribuisce ad innovare il sistema. Occorre prendere atto che nella prassi si stanno già diffondendo società commerciali con una finalità sociale che – fuori da un perimetro normativo definito – realizzano delle attività negli ambiti tipici del Terzo Settore, limitando – statutariamente – la distribuzione dei dividendi. Opzione non semplice da porre in essere, visto che la burocrazia in Italia rabbrividisce e si chiude a riccio ogniqualvolta si trovi dinnanzi a qualcosa di diverso da “acceso-spento”, “bianco-nero”, che però ha già portato alla costituzione di alcune società commerciali low profit. E’ curioso scoprire che alcuni pionieri abbiano deciso di aggirare l’ostacolo (ma non la legge) per concretizzare una scelta imprenditoriale che, facendo ricorso alle opzioni contemplate nel tradizionale alveo del Terzo Settore, non sarebbe stato possibile disciplinare.
Ampliamo l’orizzonte (anche se la cosa non piace, non è mai piaciuta, ai più tradizionalisti del nostro Terzo Settore) e guardiamo ad altri ordinamenti. Molti di essi hanno già legittimato queste nuove forme di social business; è il caso delle Community Interest Companies (CIC) nel Regno Unito oppure delle Low Limited Liabilities Companies (L3C) nel sistema USA, dove si sono anche diffuse le più innovative B Corporation, tutti enti che hanno la possibilità di distribuire dividendi con modalità e vincoli ben definiti. Addirittura, considerata l’attrattività che questo nuovo sistema di svolgere attività imprenditoriale nell’ambito sociale sta sviluppando in maniera uniforme a livello globale (per quanto sia possibile, tenendo conto delle specificità dei singoli ordinamenti), accade che già si sia concretizzato il caso di qualche imprenditore italiano che abbia conseguito, negli Stati Uniti, la qualificazione di B Corp.
Pertanto? Siamo di fronte ad un passaggio epocale che coinvolge il social business, portando con sé una nuova visione della remunerazione, calmierata o “cappata”, del capitale investito in attività imprenditoriali di carattere sociale. Se vogliamo chiuderci a riccio, respingendo velleitariamente questa tendenza, possiamo farlo, forti delle nostre certezze e tradizioni millenarie. Peccato che il mondo vada in una direzione opposta. E in più, un paradosso: il dibattito dottrinario che a partire dagli Anni Sessanta portò all’evoluzione accennata nel “punto Secondo”, aprendo ai nostri enti senza scopo di lucro la porta dell’esercizio dell’attività economica, prese le mosse dalla interpretazione che già nel mondo anglosassone si dava a questo settore, importando dal loro sistema il principio del “non distribution constraint”. Quella volta gli anglosassoni ci diedero una mano…
Quarto. Le parole sono importanti e mai, come nel dibattito intorno alla distribuzione limitata degli utili, sono state usate cosi male: la riforma, ad esempio, non intende in alcun modo equiparare le imprese sociali alle società commerciali tout court, ma prevede come la remunerazione del capitale sociale e la ripartizione degli utili, debba essere assoggettata a condizioni e limiti massimi, assicurando, in ogni caso, la prevalente destinazione delle risorse dell’impresa alle finalità istituzionali dell’ente, in analogia ai meccanismi che si applicano alle cooperative a mutualità prevalente. Quindi, non si dovrebbe fare altro che applicare alle imprese sociali il meccanismo previsto dall’articolo 2514 del Codice Civile, secondo cui le cooperative a mutualità prevalente non possono distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato. Questa disposizione si estende alle cooperative sociali, queste considerate – addirittura – dal D.Lgs 460/97 quali “Onlus di Diritto”. Ebbene sì, un veicolo societario, costituito in forma cooperativistica, che può distribuire limitatamente dividendi ed ha accesso a tutte le agevolazioni di natura tributaria previste dalla normativa di settore per le Onlus. E questo non da ieri!
Questo esempio, solo per dimostrare come in alcuni casi investimenti, distribuzione (limitata) degli utili ed agevolazioni fiscali, possa coesistere in maniera equilibrata senza che si scatenino battaglie ideologiche fra favorevoli e contrari. Se questo principio vale per le cooperative sociali, perché non lo si può applicare, mutatis mutandis, anche alle imprese sociali? Come se non bastasse, più recentemente il legislatore ha inserito un altro “bug” nel roccioso sistema posto a difesa del “non distribution constraint” (bello dirlo all’inglese, visto che adesso questo principio viene utilizzato per contrastare l’innovazione …). La disciplina sulle start up innovative a vocazione sociale, infatti, ha definitivamente scardinato la tenuta stagna di quel concetto, e senza che nessuno (quasi) se ne accorgesse! Forse è utile rammentarlo anche qui, le start up innovative a vocazione sociale, enti costituiti in forma societaria che svolgono le proprie attività nei medesimi settori indicati dal D.Lgs 155/06 sono sottoposte ad un divieto assoluto di distribuzione di utili per i primi 48 mesi, dopodiché non esiste più alcun limite, è possibile distribuire quanto si vuole.
Quindi? Quindi, bisognerebbe conoscere bene il perimetro normativo che delimita il Terzo Settore e, magari, provare a leggere nell’evoluzione storica degli enti senza scopo di lucro del nostro ordinamento, i passaggi che ne hanno mutato non solo la pelle, ma anche la sostanza. Se poi ci perdiamo per strada e dimentichiamo i precedenti che, da un punto di vista puramente tecnico, contengono già i principi dell’innovazione (tanto osteggiati nel dibattito degli ultimi anni interno al Terzo Settore e, oggi in alcune posizioni emerse nel dibattito parlamentare), allora il dubbio della mancanza di obiettività, sorge spontaneo.
Quinto. Accanto al tema della distribuzione dei dividendi, viene inoltre sbandierato come uno spauracchio quello delle agevolazioni fiscali, quasi fossero due aspetti intimamente connessi da affrontare insieme. Anche in questo caso temo che in molti abbiano preso un abbaglio, lo ribadisco, le parole sono importanti. Nel testo della riforma da nessuna parte si parla di agevolazioni fiscali per le imprese sociali, in quanto la proposta parla esclusivamente di “misure agevolative volte a favorire gli investimenti di capitale”; quindi, al massimo, si tratta di incentivi per gli investitori che intendo rischiare il proprio denaro, investendolo (a rischio, occorre ribadirlo) in attività che producono un beneficio per la collettività.
Detto diversamente, l’impresa sociale rimarrebbe un veicolo fiscalmente neutro e soggetto alla disciplina tributaria prevista per la categoria degli enti che ne assumono la qualifica. Al riguardo vale la pena chiedersi se tutti coloro che oggi si schierano contro qualsiasi misura agevolativa in favore degli investitori, siano stati informati del fatto che, la norma sulle start up innovative a vocazione sociale (la Legge 17 Dicembre 2012 n.221), preveda una deduzione/detrazione sugli investimenti effettuati nel capitale sociale. Quindi, una società commerciale con un vincolo di distribuzione degli utili solo temporaneo può legittimamente “restituire” ai propri investitori una percentuale fino al 26% del capitale investito, un’impresa sociale con un vincolo di destinazione perpetuo ed un tetto alla distribuzione degli utili, no.
Quindi? Non mi pare che lo sbandierato spauracchio delle agevolazione fiscali possa avere attinenza con quanto delineato nel testo della riforma. Ancora una volta, sarebbe bastato analizzare con attenzione le disposizioni vigenti in materia per comprendere come le critiche mosse al connubio distribuzione degli utili/vantaggi fiscali dell’impresa sociale, fosse del tutto infondata.
Probabilmente, se lo stesso Terzo Settore non si fosse perso in anni di sterili dibattiti e di ostracismo per una nuova impresa sociale che remunera il capitale investito, a quest’ora il percorso di revisione della fallimentare norma del 2006 sarebbe stato compiuto. Adesso, invece, il Terzo Settore deve compattarsi – magari turandosi il naso – per spiegare le proprie ragioni e necessità di riforma a chi si oppone alla sua evoluzione in chiave imprenditoriale con argomentazioni che sembrano più andare dietro all’onda emotiva dei fatti di cronaca che non essere costruite su un’adeguata conoscenza dei profili normativi e della loro prassi applicativa in questa materia.
Prima di essere contro – il profitto, gli utili, le attività commerciali, gli investimenti, l’impresa – bisognerebbe forse guardare meglio dentro alle cose. Come urlava il protagonista di un vecchio film di Nanni Moretti, chi parla male, pensa male e vive male. Le parole sono importanti.
Si può usare la Carta docente per abbonarsi a VITA?
Certo che sì! Basta emettere un buono sulla piattaforma del ministero del valore dell’abbonamento che si intende acquistare (1 anno carta + digital a 80€ o 1 anno digital a 60€) e inviarci il codice del buono a abbonamenti@vita.it
